Rinascita Americana di Giovanna Pancheri è uno di quei libri rari che hanno il potere di aprire le porte su un mondo apparentemente patinato, distruggendo ogni nostro giudizio e pregiudizio. Frutto del suo lavoro come corrispondente on the road, Rinascita Americana ci porta assieme alla sua autrice nei meandri dell’America inesplorata, fuori dalle metropoli megalitiche di New York e Los Angeles, per capire la mentalità di un popolo che ha perso il proprio sogno americano. Ciò che ci viene mostrato è un mosaico di malumori e contraddizioni sapientemente utilizzati da Donald Trump per la sua elezione nel 2016. Un popolo silenzioso, “l’Altra America” fatta di dipendenza da oppiacei, razzismo alla ribalta e nuovi poveri. Ma c’è anche speranza, quella di una nuova rinascita per sconfiggere le piaghe più profonde della società americana e tornare a sognare l’american dream. Forse la lettura dell’anno, il libro giusto per capire gli Stati Uniti con un occhio critico.

Abbiamo raggiunto Giovanna Pancheri per farle alcune domande su Rinascita Americana e sui primi mesi della presidenza Biden.
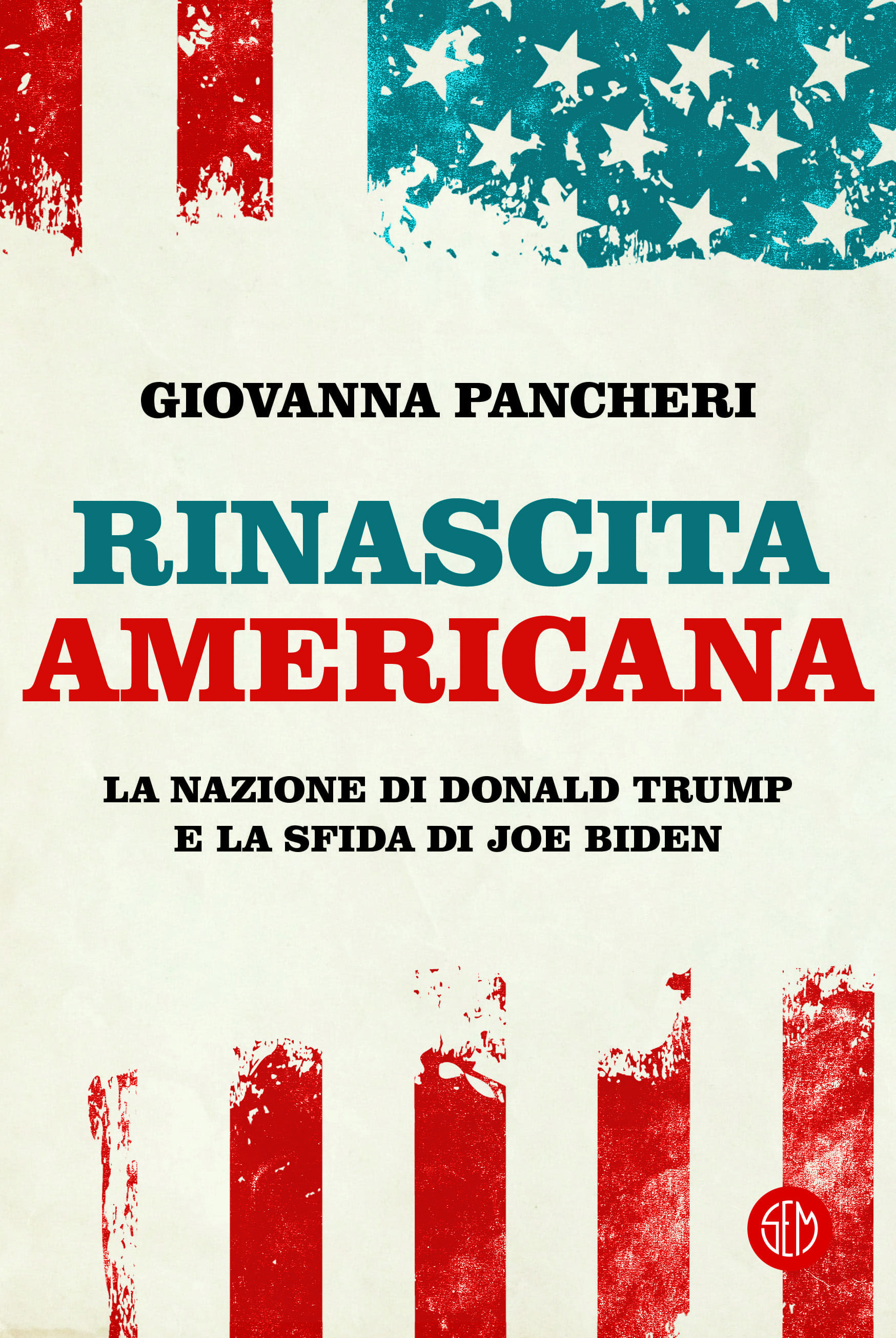
Come nasce l’idea di Rinascita Americana e perché ha scelto questo titolo?
“Sono arrivata negli Stati Uniti nel 2016 per seguire le convention dei due partiti e, come racconto nel mio libro, già dal discorso inaugurale di Trump del 20 gennaio 2017 si aveva la percezione che la sua sarebbe stata una presidenza di rottura con il passato. Per questo, decisi a mia volta di fare un cambiamento rispetto al classico lavoro del corrispondente e di seguire le vicende della presidenza Trump non solo da New York, ma viaggiando per il paese. Durante questa corrispondenza itinerante le testimonianze raccolte sono state talmente tante e così particolari che non avrei potuto inserirle tutte nei miei servizi televisivi per Sky. Ho così deciso di farne un racconto dei miei 4 anni in America. Quando ho iniziato la prima stesura del libro il covid ancora non era esploso, ma alla fine è diventato predominante all’interno del racconto. Giunta al titolo ho pensato che la pandemia sia stata percepita ovunque come un conflitto. Quindi mi è tornato in mente un discorso molto famoso di Abramo Lincoln alla conclusione della battaglia di Gettysburg. Al culmine della Guerra di Secessione, Lincoln parlò da leader facendo un appello all’unità per portare avanti un processo di rinascita assieme, nord e sud. Questa sua volontà di andare verso un’unione reale anche con chi la pensava in modo totalmente diverso, secondo me è il segreto per uscire da una crisi profonda come quella che stiamo vivendo. Non è un titolo legato alla vittoria di Joe Biden, ma un auspicio per gli Stati Uniti”.

Ciò che emerge nel suo libro è l’esistenza di due Americhe: “l’America” che tutti conosciamo e “l’altra America” che lei racconta. Perché i media non parlano mai dell’America rurale e periferica e come mai è stata così importante nelle ultime tornate elettorali?
“Se ne parla poco perché non è l’America leader. Pensiamo alla stessa pandemia: alla fine, da tutto il mondo abbiamo guardato proprio gli americani per una soluzione. Perché l’America è questo: avanguardia, visione, grande sviluppo e progresso. Ma, il paese che va a votare è molto variegato, composto anche dai fly-over states, gli stati più centrali e meno attrattivi. A me affascinava il fatto che nel 2016 fosse stata quest’altra America a far vincere Trump ed a sorprendere i media mainstream. Trump ha avuto la grande abilità di capire che c’era una parte d’America che non aveva trovato in Obama le risposte alla crisi del 2008 ma, soprattutto, che ad un tratto non era stata più in grado di realizzare il sogno americano: avere una bella casa, mandare i figli al college, comprarsi un’auto. Con la crisi del 2008, soprattutto per la classe media bianca e la classe operaia, questo sogno non è stato più così semplice da raggiungere. Per questo motivo, molti americani si sono sentiti ai margini della società, dei perdenti (il peggiore insulto che si può fare ad un americano). Trump ha abilmente ribaltato questa mentalità nel 2016, spiegando questi elettori che non era colpa loro se non erano più in grado di vivere il sogno americano, ma dovevano incolpare fattori esterni, come gli immigrati o le regole sulla tutela dell’ambiente. Questo ha avuto indubbiamente un grandissimo impatto sulle elezioni. Ma, nei suoi quattro anni, e soprattutto durante la pandemia, Trump ha perso questa capacità di ascoltare i timori e le paure della pancia dell’America. Questa mancanza di sensibilità è dovuta all’allontanamento dei collaboratori più critici ma attenti. Decidendo di cancellare queste voci dissonanti è rimasto sordo di fronte ad una questione che è stata dirimente nelle ultime elezioni”.

Come è stato viaggiare nell’altra America come corrispondente e giornalista italiana? Come è stata accolta dalle persone?
“Gli americani sono molto curiosi e questa è la loro forza. Sono un popolo che non si vergogna di non sapere, per cui l’ignoranza non è qualcosa di negativo ma una base per imparare cose nuove. E quindi devo ammettere che durante i miei viaggi c’era sempre molta curiosità nei miei confronti. Sono andata spesso in luoghi dimenticati e particolari, dove magari le persone non soltanto non avevano un passaporto ma non erano neanche mai usciti dal loro stato. Mi è capitato di parlare con adulti che mi chiedevano dove fosse l’Italia o quale lingua si parlasse in Europa, ma sempre con grande curiosità. Invece, per quanto riguarda la parte più radicale dei sostenitori di Trump, è stato interessante ascoltare alcune delle loro reazioni che, soprattutto nell’ultimo anno, erano generalmente anti-media. Comunque, non conoscendo il mio network, conversare con loro è stato più semplice. Ma quello che mi ha colpito molto, e lo racconto anche nel libro, è come durante la prima ondata di covid molti mi chiedevano perché fossi in America, dato che Trump aveva posto un ban sui visti dall’Europa. Quindi, fra i supporter di Trump c’era la percezione che io fossi una “straniera” e quando li incontravo dovevo spiegare i motivi del mio soggiorno negli USA”.

Il “Fattore C”, il coronavirus, che lei ha inserito alla fine di ogni capitoli del suo libro, come ha cambiato la percezione degli americani su un tema come la sanità e perché è stato cruciale nella sconfitta di Donald Trump?
“Ho deciso di chiudere ogni capitolo del mio libro con un paragrafo dedicato al coronavirus, il “Fattore C”, per mostrare il suo impatto sulla società americana. In generale, il covid ha cambiato la percezione che gli americani hanno del ruolo dello stato nelle loro vite e, per quella che sappiamo essere la mentalità americana, questa è stata una rivoluzione non da poco. Durante questa crisi, le persone si sono rese conto di voler una maggiore presenza dello stato nelle loro vite e quindi maggior welfare e sanità pubblica. Non dimentichiamoci che adesso negli Stati Uniti tutti i test e tutti i vaccini sono offerti gratuitamente alla popolazione. Purtroppo, però, soprattutto nelle comunità latine ed afroamericane più povere esiste un pregiudizio nei confronti del sistema sanitario che li ha portati a recarsi solo tardivamente nelle strutture ospedaliere. Ciò accade perché negli ospedali, come mi hanno raccontato alcuni medici, esistono pregiudizi duri a morire contro le minoranze, considerate sempre sprovviste di copertura sanitaria e quindi da trattare frettolosamente. Quindi, a pagare le conseguenze di questo sistema è stata la parte più povera della popolazione. Invece, la sconfitta di Donald Trump è stata decretata quando ha perso l’occasione di mostrare empatia durante la pandemia. Pensiamo al caso di Boris Johnson, che prima di ammalarsi aveva fatto dichiarazioni shock sull’immunità di gregge. Dopo il suo ricovero è tornato e ha preso molto seriamente questa faccenda, tant’è che adesso la Gran Bretagna è molto avanti con le vaccinazioni. Al contrario, Trump si è ammalato ed ha avuto la possibilità di capire la gravità della malattia e l’incertezza in cui può gettare le persone, specialmente quelle senza copertura sanitaria. Invece, una volta guarito ha continuato ad essere scettico nei confronti della scienza, promuovendo soluzioni improbabili. Insomma, non un comportamento da leader. Per me questo mancato cambio di passo è stato uno dei momenti che lo ha condannato alla sconfitta”.

Nei suoi viaggi ha parlato con persone come Thomas Robb del KKK, Richard Spencer dell’Alt-Right e Jared Taylor della destra estrema. Come mai in America esistono ancora idee suprematiste e razziste così marcate? Crede che il processo Minnesota v. Derek Chauvin per la morte di George Floyd, possa rappresentare una svolta?
“Credo che la vicenda George Floyd sia stata un momento di svolta. Nel capitolo del mio libro dedicato al problema del razzismo, il paragrafo conclusivo non analizza soltanto il “Fattore C” ma anche il “Fattore G” (George Floyd). Questo perché il suo omicidio è avvenuto in un momento in cui il paese era già sotto particolare pressione per la pandemia. Non dimentichiamo che il movimento Black Lives Matter è nato negli anni di Obama ma la vicenda George Floyd lo ha risvegliato, facendolo tornare per le strade con una consapevolezza diversa. Anzitutto il movimento si è aperto anche ad altre comunità, come quella bianca, ed ha visto una grandissima partecipazione giovanile. In più, con le elezioni imminenti, c’è stata la necessità di spingere la comunità alle urne, molto più di quanto fatto nel 2016. Una grande mobilitazione traducibile con “piazze piene ed urne piene”, una volta tanto. In più a mio parere, la morte di George Floyd ha riacceso i riflettori su un problema endemico. Per questo, credo che una sentenza contro Derek Chauvin, dopo decenni di violenze impunite da parte di membri delle forze dell’ordine, possa innescare un cambiamento anche nelle regole di selezione del corpo di polizia.

Avendo girato tanto per il paese, credo che il razzismo sia veramente una questione non risolta per molte ragioni. Per esempio, in Germania c’è una tale memoria storica che addirittura dalla scuola elementare vengono organizzate gite nei campi di concentramento, così da spiegare ai bambini ciò che è successo e le responsabilità del popolo tedesco. Nel sud, invece, fino a pochi anni fa esistevano ancora scuole “just white” perché, per portare avanti un’unione “non è rotta ma ancora incompleta”, per citare Amanda Gorman, si è chiuso un occhio su determinate discriminazioni. Così, la questione razziale è stata tralasciata dall’istruzione, impedendo la formazione di una memoria storica forte. Questa scelta si paga con un razzismo ancora presente che, a mio parere, soffre anche del vulnus del Primo Emendamento, come ho avuto modo di constatare intervistando i personaggi che hai citato. Non essendoci mai stati forti movimenti liberticidi in America, si è meno coscienti dei rischi di una certa propaganda d’odio, che può sfociare in azioni violente. Da questo punto di vista gli europei hanno sviluppato anticorpi che permettono loro di considerare inaccettabili alcune esternazioni, sia dal punto di vista morale che legale. Negli Stati Uniti invece questo processo non c’è mai stato e, nel nome della libertà assoluta, quando hai un presidente che non censura in modo netto le dichiarazioni d’odio, queste si propagano generando violenza. Ciò che mi ha più colpita dell’intervista fatta a padre Robb, leader del KKK dopo David Duke, è stata la sua consapevolezza di non aver più bisogno di nascondersi. A persone del genere è consentito portare avanti le proprie tesi a viso aperto. Oltre ad essere molto grave, credo che sia una delle responsabilità maggiori della presidenza Trump che, non condannando apertamente questi messaggi, li ha legittimati, aprendo la strada alle derive del 6 gennaio”.

Biden, che nel discorso inaugurale aveva annunciato grande discontinuità, adesso guida il mondo con un piano vaccinale solido ed un piano di ripresa da 1900 miliardi. In politica estera ha annunciato un riavvicinamento agli storici alleati europei ma, in un’ultima intervista, Anthony Fauci ha dichiarato che gli USA non daranno priorità all’UE nei loro aiuti. Come valuta l’impatto di Joe Biden sulla politica interna ed estera statunitense?
“Secondo me ci sono stati cambiamenti anche radicali. È una presidenza molto più calma in cui chi fa il nostro mestiere riesce a districarsi meglio fra le notizie. Poi ci sono cambiamenti più sostanziali come il reingresso negli accordi di Parigi ma anche la grande insistenza di Biden di volersi rivolgere a tutti gli americani, nella consapevolezza di essere stato votato anche da molti repubblicani. Vi è una ritrovata volontà di portare avanti un dialogo bipartisan, consapevoli che dalla crisi se ne potrà uscire soltanto insieme. E poi, a mio parere, c’è stato anche un cambiamento interno al partito repubblicano che ha sofferto l’atteggiamento di Trump nel periodo post-elettorale. A me ha colpito molto vedere come in un sondaggio del CPAC, che ricordiamo essere l’ala più conservatrice del partito repubblicano, quella che fa riferimento a Trump, soltanto il 54% dei membri si è detto favorevole alla candidatura dell’ex presidente nel 2024. Assolutamente non il plebiscito che si aspettava. Trump ha perso molti consensi perché la solidità della democrazia è rimasto un tema inviolabile sia per i conservatori che per i democratici e questo fatto può aprire la strada ad una maggiore collaborazione bipartisan.

Con l’Europa, invece, c’è sicuramente un approccio diverso. In virtù della sua appartenenza al blocco occidentale, l’UE è sempre stata vista come il main ally da tutte le amministrazioni ed anche in questo Trump è stato un presidente di rottura. Nei suoi 4 anni da presidente, Trump ha dimostrato in modo pubblico il suo fastidio nei confronti del progetto unitario europeo ed il suo sostegno ai movimenti di rottura come la Brexit. Adesso l’approccio è cambiato, non a caso Blinken si è recato a Bruxelles fra le sue prime visite internazionali. Però questa rinnovata attenzione all’alleato europeo porta con sé anche maggiori richieste. Lo vediamo anche da come Draghi ha esplicitato in modo chiaro “da che parte stiamo” perché siamo tornati ad una logica di blocchi contrapposti, fra occidente e Cina e Russia. È un rapporto che torna ad essere quello che era in passato sebbene in un momento di crisi profonda in cui Biden sa di avere già tante sfide da affrontare al livello interno, come la vaccinazione di massa degli americani. Sicuramente dopo questa fase riceveremo degli aiuti ma il problema comunque è nostro che da europei non siamo riusciti a sviluppare un vero e proprio vaccino. BioNTech è europea ma abbiamo fatto sì che il suo vaccino fosse sviluppato da Pfizer, mentre il capo sulla ricerca vaccini di Moderna è un italiano. Insomma, l’America continua ad essere il polo di attrazione principale per chi fa ricerca a questi livelli. Speriamo che l’Europa impari qualcosa da questa crisi”.










