In questi giorni si è tornati ad evocare Srebrenica parlando dell’assedio dell’ISIS alla città di Kobane, suggerendo quindi il duplice paragone Isis – miliziani serbi genocidiari e curdi – musulmani bosniaci trucidati nella cittadina della ex Jugoslavia. E se ne potrebbe aggiungere un terzo: esercito turco – Caschi Blu dell’ONU, visto che entrambi non hanno fatto nulla.
Alla fine, nonostante le più pessimistiche previsioni, Kobane non è ancora caduta. Mentre ad intervenire in appoggio ai curdi – per ora solo con l’aviazione – è stata, as usual, l’America. Nel frattempo, però, mi ero ricordato di avere lasciato indietro un libro importante, uno dei più recensiti nel 2014 letterario italiano: sto parlando del romanzo d’esordio di Marco Magini, Come fossi solo, finalista al Premio Calvino – un punto di riferimento imprescindibile per i nuovi autori in Italia – e poi al premio Strega 2014. Un romanzo-verità ambientato a Srebrenica, appunto.
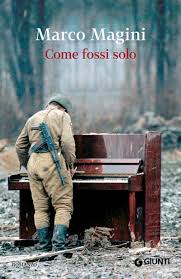 C’erano anche delle ragioni personali che mi spingevano verso questa lettura. Ad esempio, il fatto di conoscere Srebrenica, di averla visitata in un caldissimo agosto, per incontrare le socie di una cooperativa femminile, donne di diversa provenienza che avevano deciso di mettere in piedi un’attività economica beneficiando dei finanziamenti della solidarietà internazionale. In quell’occasione ero stato naturalmente al grande cimitero musulmano nel quale sono stati sepolti i resti delle vittime che si è riusciti ad identificare, all’epoca 8.372, ma nel frattempo potrebbero essere aumentate. All’ingresso del paese c’era un centro commerciale nuovo di zecca ma le facciate delle case erano ancora crivellate di proiettili e su tutto sembrava essersi posato un velo di congiura e omertà.
C’erano anche delle ragioni personali che mi spingevano verso questa lettura. Ad esempio, il fatto di conoscere Srebrenica, di averla visitata in un caldissimo agosto, per incontrare le socie di una cooperativa femminile, donne di diversa provenienza che avevano deciso di mettere in piedi un’attività economica beneficiando dei finanziamenti della solidarietà internazionale. In quell’occasione ero stato naturalmente al grande cimitero musulmano nel quale sono stati sepolti i resti delle vittime che si è riusciti ad identificare, all’epoca 8.372, ma nel frattempo potrebbero essere aumentate. All’ingresso del paese c’era un centro commerciale nuovo di zecca ma le facciate delle case erano ancora crivellate di proiettili e su tutto sembrava essersi posato un velo di congiura e omertà.
Il romanzo di Magini prova a squarciare questo velo. Lo fa usando tre voci: quella di un casco blu olandese, uno di quelli che si arresero senza combattere, consegnando le armi ai miliziani serbi guidati da Ratko Mladi─ç (non per colpa loro ma perché dall’ONU non arrivò l’ordine di prendere la difesa dei civili che si erano rifugiati in quella valletta cieca per sfuggire alla pulizia etnica, proprio su indicazione delle Nazioni Unite); quella del giudice spagnolo Romeo González; e quella di Dra┼¥en Erdemovi─ç, di Tuzla, madre croata e padre serbo, costretto dalle circostanze e dal bisogno a vestire una divisa che nel corso della dissoluzione della ex Jugoslavia cambiava, a seconda del mutare dei fronti e dei confini. Unico miliziano che si dichiarò colpevole al processo istituito dal Tribunale Penale Internazionale, all’Aja.
Con romanzi come questo, che verrà probabilmente adottato in tante scuole per il suo valore pedagogico, si corre sempre un rischio: quello di passare sopra allo specifico letterario, concentrandosi sull’argomento. In fondo Srebrenica è stato l’episodio di guerra più cruento avvenuto in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale: pensate, oltre 8.000 civili trucidati nel giro di tre giorni, a poche ore di automobile da Trieste o da Vienna, civili che avevano come unica colpa quella di essere musulmani (dovremmo ricordarcene più spesso, quando denunciamo le crudeltà dell’Islam integralista).

L’autore Marco Magini
Per la mia generazione – a differenza di quella di Magini, nato nel 1985 – Srebrenica non è un evento dimenticato o da “riscoprire”. Nel ’95 chi aveva 30 anni sapeva bene quello che stava succedendo nella ex Jugoslavia, se solo voleva sapere, ovviamente. Semmai, ricordiamo il senso di impotenza che si respirava allora, a seguire l’evolversi del conflitto sui giornali. E l’impegno generoso di tanti volontari, che partivano dall’Italia per portare soccorso alle popolazioni stremate (qualcuno pagò la sua generosità con la vita). Ricordiamo l’assedio di Sarajevo, che spinse persino un pacifista al di sopra di ogni sospetto come l’eurodeputato Alexander Langer, padre dei Verdi italiani, a sollecitare un intervento “chirurgico” per liberare la città dalla morsa dei serbi (richiesta come noto inascoltata fino a quando ad intervenire non si decise Bill Clinton). Ricordiamo la distruzione del ponte di Mostar, della biblioteca di Sarajevo, il tentativo di fare piazza pulita delle memorie, di riscrivere la storia. Ricordiamo gli stupri, i campi di concentramento, il grande dibattito quando il governo D’Alema si schierò per l’intervento militare in difesa del Kosovo, che finalmente condusse alla caduta di Milosevic, ma non alla completa risoluzione dei problemi balcanici (a tutt’oggi la Bosnia Erzegovina è più un’entità artificiale che uno stato a tutti gli effetti).
Per questi motivi, il mio accostarmi al romanzo non aveva principalmente a che fare con un bisogno di conoscenza, del tutto legittimo, invece, in uno studente di oggigiorno. E, sì, devo anche ammettere che come lettore ho messo in fila, pagina dopo pagina, anche qualche riserva. Intendiamoci, non c’è nulla nella macchina narrativa a più voci che costituisce l’ossatura del romanzo che non funzioni. Solo, ho avvertito a volte la mancanza di qualcosa di più. Magari di una provocazione esplicita, sul piano del linguaggio, o su quello della trama. Penso ad esempio a Il grande orfano, di Tierno Monénembo, altro romanzo dedicato a un genocidio, quello del Rwanda, dove l’autore sceglie di utilizzare un registro quasi picaresco, tipico di tanta narrativa africana, per colpire inaspettatamente al cuore nella parte finale (anch’essa centrata su un processo). In Magini c’è senso del ritmo, tanto quanto in una buona sceneggiatura. C’è la consapevolezza che la condanna morale, o anche giuridica, è un conto, e la volontà di comprendere i comportamenti individuali un altro, specie quando si ha a che fare con i crimini commessi a causa delle circostanze, della viltà, delle pressioni esterne, senza vero odio. Ma la prosa si concede – volutamente, immagino – pochi azzardi. E in qualche pagina questo lo si paga.
Al tempo stesso, devo dire che invece non mi hanno disturbato i presunti difetti rilevati dalle (poche) altre critiche negative collezionate dal libro, una per tutte quella riguardante il fatto che i tre protagonisti parlano grossomodo la stessa lingua (succede spessissimo, anche con i maestri, alla fine a prevalere è quasi sempre una voce sola, quella del narratore). Non mi ha disturbato nemmeno la presunta mancanza di aderenza alla realtà, innanzitutto perché, a parte qualche appunto di carattere linguistico mi sembra che l’autore si sia ben documentato. Poi perché questo è un romanzo, non un saggio, anche Truman Capote a volte inventava, ne abbiamo parlato la scorsa settimana a proposito della biografia di Plimpton.
In ogni modo, questi sono appunti di carattere letterario. Mentre il libro di Magini ha una valenza anche (inevitabilmente?) sovraletteraria, e questa è la condanna di tutti gli scrittori che si misurano con un romanzo-verità. Degli scrittori che cercano di calarsi, e ci vuole un gran coraggio, nelle menti e nei corpi di coloro che una storia, ancorché crudele come quella di Dra┼¥en (70 persone uccise in una sola giornata), l’hanno vissuta veramente, e non soltanto immaginata.
Srebrenica è stato un punto di non ritorno per la storia europea. Dopo di allora nessuno ha potuto più dirsi pacifista integrale. Dopo di allora è stato chiaro a tutti che a volte l’uso della forza è necessario, per soccorrere i più deboli.
C’è chi poi ha abusato di questo uso, naturalmente. C’è anche chi oggi tira in ballo la Bosnia e il Rwanda per giustificare gli interventi militari più spregiudicati. Ma questa, è un’altra storia.
Marco Magini, Come fossi solo, Giunti, 2014.












