Spesso in Italia, quando ci si vuole lamentare di un provvedimento, di una decisione o di un’organizzazione che si ritiene non proprio ineccepibile, si dice che le cose sono state fatte all’italiana, come sinonimo di approssimativo, raffazzonato, confusionario. Eppure, uscendo dai confini nazionali e sentendo parlare di made in Italy o semplicemente di Italian, la percezione è leggermente differente. Tutto ciò che è italiano, infatti, può essere magari bizzarro o sopra le righe, ma quasi sempre con una sfumatura positiva. Del tipo: gli italiani saranno pure un po’ matti, ma sono geniali.
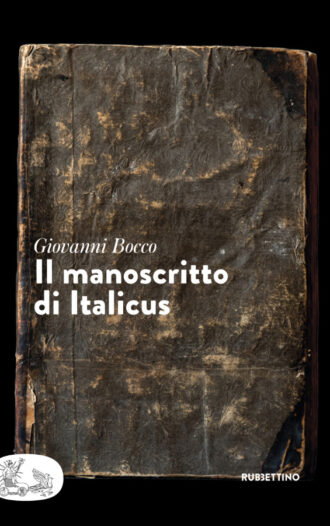 Chi non vive la quotidianità della penisola, quando pensa all’Italia non pensa alle code davanti gli uffici pubblici o alla burocrazia snervante. Piuttosto, vede l’arte, la cucina, la moda, le macchine sportive, il design, la letteratura, lo sport (e forse ora anche la musica rock), tutti ambiti in cui Italia e italiano sono sinonimi di eccellenza e unicità. Questa curiosa doppia percezione, ci mostra quanto sia più difficile del previsto definire con certezza cosa significhi essere italiano e, soprattutto, come l’espressione dell’italianità travalichi spesso i confini nazionali, declinandosi a seconda dei contesti e spesso elevandosi, pur mantenendo sempre tratti distintivi.
Chi non vive la quotidianità della penisola, quando pensa all’Italia non pensa alle code davanti gli uffici pubblici o alla burocrazia snervante. Piuttosto, vede l’arte, la cucina, la moda, le macchine sportive, il design, la letteratura, lo sport (e forse ora anche la musica rock), tutti ambiti in cui Italia e italiano sono sinonimi di eccellenza e unicità. Questa curiosa doppia percezione, ci mostra quanto sia più difficile del previsto definire con certezza cosa significhi essere italiano e, soprattutto, come l’espressione dell’italianità travalichi spesso i confini nazionali, declinandosi a seconda dei contesti e spesso elevandosi, pur mantenendo sempre tratti distintivi.
Attorno a questa idea “estesa” di Italia si sviluppa il romanzo del giornalista Giovanni Bocco, Il manoscritto di Italicus (Rubbettino, 216 pagine, 15 euro). Il protagonista della storia è Italicus, sovrano di un immaginario Regno del Ponto che, da Napoli, sogna di partire e girare il mondo per riunire tutti gli italici, quasi trecento milioni di persone che vivono, interpretano e rappresentano l’Italia a prescindere dal luogo in cui si trovano e dagli effettivi legami di sangue con il nostro Paese. Questo suo progetto è raccontato in un manoscritto che viene ritrovato da Michele, un giornalista discendente del sovrano che, al pari del lettore, cerca di comprendere l’idea alla base del concetto di civilizzazione italica.
Si può, dunque, essere italici senza essere cittadini italiani o senza necessariamente parlare italiano? Bocco, che per trent’anni è stato corrispondente dall’estero per il Tg1 e si è occupato di civilizzazione ed emigrazione italiana (realizzando sull’argomento reportage in Argentina, Australia e Stati Uniti), ci dice che è possibile, perché l’Italia è rappresentata da valori e da un particolare sentire che non hanno limiti geografici. Sono italici gli italiani, così come i loro discendenti di terza generazione, i siciliani del New England, i calabresi di Sidney e sono italici gli stranieri che per lavoro, scelta o necessità raggiungono l’Italia e decidono di restarci. Abbiamo contattato l’autore per discuterne insieme a lui del suo romanzo e delle idee che lo hanno ispirato.
Come è nata l’idea del tuo romanzo e della ricerca del manoscritto che dà avvio a tutta la vicenda che racconti?
“L’idea del manoscritto ritrovato, oltre a essere manzoniana, fa parte di una lunga tradizione. Mi è venuta in mente perché dovevo mettere insieme e collegare più epoche storico-culturali. Il romanzo è naturalmente ambientato fuori dallo spazio e dal tempo e l’espediente del manoscritto ritrovato mi ha aiutato a movimentare la scena e mi ha consentito, poi, di sovrapporre diversi tipi di scrittura e di introdurre alcuni personaggi come quello di Gilda, la bibliotecaria, utili a completare il quadro d’insieme in modo che aderisse alle mie idee di rappresentazione”.

Parlando di Italicus, c’è o c’è stato nella storia italiana più o meno recente un personaggio che lo ha ispirato? A me il suo progetto e il suo cenacolo hanno ricordato Federico II di Svevia, mentre il suo slancio estetico e il suo rapporto con le donne hanno forse un che di dannunziano. Ti sei ispirato a qualcuno in particolare o hai accolto la suggestione di personaggi storici o realmente esistiti?
“Sicuramente, a parte la libera fantasia, ho preso ispirazione da Federico II che governava la Germania da Palermo. Tutto il romanzo è un’evidente provocazione meridionalista, quindi Federico II è un punto di riferimento. Per quanto riguarda le donne e il dannunzianesimo, su questo elemento c’è tanta autoironia. Poi c’è stato Ferdinando II di Borbone, il penultimo dei re borbonici che è stata una personalità complessa e ha avviato e portato avanti un processo di industrializzazione del Mezzogiorno poderoso, riconosciuto anche da Francesco Saverio Nitri e da altri studiosi. Lui è un altro personaggio che un po’ mi ha ispirato, anche per il fatto che delle volte si travestisse per andare in giro in incognito tra i suoi sudditi per controllare la situazione. Federico II, però, è il riferimento politico più pregnante”.
Il progetto di civilizzazione italica che vuole portare avanti Italicus è quasi utopistico, eppure si fonda sul fatto che nel mondo ci siano quasi trecento milioni di italici, cioè di persone che a prescindere dall’effettiva discendenza italiana, dalla cittadinanza e dalla posizione geografica si riconoscono nei valori italici e attorno a essi possono essere radunati. In questo senso, a che punto siamo, secondo te, nella realtà?

“A New York, all’ONU c’è l’UNAOC (United Nations Alliance of Civilizations), l’ufficio che si occupa delle civilizzazioni. Dal 2017 è compresa anche la civilizzazione italica, tenendo conto anche del fatto che il 70% del patrimonio culturale del mondo si trova in Italia. L’idea è che Italicus sia il rappresentante degli italici, di questi trecento milioni di persone che fanno riferimento alla civilizzazione italica, un concetto che vorrei precisare. L’esempio è quello di altre civilizzazioni più note, come quella anglosassone e quella ispanica, cioè qualcosa che travalica i vecchi confini territoriali e dà vita a questo insieme che raccoglie tutto ciò che fa riferimento all’Italia, alla sua cultura, alla lingua, al made in Italy, allo stile, all’arte, al gusto e così via. Gli italici – tra cui ci sono anche gli italiani – sono coloro che hanno un legame anche solo parziale o indiretto con l’Italia che può essere familiare o sociale. Si pensi all’importanza delle seconde e delle terze generazioni anche per il ritorno allo studio dell’italiano, ma può essere un legame anche di tipo culturale o economico (come per primo ha ribadito Piero Bassetti, ndr). Per esempio, tutti quelli che avviano o fanno parte di un’attività imprenditoriale ispirata all’Italian way of life. Andando in giro per il mondo, questo lo percepiamo. Italici sono anche i cittadini di posti in cui si parla italiano come la Dalmazia, l’Istria, il Canton Ticino, così come tutti gli italofili e gli stranieri che scelgono per lavoro e per passione di vivere in Italia e che, pur non avendo sangue italiano, hanno stili di vita e valori ispirati al sentire italiano. Si tratta di un soft power molto importante. L’Italia è diventata il primo influencer culturale del mondo, superando la Francia, dietro Stati Uniti e Spagna, eppure noi siamo poco consapevoli di questo potere di persuasione e di influenza che è estremamente rilevante nelle società contemporanee. L’affermarsi e il propagarsi del concetto di civilizzazione italica si inserisce, così, molto bene in un mondo sempre più trans-nazionale, dove cadono i confini e gli steccati, sempre più interconnesso grazie a internet e alla globalizzazione. Quindi anche le identità nazionali diventano plurinazionali e pluriformi. Ci sono molti italici con doppio o triplo passaporto e altri che non hanno il passaporto italiano ma si riferiscono ai nostri valori e intraprendono iniziative nel mondo, con riflessi anche in Italia, utilizzando formule di produzione italiana e macchinari utensili italiani”.
Ti sei occupato di emigrazione italiana con diversi speciali del TG1 dedicati agli italiani in Argentina, Australia e Stati Uniti. Tra le varie iniziative sia individuali sia legate alle istituzioni locali per promuovere, valorizzare e raccontare questi valori italiani, ce n’è qualcuna che ti ha particolarmente colpito?

“Da questo punto di vista l’Argentina è un Paese incredibile. Se cammini per le strade e guardi le insegne dei negozi ci sono moltissimi nomi italiani. Più di metà della popolazione argentina è di ascendenza italiana. È il Paese italico per eccellenza. Nelle PMI e nell’industria ci sono nomi come Rocca, Gancia e tanti altri, nomi storici dell’imprenditoria italiana e italica. A Mendoza, che è la regione in cui si produce un ottimo vino, ho scoperto che la vite è stata importata dagli italiani e anche il sistema di canalizzazione per portare l’acqua dalle montagne fino ai vitigni è stato progettato e realizzato da un ingegnere italiano. Molte di queste grosse case vinicole che esportano in tutto il mondo sono di discendenza italiana. Negli Stati Uniti, invece, sono andato nel New England in un paesino chiamato Gloucester dove ho visto una cosa incredibile, che non mi sarei mai aspettato. Su trentamila abitanti, la metà è di origine siciliana, compresa la sindaca che ho intervistato. Anche la religiosità di quei luoghi è tipicamente italica, con feste, processioni, cene. La religiosità popolare è fondamentale per unire, soprattutto all’estero. Oppure in Australia, dove il mercato del pesce di Sidney è in mano ai pescatori di Bagnara Calabra che sono fortissimi. Lì affermarsi e farsi rispettare non è stato facile per chi veniva da così lontano, ma in Australia c’è un grande rispetto per gli italiani proprio grazie al lavoro di chi si è impiantato. Loro pensano che le cose, quando sono fatte dagli italiani, sono migliori, perché abbiamo buon gusto e le sappiamo fare. Aziende come Iveco e Schirato sia in Australia sia in Asia hanno un ruolo importantissimo e producono utilizzando macchine utensili italiane”.
La religiosità di cui parli e in generale l’immagine dell’Italia così come viene rappresentata all’estero ha uno stampo decisamente meridionale, forse perché la prima grande ondata migratoria italiana alla fine dell’Ottocento ha riguardato soprattutto il Sud. Eppure tu nel romanzo racconti che prima dell’Unità d’Italia Napoli era una delle città più industrializzate d’Europa, capitale di un regno florido. Come ha fatto il Mezzogiorno, nel giro di un paio di generazioni, a diventare la terra desolata da cui scappare per evitare la miseria?
 “Questo si deve alla politica di occupazione militare e colonizzazione del meridione operata dalle classi dirigenti che hanno preso il potere dopo Cavour. Da quello che si intuisce dai suoi scritti, Cavour aveva capito cosa aveva tra le mani e aveva un’idea differente di come sviluppare l’interconnessione tra Nord e Sud. Invece le classi dirigenti piemontesi che hanno preso in mano la situazione dal 1861 in poi hanno pensato di colonizzare il Sud, anziché valorizzarlo, svuotandolo di tutti i contenuti industriali e finanziari e trasferendone al Nord gli asset principali attraverso leggi e impedimenti. La classe dirigente meridionale ha grosse responsabilità perché all’inizio, essendoci un divario economico così netto a favore del meridione, pensava di gestire meglio la situazione. Nel libro dico provocatoriamente «guai ai vinti» perché se non si patteggia nulla di serio, dopo una sconfitta, ti ritrovi con le scarpe in mano. A me non interessa il discorso neo-borbonico, però quando oggi si ridiscute dell’Unità nazionale e delle basi su cui rilanciare lo sviluppo del Paese non è detto che si debba guardare solo a Nord. Non a caso concludo il romanzo scrivendo «barra a Sud», anche perché il Mediterraneo è diventato nuovamente centrale, ci passano decine di migliaia di navi ogni anno. E noi stiamo lì. L’hanno capito i cinesi, i turchi, solo noi ancora non l’abbiamo capito bene. Ora però, forse, al timone c’è qualcuno che si rende conto della grande chance che abbiamo per colmare il gap del Meridione col resto dell’Europa”.
“Questo si deve alla politica di occupazione militare e colonizzazione del meridione operata dalle classi dirigenti che hanno preso il potere dopo Cavour. Da quello che si intuisce dai suoi scritti, Cavour aveva capito cosa aveva tra le mani e aveva un’idea differente di come sviluppare l’interconnessione tra Nord e Sud. Invece le classi dirigenti piemontesi che hanno preso in mano la situazione dal 1861 in poi hanno pensato di colonizzare il Sud, anziché valorizzarlo, svuotandolo di tutti i contenuti industriali e finanziari e trasferendone al Nord gli asset principali attraverso leggi e impedimenti. La classe dirigente meridionale ha grosse responsabilità perché all’inizio, essendoci un divario economico così netto a favore del meridione, pensava di gestire meglio la situazione. Nel libro dico provocatoriamente «guai ai vinti» perché se non si patteggia nulla di serio, dopo una sconfitta, ti ritrovi con le scarpe in mano. A me non interessa il discorso neo-borbonico, però quando oggi si ridiscute dell’Unità nazionale e delle basi su cui rilanciare lo sviluppo del Paese non è detto che si debba guardare solo a Nord. Non a caso concludo il romanzo scrivendo «barra a Sud», anche perché il Mediterraneo è diventato nuovamente centrale, ci passano decine di migliaia di navi ogni anno. E noi stiamo lì. L’hanno capito i cinesi, i turchi, solo noi ancora non l’abbiamo capito bene. Ora però, forse, al timone c’è qualcuno che si rende conto della grande chance che abbiamo per colmare il gap del Meridione col resto dell’Europa”.
Prima della pandemia, Milano viveva un momento di grande crescita, cominciato con l’Expo. Dopo la Brexit, molti la vedevano già prendere il posto di Londra nello scacchiere delle metropoli europee, poi però la città e la Lombardia sono state colpite molto duramente dall’emergenza sanitaria, che ha imposto una netta battuta d’arresto in quel senso. Nel tuo romanzo descrivi Napoli come «un set cinematografico a cielo aperto» e la città in effetti beneficia almeno da un decennio di una narrazione letteraria e cinematografica di grande visibilità internazionale (si pensi ai successi di Gomorra o dei romanzi di Elena Ferrante). Credi che la pandemia possa aver messo in discussione il ruolo di Milano come esclusiva protagonista e che sia spazio nel prossimo futuro anche per un riscatto di Napoli come capitale dell’Italia e dell’Europa meridionale?

“Anzitutto per Napoli può esserci la ripresa di un ruolo importante nei traffici marittimi, in questo senso ci sono già varie iniziative in corso. C’era poi l’idea di creare un grande polo tecnologico, che è iniziata anni fa e poi si è un po’ fermata e che con la pandemia non so a che punto sia. Inoltre c’è il ruolo culturale di Napoli che non è mai venuto a mancare, fondamentale e importantissimo. Dopo l’Unità nessuno si è mai posto veramente il problema del ruolo da dare a questa città e a tutto il Meridione. Sicuramente una delle sfide del rilancio del Paese, anche in virtù dei nuovi fondi che arriveranno, è anche quella del ruolo internazionale che avrà Napoli, una città che europea è sempre stata e continua a essere. Oltre al polo marittimo e tecnologico c’è un’industria da sviluppare di nuovo, perché quella industriale è sempre stata storicamente una vocazione della Campania. Io l’anno scorso sono stato a Grottaminarda, in provincia di Avellino, dove ho visitato una fabbrica di generatori che è diventata una piccola multinazionale con sedi in Inghilterra e in Germania, ma il cuore è lì in Campania. Mi ha colpito molto questa realtà perché non è isolata, ce ne sono molte. Quindi, se si investe e se si ha fiducia, le cose poi si affermano e vanno avanti. Ma questa vocazione industriale della Campania e di tutto il Mezzogiorno va rilanciata e strutturata più organicamente”.

Nel tuo romanzo chiami «Conformisti» tutti coloro che vogliono mantenere lo status quo e si oppongono agli «spiriti liberi» come Italicus, ostacolando a ogni forma di progresso. In quest’ottica fai un ritratto satirico feroce e grottesco di alcuni esponenti della classe politica e anche alla tv di Stato dedichi passaggi particolarmente pungenti. Che responsabilità hanno, secondo te, gli amministratori e anche i mediatori, coloro che sono chiamati a comunicare, raccontare e far conoscere il patrimonio culturale ed economico italiano? C’è qualcosa che hanno sbagliato, che è stato fatto bene o che invece si potrebbe fare meglio?
“Il mondo del business è abbastanza ricettivo all’idea della diffusione e della civilizzazione italica, anche se magari sono necessari dei correttivi sul piano etico. È proprio l’aspetto politico quello che è carente, perché c’è meno consapevolezza. Secondo me ciò si spiega con il fatto che la politica gestisce il potere costituito, quindi i politici non vedono di buon occhio quello che in qualche modo si oppone al loro potere e alle loro competenze, perché per definizione sono concepiti nei termini dei confini nazionali. Tutta questa idea che travalica i confini non è che gli piaccia granché. Noi abbiamo questo soft power che ci viene riconosciuto dagli stranieri e di cui spesso non siamo consapevoli. Uno dei nostri sport nazionali è l’autoflagellazione. Dobbiamo cercare di rafforzare e consolidare la consapevolezza di ciò che siamo e rappresentiamo nel mondo, di esserne orgogliosi. Tanto ci criticano anche gli altri, perciò noi dobbiamo criticarci fino a un certo punto e credere un po’ di più in noi stessi. Purtroppo non lo facciamo molto”.
Nel Manoscritto di Italicus c’è anche un confronto generazionale. Michele, il giornalista che ritrova il manoscritto, è un discendente di Italicus e lo stesso Italicus, quando decide di partire per realizzare il suo progetto di civilizzazione italica, riflette sulle conseguenze e che la sua assenza avrà sul figlio Tiziano. Quello del confronto e spesso anche dello scontro tra generazioni diverse, tra boomer e millennial, è un tema molto attuale. Per quanto riguarda il modo di vivere, interpretare e rappresentare l’italicità va tenuto conto del fatto che ci sono ormai diverse Italie: quella degli emigrati italiani degli anni sessanta, più tradizionale, è diversa dall’Italia degli expat, più focalizzata in contesti come quello accademico e tecnologico. Tu come vedi il rapporto tra queste generazioni e queste Italie differenti e cosa ci possiamo aspettare da esso?

“Io credo molto nei giovani capaci. Ne incontro continuamente in giro per il mondo, italiani o italici di straordinaria capacità. Noto anche che il legame con l’Italia è cercato e riscoperto dalle seconde e dalle terze generazioni, non solo con la lingua italiana, ma proprio col Paese, con la sua storia e le sue caratteristiche. C’è infatti il fenomeno del turismo delle radici, molte persone vogliono vedere da dove provengono e capire perché i loro antenati sono andati via. La mia generazione ha subìto la pressione dei Conformisti, per dirla nei termini del romanzo. Ha dovuto adattarsi e accettare compromessi per sopravvivere in questo contesto, dove un certo tipo di immobilismo era egemone. I giovani italiani, molti dei quali sono andati all’estero, non accettano questi compromessi. C’è dunque un fattore dinamico di rottura degli schemi conformisti e di modernizzazione reale del Paese che è potenzialmente importantissimo. C’è stato nelle altre civilizzazioni, quella anglosassone deve molto a chi è andato fuori e ha trasferito le sue esperienze rendendo molto più dinamica la società. È un processo sociale, culturale e politico importante. I giovani sono il futuro di questo Paese, ma non è demagogia. È perché sono in gamba, sono stati all’estero, sono globalizzati e non accettano certe cose antipatiche e insopportabili del nostro Paese come il conformismo dilagante e il servilismo verso il potere economico e politico, altro nostro male nazionale. Io credo molto in questa idea della civilizzazione italica perché può trasferire un potenziale enorme di modernizzazione all’interno del nostro Paese e possiamo giocarci una grande carta sul piano internazionale”.
Riferendoti ai Conformisti hai parlato di immobilismo. Con la pandemia l’immobilismo è stato forzato, parlavamo poco fa di Milano e delle conseguenze patite dall’Italia, ma gli effetti si vedono anche fuori dai nostri confini. C’è ad esempio la situazione di enorme disagio degli italiani negli Stati Uniti bloccati a causa del travel ban. Oltre all’immobilità fisica, la pandemia ha inoltre inibito in molti casi lo spostamento di idee, progetti, iniziative. Ciò ha chiaramente impattato anche il processo di civilizzazione italica. Quando l’emergenza sanitaria sarà finita, quale direzione pensi che si prenderà da questo punto di vista? Si proverà a ricominciare da dove tutto si è interrotto all’inizio del 2020 o questa pausa forzata potrà servirci magari ad aggiustare il tiro e cambiare strategia?

“Questa situazione non è risolta ma siamo sulla buona strada. Penso che bisognerà farsi trovare pronti per portare avanti e rilanciare il discorso della civilizzazione italica. Con l’Associazione Svegliamoci Italici, il 22 settembre presso la sede della Stampa Estera a Roma faremo un convegno di presentazione della Italica Global Community, che è questa piazza italiana aperta e a disposizione di tutti gli italici del mondo per riunire le energie, le idee, i progetti ed elaborarli insieme. Da lì pensiamo di iniziare un discorso di costruzione di un rapporto fra gli italici del mondo. Ci sono varie iniziative grazie alla rete, che ci permette di dialogare a migliaia di chilometri di distanza. Il convegno sarà aperto da Piero Bassetti, che ha lanciato l’idea con il suo libro Svegliamoci Italici! (Marsilio, 2015). Ci saranno in presenza e in video contributi da tutti gli italici del mondo: Brasile, Stati Uniti, Australia, Londra, Parigi, Russia… Sarà un congresso di fondazione della comunità, un primo passo, dopodiché si vedrà dove arriveremo”.












