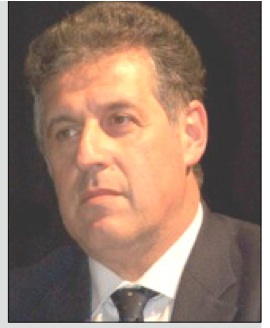Si laurea negli anni in cui la mattanza mafiosa ha un ritmo quotidiano, gli anni in cui i servitori dello Stato cadono, uno a uno, ogni giorno: Beppe Montana, Ninni Cassarà, Roberto Antiochia. Cresce col mito di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e anche da loro impara a non cedere a un’inclinazione tutta siciliana: quella della rassegnazione.
Sceglie di fare il magistrato e indossa la toga, per la prima volta, nella camera ardente allestita al Palazzo di Giustizia di Palermo per Falcone e la moglie Francesca Morvillo, uccisi dal tritolo di Capaci.
"Con la morte nel cuore meditavo sulla responsabilità, il significato, la complessità del ruolo del magistrato in terra di mafia, mentre migliaia di persone di tutti i ceti sociali venivano a rendere il loro omaggio a quegli eroi".
Pochissimi cenni biografici per avere un’idea di chi è Nino Di Matteo, pubblico ministero a Palermo, impegnato nelle principali inchieste sulla criminalità organizzata e sui suoi rapporti con la politica. Per la prima volta Di Matteo accetta di raccontarsi in un libro che è la narrazione di un percorso ideale ed esistenziale ma anche un grido di allarme sulla deriva pericolosa che la riforma Berlusconi, "che ricorda tanto il Piano di rinascita democratica della P2 di Gelli", potrebbe imprimere al mondo della Giustizia.
Il volume, scritto insieme al giornalista Loris Mazzetti, si intitola “Assedio alla Toga” ed è edito da Aliberti.
Ma perché un pm riservato, schivo, "tutto d’un pezzo", come lo definisce il suo coautore, decide di prendere posizione, uscire allo scoperto correndo il rischio di suscitare le critiche in chi pensa che le toghe debbano parlare solo con gli atti giudiziari?
La risposta la dà lui stesso: "È certo che stiamo vivendo un momento di grave pericolo che incombe sulla tenuta di alcuni valori costituzionali, e ogni magistrato per difendere quei principi dovrebbe trovare il coraggio di esporsi, di uscire dal riserbo": una dichiarazione che pare la presa d’atto d’una emergenza e che spingerà Di Matteo, incalzato dalle domande di Mazzetti, a fare riflessioni dure su una serie di argomenti sempre più attuali.
Come le commistioni mafia-politica "un’abitudine al dialogo permanente tra poteri politici e poteri criminali che anche in tempi recenti ha trovato ampi spazi di penetrazione", dice il pm nel cercare le radici di una con-suetudine che si perpetua. "Sorprende però come rispetto a certi fatti, a rapporti accertati (a prescindere dal loro rilievo strettamente processuale), in Italia non scatti mai un meccanismo di responsabilità politica che impedisca che esponenti che hanno conosciuto, frequentato, avuto significativi rapporti con mafiosi, continuino a rappresentarci in Parlamento", scrive sottolineando un’anomalia tutta nazionale.
Ma il magistrato non risparmia bacchettate neppure all’informazione "sorda" a certi argomenti. E, vero cuore del libro, alla riforma della giustizia voluta da Berlusconi.
Una riforma che "finirebbe per spuntare le armi investigative più importanti" e che vietando la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, anche quelle non più coperte dal segreto investigativo (pubblicabili solo all’inizio dell’eventuale dibattimento), "i cittadini verrebbero privati, per sempre o per un periodo comunque troppo lungo, della conoscenza di determinati fatti di interesse pubblico e magari importanti per orientare consapevolmente il loro voto".
Sotto scorta da 18 anni, costretto a rinunciare a una vita "normale", Di Matteo ricorda l’ingenuità dei primi anni in magistratura, i timori da pm a Caltanissetta. Ora legge le cose con la consapevolezza dell’esperienza e di chi sa "che indagare il rapporto politica-mafia significava inoltrarsi in un terreno minato. Anche oggi, come allora, quando si comincia a indagare e ci si avvicina veramente al cuore di questo nodo, iniziano le polemiche, si mette in moto la delegittimazione e l’isolamento dei magistrati che conducono quelle inchieste". E arrivano l’isolamento e la delegittimazione.