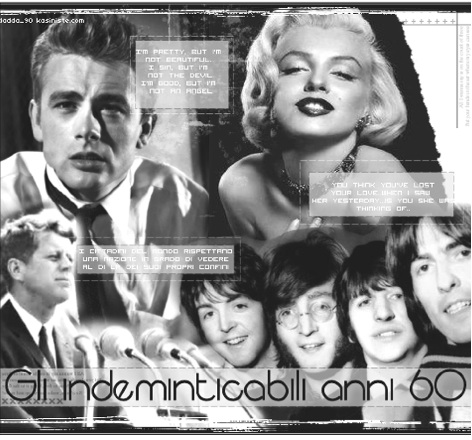C’è un correre per le strade, c’è una moto come simbolo di libertà, di andare a scoprire il mondo con innocenza, aperti a tutto, in queste pagine, e c’è il crescere e il morire, metaforico e reale, da quello di tutto un paese a quello del Tenebroso a cavallo della sua moto o del piccolo Ermanno Lavorini ucciso nella pineta della Marina di Vecchiano, vicino Pisa: "Neppure oggi, dopo quarant’anni, sappiamo con certezza cosa fu costretto a subire quel povero ragazzo. ma non è questo che ci interessa. L’importante è che Ermanno fu ucciso e che, con la sua fine, l’Italia si gettò dietro le spalle l’innocenza".
Ad Aurelio Picca non interessano – in «Addio» (pp. 174, Bompiani, Euro 16) – le prospettive storiche, le cesure profonde e drammatiche, non il movimento studentesco o l’autunno caldo con cui si apre una stagione tragica, ma la vita quotidiana, il modo di essere delle persone qualsiasi in un paese che vive la sua giovinezza economica, che si lascia definitivamente alle spalle la guerra e la ricostruzione e si sente spensierato e innocente, libero sull’onda delle mille canzonette pop in cui si rispecchiarono quegli anni Sessanta, da Ornella Vanoni a Massimo Ranieri, da Peppino di Capri a Gianni Morandi, da Nada ad Adamo e via ricordando. E lo scrittore crea proprio una sorta di colonna sonora di citazioni di quei versi al suo racconto, che va di pari passo con un’ispirazione visiva, quasi a contraltare, in cui invece è l’arte d’avanguardia, di ricerca di quegli anni a venir ricordata, i Sacchi e le Combustioni di Alberto Burri o le sagomine di De Dominicis, quasi i due aspetti di un’epoca: la spensieratezza e la preveggenza.
Se il poema di Picca “L’Italia è morta, io sono l’Italia”, fatto anch’esso di corse su e giù per tutto il paese, ma nei successivi anni Settanta, nasce in fondo da rabbia e impotenza e da un tentativo di non soccombere, in questo lungo «Addio» rivivono la tenerezza e lo stupore, lo scorrere dei giorni al bar e al biliardo, le malie del boom economico, uno sport ancora incorrotto, mentre la cronaca nera comincia a farsi efferata, a partire dal gratuito assassinio per rapina dei due giovani gioiellieri Menegazzo, ad annunciare quella perdita di innocenza. Da una parte, col Juke-Box, l’Oro Pilla, il J&B, la Simca e la Giulietta, dall’altra la malavita che comincia a usare le armi, i ragazzi che si sfidano "a centosettanta all’ora sulla via Appia a chi staccava il muso per ultimo dal tir che giungeva sull’altra corsia" e, di là dell’oceano, i sanguinosi riti satanici di Charles Manson.
Mille ricordi, citazioni, personaggi noti e non restituiscono, con la vitalità anche concitata della scrittura emotiva di Picca, quel decennio che fu anche il decennio della giovinezza e dell’innocenza dell’autore.
Un autore che nei suoi libri, da “Tuttestelle” a “Sacrocuore” e al recente “Se la fortuna è nostra”, mostra un rapporto diretto con la vita e lo sviscera sulla pagina, dolorosamente, ineffabilmente, passando certe volte più per quel che sente il cuore, altre attraverso la pancia e la testa.
In tutti i suoi libri, in versi o prosa, il senso di un’identità trovata e di una salvezza si rivelano nel momento in cui se ne celebra la fine (come questo "addio" che nelle ultime righe confessa di voler essere un arrivederci) e la testimoniano.