Quanto con i suoi romanzi Leonardo Sciascia penetrò nelle menti di chi lo leggeva negli Stati Uniti? E quanto gli scrittori americani plasmarono stile e idee del grande scrittore siciliano? E gli studenti americani, come reagiscono ancora oggi a quel “manuale” sulla mafia e dei suoi rapporti tra mafia e Stato che è il romanzo Il Giorno della Civetta”?
A cento anni dalla nascita dello scrittore, l’Istituto Italiano di Cultura di New York, con l’Associazione Amici di Leonardo Sciascia e la rivista internazionale di studi su Sciascia “Todomodo”, ha scavato questi e altri temi su vita e opere del “maestro elementare” di Racalmuto, in una settimana densa di eventi e dibattiti tenuti tra la sede istituzionale di Park Avenue, la libreria Rizzoli a Manhattan e il Center for Italian Modern Art (CIMA).
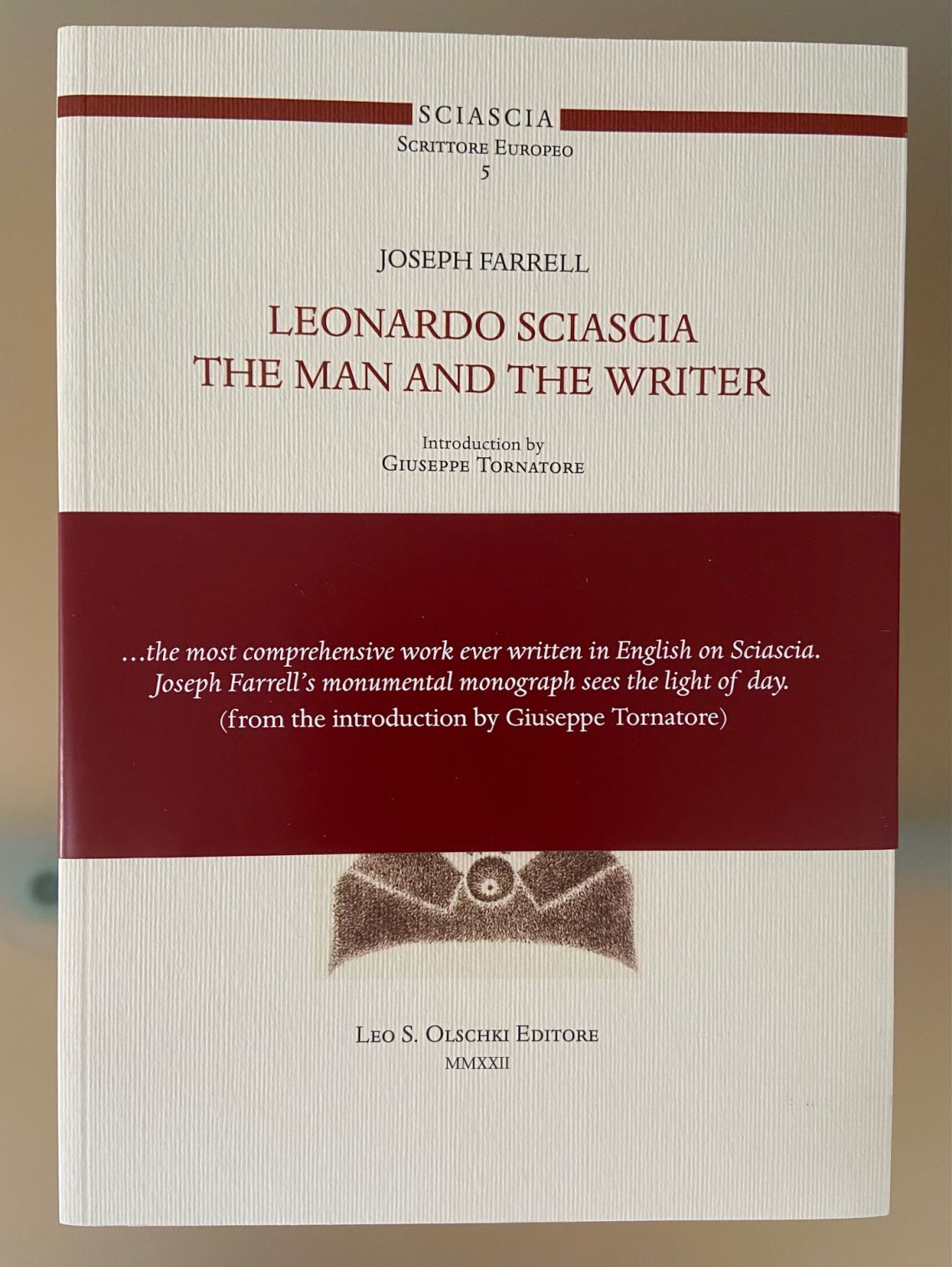
Diretto e moderato dal Prof. Valerio Cappozzo dell’University of Mississippi e presidente dell’Associazione Amici di Sciascia, il Colloquium si è articolato in diverse sessioni, tavole rotonde, video-interviste, videoclip con studenti e discussioni sulla relazione che lo scrittore ebbe con gli Stati Uniti.
La prima tappa della settimana sciasciana di New York si è svolta martedì, 20 settembre, alla libreria Rizzoli, dove, con la partecipazione di un pubblico numeroso e coinvolto (c’era anche la traduttrice Ann Goldstein) è stato presentato il libro di Joseph Farrell Leonardo Sciascia. The Man and the Writer, appena pubblicato dalla storica casa editrice fiorentina Leo S. Olschki e con un’introduzione firmata dal regista premio oscar Giuseppe Tornatore, che di Sciascia fu amico. Quella dello scozzese Farrell, emeritus professor a Glasgow di studi italiani alla University of Strathclyde, è la monografia più ricca e aggiornata disponibile in lingua inglese sull’opera e le idee di Sciascia, scritta da uno dei maggiori studiosi dell’autore siciliano. Alla presentazione, introdotta dal direttore dell’IIC Fabio Finotti, c’erano a commentare il libro con l’autore anche Valerio Cappozzo e Gaetana Marrone-Puglia della Princeton University.

Si parla del padre di Leonardo, Pasquale Sciascia, che emigrò negli USA nel 1912 ma che nel 1919 tornò in Sicilia “e di quella sua esperienza in America non parlò mai”. Leonardo invece non si recò mai oltre Oceano, anche quando divenne uno scrittore famoso e celebrato. Eppure il rapporto intellettuale con la letteratura americana fu costante e Sciascia ricevette in Sicilia molte visite di scrittori e pensatori americani. Alla presentazione del libro si è parlato anche del suo lavoro come direttore della rivista “Galleria” che negli anni Cinquanta pubblica ben due numeri monografici sulla letteratura, il cinema, il teatro e la poesia americana. Durante la presentazione, sono state sottolineate le varie funzioni che il libro può avere soprattutto per studenti statunitensi: quelle di offrire un contesto storico-culturale-politico dell’Italia del secondo Novecento in cui Sciascia ha operato.

Il giorno dopo, mercoledì, gli sciasciani si sono spostati nella elegante sala esposizioni del CIMA a SoHO, dove c’è stata la presentazione della ventottesima cartella di grafica d’arte fuori commercio della collana Omaggio a Sciascia, curata da Francesco Izzo (Direttore Operativo del Comitato Nazionale Celebrazioni Sciascia) per l’Associazione gli Amici di Leonardo Sciascia. Per l’occasione del centenario la cartella, in edizione bilingue, ospita il primo testo in inglese di Sciascia pubblicato nel 1952 a Chicago (e recentemente ritrovato da Valerio Cappozzo nel corso di una ricerca di archivio: si tratta della voce “Italian Literature” per l’American Peoples Encyclopedia), accompagnato dalla litografia in edizione numerata Portrait in Black, tratta da un ritratto originale dello scrittore siciliano eseguito nel 1979 dal celebre disegnatore David Levine per la The New York Review of Books. La serata, introdotta dal Direttore del CIMA, Nicola Lucchi, ha visto interventi di Teresa Fiore (Montclair State University), David Leopold (David Levine Archives) e Izzo e Cappozzo. A latere dell’iniziativa restano in mostra, a cura dei David Levine Archives, una dozzina di disegni originali di David Levine scelti dalla sua produzione di ritratti di scrittori e altri personaggi della cultura italiana e americana legati all’universo di Sciascia: Roberto Calasso, Federico Fellini, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Aldo Moro etc.

Le giornate di studio e dibattito del convegno sono state inaugurate giovedì nella sede di Park Avenue dell’IIC di New York con la presenza dell’ambasciatrice d’Italia a Washington Mariangela Zappia, che ha detto: ”Gli scritti di Sciascia sono profondamente radicati in Sicilia, la regione in cui è nato e la fonte primaria di ispirazione per molte delle sue opere. Eppure Sciascia è stato uno degli scrittori italiani del XX secolo con il più vasto pubblico internazionale e intergenerazionale”. L’ambasciatrice, ricordando l’ispirazione regionale di Sciascia e contemporaneamente il suo successo internazionale, ha aggiunto che “il messaggio e l’esempio di Sciascia sono oggi più attuali che mai: il suo radicato impegno civile e sociale, la sua apertura mentale e il tenace senso del dovere sono qualità che dovrebbero ispirare tutti di questi tempi”.

Collegati in videoconferenza all’evento ospitato dal direttore dell’Istituto di Cultura Fabio Finotti, per celebrare Sciascia e il suo rapporto intellettuale con l’America, pure il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova e la senatrice Emma Bonino, presidente del Comitato nazionale per la celebrazione del centenario sciasciano.
Nella prima sessione del convegno, intitolata “The Myth of America. Gli scrittori italiani e la letteratura americana”, Domenico Scarpa (Centro Studi Primo Levi) ha presentato per la prima volta il carteggio inedito tra Primo Levi e Sciascia. Levi scrisse infatti nel 1968 al Presidente USA Lyndon Johnson per criticare la guerra in Vietnam intesa come fine della civiltà. Levi inviò una bozza della lettera a Sciascia per commenti. Dalla Sicilia lo scrittore gli rispose appoggiando l’iniziativa pur se con riserve sull’utilità della stessa. Seguirono altre lettere con la speranza di trovare solidarietà tra altri intellettuali contro la guerra.
Joseph Farrell ha discusso l’attrazione verso l’America degli intellettuali italiani durante l’ascesa del fascismo sottolineando, attraverso aspetti biografici, il ruolo di Sciascia nella divulgazione della letteratura americana ma anche del rifiuto della politica statunitense e della pena di morte.

Nella sessione intitolata “Il mito Mediterraneo. The Legacy of Sciascia”, Francesca Maria Corrao (università LUISS) ha parlato della presa di conoscenza dell’esperienza araba e musulmana della Sicilia (oltre due secoli di dominio incontrastato dell’isola, fino al 1060 quando inizia la conquista Normanna), quando al tempo di Sciascia ancora se ne parlava poco. Per lo scrittore, invece, fu motivo di orgoglio storico e il suo stesso cognome era di evidente derivazione araba. Lo scrittore Amara Lakhous (New York University) ha parlato della condizione dell’esiliato, del rifugiato politico che sempre torna con la sua testa alla terra di origine, come i siciliani emigrati in America che ritrovano in Sciascia una sorta di linguaggio primordiale, materno. Lakhous ha rivelato anche l’ispirazione che gli dà Sciascia nello scrivere i suoi romanzi.
Partecipata e stimolante la tavola rotonda dedicata alla traduzione e intitolata “Translating Sciascia in English. Difficoltà di traduzione, tecniche, metodologie”. Ann Goldstein si è concentrata sulla traduzione delle prose poetiche, Joseph Farrell dei romanzi, James Marcus (NYU) dell’opera critica. Marcus ha parlato anche delle difficoltà nel far capire il background storico sulle situazioni narrate nei romanzi di Sciascia: “Sappiamo quanto gli americani vivono più presente e futuro senza preoccuparsi del passato, ma per Sciascia la storia era fondamentale per poter interpretare le vicende contemporanee”. Tutti hanno auspicato nuove traduzioni ed edizioni americane dell’opera di Sciascia.

Nella sezione dedicata agli studi cinematografici e intitolata “Quando il cinema era il cinema”, è stato mostrato il video inedito delle interviste condotte “parallelamente” nel 1983 da Rita Cirio a Sciascia e Federico Fellini. Il tema era il ruolo della letteratura e del cinema verso il pubblico e il debito dell’uno verso l’altro. Anche con domande sul cinema preferito da Sciascia e da Fellini, che hanno mostrato preferenze per quello francese e americano degli anni Trenta e Quaranta (Sciascia), quello comico dei fratelli Marx (Fellini). Sciascia si lamenta della fine del vero cinema ormai ridotto più a spettacolo che a formulazione artistica, mentre Fellini a sorpresa dice di andare poco al cinema e solo per vedere i film di 007, “fatti benissimo!”. Interessante la risposta di Sciascia alla domanda del “per chi si scrive”, se per se stessi o per il pubblico: “Uno scrittore, come penso un regista, non penso possa dedicarsi alla sua opera pensando a quello che vuole il pubblico. Si scrive per se stessi” dice Sciascia nel suo forte accento siciliano, per poi concludere: “Io quando scrivo devo divertirmi e poi certo, magari uno spera che dopo il romanzo piaccia. Ma come si può scrivere senza divertimento?”

Gaetana Marrone Puglia (Princeton University) ha parlato dello stretto rapporto del regista Francesco Rosi con la letteratura di Sciascia (erano amici), e anche di quella col regista Roberto Andò. Marrone-Puglia, ha ricordato come nacque il film di Rosi “Cadaveri Eccellenti”: il regista tornava in areo da New York e aveva con se il libro “Il Contesto” di Sciascia che lesse d’un fiato attraversando l’Oceano. Appena arrivato a Roma, chiamò subito lo scrittore per chiudere l’accordo per il film che poi prese quel titolo per sottolineare l’alto livello degli assassinati nella trama. Marrone Puglia ha spiegato come Sciascia e Rosi, che diventano amici, nella loro opera sono determinati a mostrare in Sicilia “la mafia organica al potere”. Per Rosi, che aveva già diretto anni prima “Salvatore Giuliano”, “la verità non è sempre rivoluzionaria”, ma per il regista, come per l’amico scrittore, lo scopo principale della creazione e tensione artistica resta la denuncia delle menzogne del potere e la ricerca della giustizia, anche quando questa appare impossibile da raggiungere. “Cadaveri Eccellenti”, con il grande attore italo-francese Lino Ventura, sviluppa la vicenda dell’assassinio di diversi magistrati, proprio come avverrà in Sicilia fino alle stragi per Falcone e Borsellino (il primo, il procuratore capo Pietro Scaglione, cade nel 1971). “Quando un giudice muore è una questione per un’ indagine poliziesca” ricorda Marrone Puglia, “quando sono quattro giudici a morire, come nel romanzo di Sciascia, il contesto diventa politico”.
Lo scrittore Antonio Monda, professore di cinema alla NYU e già direttore della Festa del cinema di Roma, ha mostrato la resa cinematografica dei passaggi cruciali dei romanzi sciasciani nel grande schermo. Monda ha esordito dicendo di aver profonda stima della libertà intellettuale di Sciascia, come quando scrisse dei “professionisti dell’antimafia”. Per Sciascia la mafia, ha ricordato Monda, “si combatte con il diritto. Lino Ventura, il commissario protagonista nel film di Rosi, crede nel diritto. Così come anche Gian Maria Volontè, il giudice protagonista del film di Gianni Amelio “Porte Aperte” che rifiuta la pena di morte imposta dal fascismo”. Monda ha ricordato anche i film di Elio Petri ripresi dai romanzi di Sciascia (“A ciascuno il suo”, “Todo modo”) per concludere che per lo scrittore siciliano“non bisogna imparare a scrivere ma a vedere, scrivere è una conseguenza”.
Per l’ultima sezione di giovedì all’Istituto di Cultura, intitolata “The America di Leonardo Sciascia. Interventi critici, giornalistici e narrativi”, per primo ha preso la parola l’organizzatore Valerio Cappozzo seguito poi dal giornalista Valter Vecellio, direttore responsabile della rivista “Todomodo”, già vice direttore del Tg2 Rai, commentatore di Radio Radicale e columnist de La Voce di New York con la rubrica “Sciascianamente”.

Cappozzo ha dedicato il suo intervento allo Sciascia giornalista, con i suoi articoli apparsi nel New York Times, i pezzi su di lui pubblicati dai giornali USA e il rapporto che lo scrittore intratteneva con giornalisti e intellettuali americani, come Herbert Mitgang. In queste corrispondenze c’erano anche quelle con gli attivisti del Council of Federated Organization, coalizione del Civil Rights Movement (COFO) e The Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC). L’America profonda e in lotta per i diritti civili che leggeva Sciascia, dalla voce diretta dei protagonisti, e anche per questo l’FBI di Hoover aprirà un dossier su Sciascia.

L’intervento di Vecellio si è concentrato sull’idea di Sciascia dell’America e di come questa cambiò (in peggio) col passare degli anni, da attrazione letteraria a rifiuto politico per chi tradiva i suoi stessi ideali. Vale la pena seguire quasi per intero il racconto che Vecellio ha fatto a New York, che ha esordito dicendo: “Forse dico una sciocchezza, ma per me il grande romanzo americano lo scrive un cineasta che si chiama Clint Eastwood. Se si prendono tutti i suoi film, sono storie di persone normali che ad un certo punto si trovano a dover affrontare degli avvenimenti straordinari per trovare loro stessi le risorse per non uscirne stritolati. C’è un mito in questi film racconto, l’individuo che vorrebbe vivere una vita in pace e tranquilla e invece deve fare i conti con una realtà che non si può eludere. E chi ha scritto, ovviamente sempre secondo me, nel secolo che ci siamo lasciati alle spalle, il grande romanzo italiano? Leonardo Sciascia. Anche lui ha qualcosa di cinematografico. Spesso in conversazioni private e anche interviste, Sciascia diceva che i suoi racconti erano praticamente delle sceneggiature già fatte e portarle nel grande schermo era facilissimo. L’intera produzione di Sciascia è tutto sommato un grande e unico libro: il racconto, la descrizione di persone normali che ad un certo punto anche loro devo avere a che fare con grandi avvenimenti. E accanto a questi racconti, di stampo cinematografico, secchi, limpidi, essenziali, come sono i film di Clint Eastwood, c’è una sorta di diario, che Sciascia compila con metodo e pazienza e fa la nostra fortuna. Perché è di grande aiuto per comprendere il testo fra il contesto. Non solo la scena, ma anche il retroscena”.
“Questo volume” continua Vecellio, “intitolato, Nero su nero, che Sciascia pubblica nel 1979, contiene riflessioni, dialoghi, suggestioni, che sono state provocate da cose viste e vissute, da letture, la sua memoria. Ad un certo punto c’è una nota che ci aiuta nel tema che cerco di sviluppare. Sciascia riflette su alcune fotografie, che gli inviati di guerra americani e inglesi hanno scattato durante la campagna in Sicilia nell’estate del 1943. Una di queste foto è di Robert Capa. Ritrae un soldato americano molto alto, quasi inginocchiato, che guarda un punto lontano che gli viene indicato da un piccolo contadino o pastore, siciliano, che appunta gli indica col bastone un punto, una direzione. Anni dopo sapremo che quel piccolo contadino o pastore è stato fucilato dai nazisti, colpevole di avere aiuta i soldati americani”.

L’intervento di Vecellio continua a svilupparsi: “E’ il ‘pretesto’ che viene usato da Sciascia per ragionare sul mito americano: soldati, figli, nipoti, comunque parenti o amici di emigrati dalla Sicilia e in Sicilia rimandati proprio per sfruttare questi legami familiari. Il piccolo contadino indica la strada giusta “al paesano, all’amico, al parente ricco comandato dal suo buon presidente a venire in Sicilia a fare una buona e giusta Guerra…”. Quelle fotografie, scrive Sciascia, dicono tutto: non ci sono solo il pastore, il paesano, gli americani: “Ci siamo anche noi, ventenni, col mito dell’America che non ci veniva dai parenti e dagli amici (degli amici), – degli amici che vi lascio immaginare chi sono – ma dalle appassionate letture, cui Vittorini e Pavese ci avevano avviato, di Faulkner, di Hemingway, di Steinbeck, di Caldwell, di Saroyan, ‘Che ve ne sembra dell’America?’, chiedeva il titolo di un libro di Saroyan tradotto da Vittorini. La libertà, la democrazia, il new deal, la frontiera verso il mondo nuovo – era la nostra risposta”.
Prosegue Vecellio: “Per questa specie di indagine si possono trovare altre tracce utili. Le Parrocchie di Regalpreta, uno dei primi libri pubblicati da Sciascia, nel 1956 da Laterza, nel capitolo quando cade il regime, cioè il regime fascista”. Qui Vecellio ritrova le origini dell’antifascismo in Sciascia, “grazie ad un segno rosso” che un professore mette in un compito dove Leonardo scriveva Affrica, in modo d’Annunziano. Vecellio fa parlare lo stesso Sciascia: “Non amava d’Annunzio e i dannunziani… Così passai le vacanze leggendo gli autori americani, come John Dos Passos, non ricordo come mi fossero venuti tra le mani…”.
Vecellio prosegue nel suo affascinante viaggio nel pensiero di Sciascia: “Facciamo un salto di 22 anni, Sciascia rilascia una lunga intervista alla rivista ‘Mondo Operaio’. Racconta che da giovane ha subito le influenze di alcune persone che gli hanno fatto da maestri, tra i quali un professore di lettere, forse proprio quello che gli aveva segnato in rosso Affrica. Che si chiama Giuseppe Granata. Introduce a Sciascia i testi di tutti gli illuministi sia francesi che italiani. Ma racconta, sempre Sciascia, che fu lui ad avvicinarlo alla letteratura americana. ‘Fu lui pressarmi a quel libro che ho letto di Dos Passos, ‘Il 42esimo Parlallelo’.”
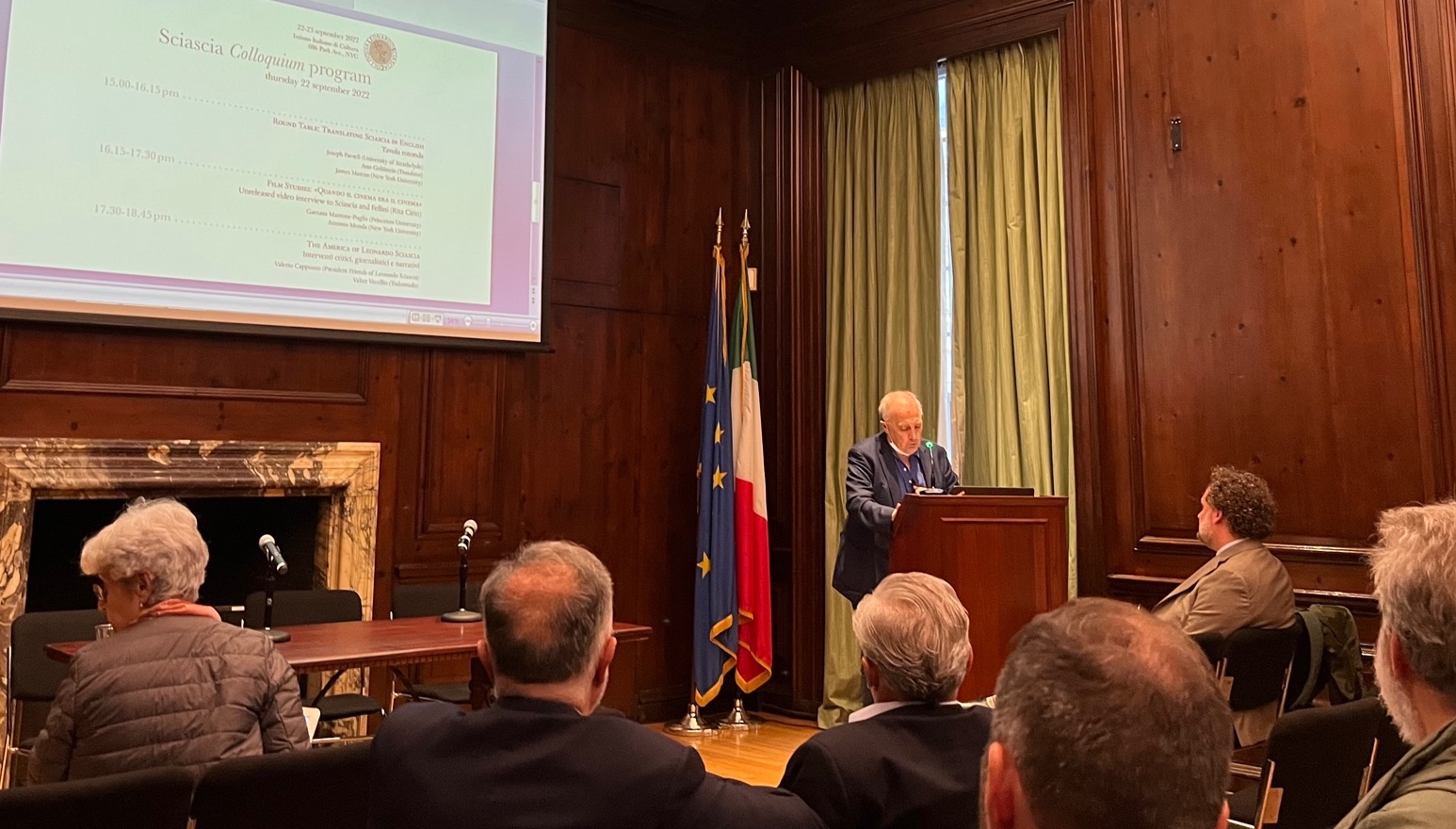
Ci dice Vecellio, che Sciascia confessa il debito contratto con gli scrittori americani del ‘900 in una intervista del giugno del 1978 al settimanale francese Le Nouvel Observateur e sempre dando voce al racconto dello stesso scrittore: “Tra i 13 e i 17 anni, ma non più in là, ho avuto una grossa passione per Gabriele D’Annunzio. La cotta mi è passata quando mi sono accorto che D’Annunzio era caduto dalla parte sbagliata, dalla parte del nazionalismo, del fascismo. Mi è passata grazie agli americani: Steinbeck, Caldwell, Faulkner, e grazie a quello che si è potuto leggere di Hemingway sotto il fascismo”.
Quindi Vecellio aggiunge: “Quanto questo specifico mito abbia fatto presa su Sciascia ne possiamo discutere con una certa cautela: perché al pari di tanti emigranti, il padre dello scrittore, Pasquale, si trasferisce negli Stati Uniti dal 1912 al 1919. Un fraterno amico di Sciascia, lo scrittore Matteo Collura, ci fornisce dei ragguagli utili su questo soggiorno americano, nella voce ‘America’, del suo alfabeto eretico:
“Suo padre, emigrato nel 1912, rimase sette anni facendogli anche il servizio militare. Dovette essere un’esperienza tutt’altro che edificante per lui, se tornato nella sua Racalmuto non ne parlò mai né in famiglia né tra gli amici. Così negli anni in cui Leonardo era bambino, nel suo paese – luogo tra i più lacerati dall’emigrazione in Sicilia – l’idea che si aveva di quel lontano continente era quella che lui avrebbe rievocato da scrittore: ‘I racalmutesi hanno sempre visto l’America con terrore, come un destino particolarmente amaro e negativo. Quegli emigranti che temporaneamente tornavano, ogni cinque o dieci anni, e sembravano americanizzati, venivano guardati con disprezzo, come se fossero divenuti più stupidi di prima. L’America la si immaginava come un posto dove non si sapeva vivere, dove si sgobbava da abbruttirsi, dove ci si inebetiva e ci si vestiva in maniera strana: cravatte dai colori sgargianti e appariscenti per gli uomini, capellini indescrivibili per le donne. Gli emigranti di ritorno li si distingueva anche per il loro dialetto arretrato, dicevano ‘bunaca’ per dire giacca e ‘burcetta’ invece di forchetta, e a Racalmuto questo faceva ridere. E poi quelli di lagnavano, dicevano che il paese non era cambiato, che era sporco come prima e anch’essi ci disprezzavano. Guardavano con diffidenza i parenti, come se tutti mirassero al loro denaro; e magari era così”.
Ed ecco che nel racconto di Vecellio, si inserisce persino un famoso cantautore: “Qui mi concedo un salto. E’ curioso ma anche di qualche significato come questi sentimenti, queste suggestioni, questi atteggiamenti restino immutati al di là dei luoghi e del tempo. Un cantautore italiano, poeta modenese, si chiama Francesco Guccini, in una delle sue più belle ballate, “Amerigo”, del 1978, parla di un suo pro zio emigrato in America. E’ un continuo confronto con gli Stati Uniti reali, quell’America dove si sconta emarginazione, fatica e sconfitta, e quella del mito che coltivava appunto Guccini, della fantasia, del viaggi fatto con l’immaginazione. E le immagini non si sovrappongono restano distanti l’una dalle altre. L’America di Amerigo è fatta di un lavoro duro, di sangue e di fatica, ‘di birre, di puttane, di giorni duri, di negri, di irlandesi, di polacchi e italiani, nella miniera, di sudore…’ cosi canta Guccini. E l’altra invece è quella del sogno, provincia dolce, l’America che è l’Atlantide, il cuore e il destino, dei sorrisi, dei rimpianti, patinata, di Ringo, e degli errori di Casablanca e Fort Apache… Alla fine Amerigo torna. .. già l’America di Amerigo è molto simile a quella del padre di Sciascia, amara…”.

A questo Vecellio passa ad una famosa intervista, quella di Giampiero Mughini a Sciascia, in cui si ricorda allo scrittore “che lui ha parlato di schizofrenia dell’intellettuale meridionale. Scisso tra la realtà che lo circonda e i viaggi, almeno quelli mentali, in culture e capitali lontane. Sei mai stato partecipe di questa schizofrenia, gli domanda Mughini. ‘La mia prima infatuazione, risponde Sciascia, fu per il mondo americano, che non mi apparve però come un mondo da visitare, ma da vivere attraverso i libri. E’ curioso ad esempio, come io sia arrivato a Giovanni Verga, un scrittore che tutt’oggi non riesco ad amare completamente, attraverso una testimonianza entusiastica che ne aveva scritto un americano, William Burnett’”.
Vecellio infine ricorda come Sciascia in America non mette mai piede, “neanche quando scrittore affermato senza problemi economici, avrebbe potuto andarci. Forse ha paura dell’aereo, non si sa per quale motivo, è stata piuttosto l’America ad andare da lui. Mi riferisco agli anni della guerra, quando gli anglo-americani sbarcano in Sicilia, nel 1943 e come molti di loro erano ‘paesani’ che il comando americano pensava sarebbero stati accolti con maggiore simpatia. Sfogliano i racconti che compongono ‘Le zie d’America’, la madre dell’io narrante… Si può osservare che dal mito della democrazia derivato dalla lettura dei romanzi, progressivamente però si passa ad una sorta disincantata parodia. Si osserva e si denuncia un consumismo che lascia intravedere quello che anni dopo accadrà e che l’atteso esercito dei liberatori in realtà portava con sé, manifestazioni di quella arroganza che era tipica di uno dei generali famosi di quella guerra, George Patton, comandante della settimana armata, che Sciascia ricorda si rese responsabile di alcuni sanguinosi eccidi tra cui la fucilazione di 73 militari italiani catturati dopo la conquista dell’aeroporto di Biscari…”

Alla fine Vecellio conclude il suo emozionante intervento così: “Chiudo con una notazione che racconta di un altro scrittore Siciliano che si chiamava Vincenzo Consolo, di Sciascia grande amico, che racconta che le sue sigarette, “erano le Chesterfield, le sue preferite, che fumava dal tempo dell’arrivo delle truppe americane in Sicilia”. Un mito anche questo, che veniva aspirato con voluttà e che contemporaneamente poi va in fumo”.
L’ultima Giornata del Convegno sciasciano, quella di venerdì, all’Istituto di Cultura si chiude con due sezioni. La prima intitolata Leonardo Sciascia in America “The American Reception of a Sicilian Writer” con l’intervento di Alessandro Giammei (Yale University) sul rapporto tra Sciascia e lo scrittore Ben Morreale, e la trasposizione che Morreale fa di Sciascia trasformandolo in un personaggio letterario. Quindi la ricezione sì delle opere di Sciascia in America ma anche (e addirittura) la metamorfosi dello scrittore in personaggio letterario. Poi l’intervento di Giulia Pellizzato (Harvard University) incentrato sulle pubblicazioni in America e le relazioni con gli editori, redattori americani (in primo luogo Knopf).
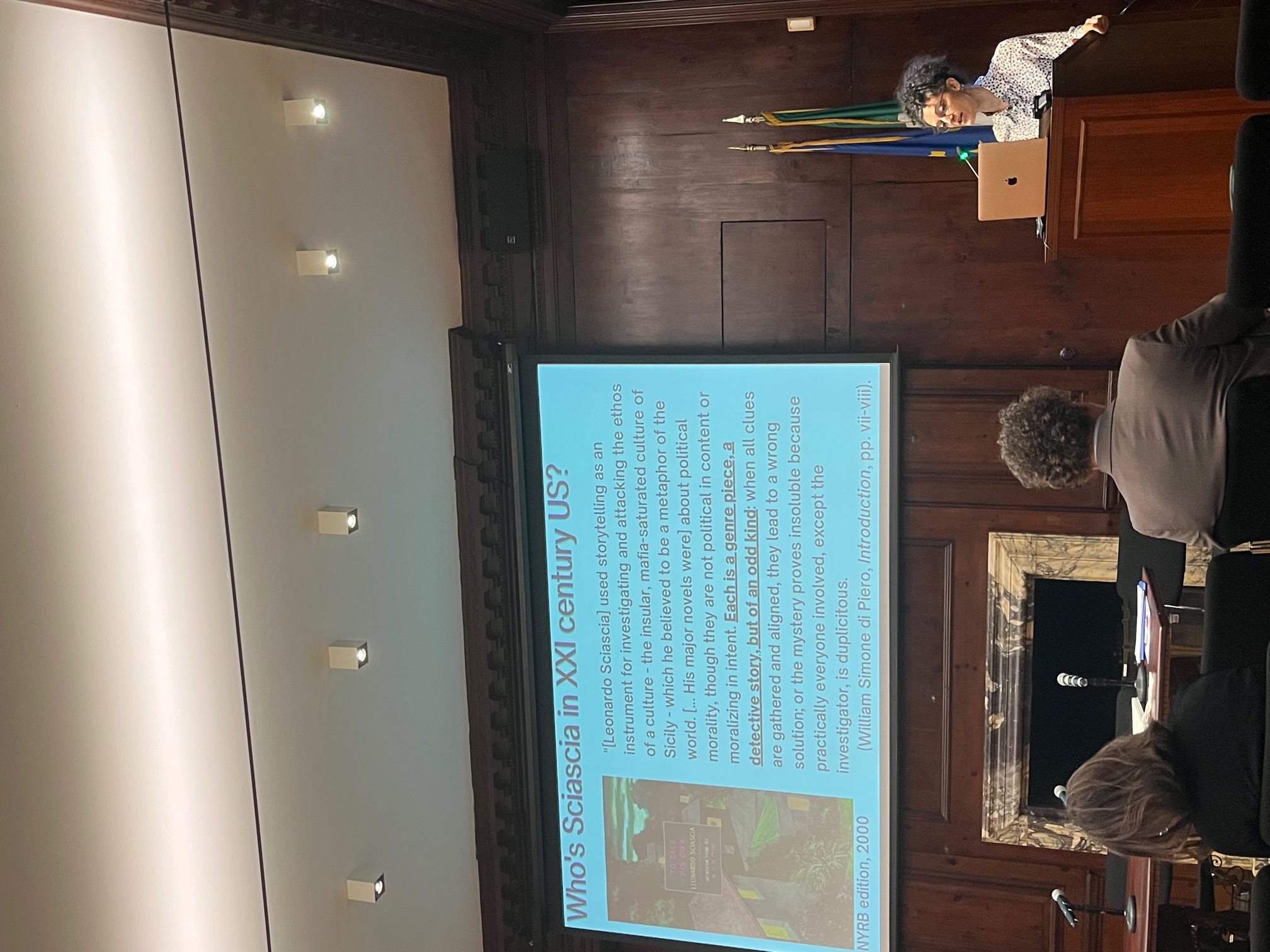
A chiudere, la sezione intitolata “Teaching Leonardo Sciascia. The Italia High Schools and US Universities. In questa l’insegnante Roberta De Luca, dirigente dell’Associazione Amici di Leonard Sciascia, ha parlato via video dall’Italia del progetto Sciascia per le scuole, dei metodi per insegnare Sciascia e mostrato anche un bel video prodotto dagli studenti di un liceo di Gaeta, ispirato dal racconto “La zia d’America” di Leonardo Sciascia.
Quindi Salvatore Pappalardo (Towson University) ha infine descritto la sfida di insegnare Sciascia agli studenti americani del college. “Bisogna soprattutto munirsi anche di una mappa geografica e far vedere il contesto della Sicilia al centro del Mediterraneo”, ha consigliato. I libri preferiti da Pappalardo sono “Il Consiglio d’Egitto”, “A ciascun il suo”, “Il Giorno della Civetta”. Su quest’ultimo, accoglienza con un misto di “scetticismo, curiosità, ottimismo, con Bellodi che sembra uscito da una delle opere di Shakespeare…”.
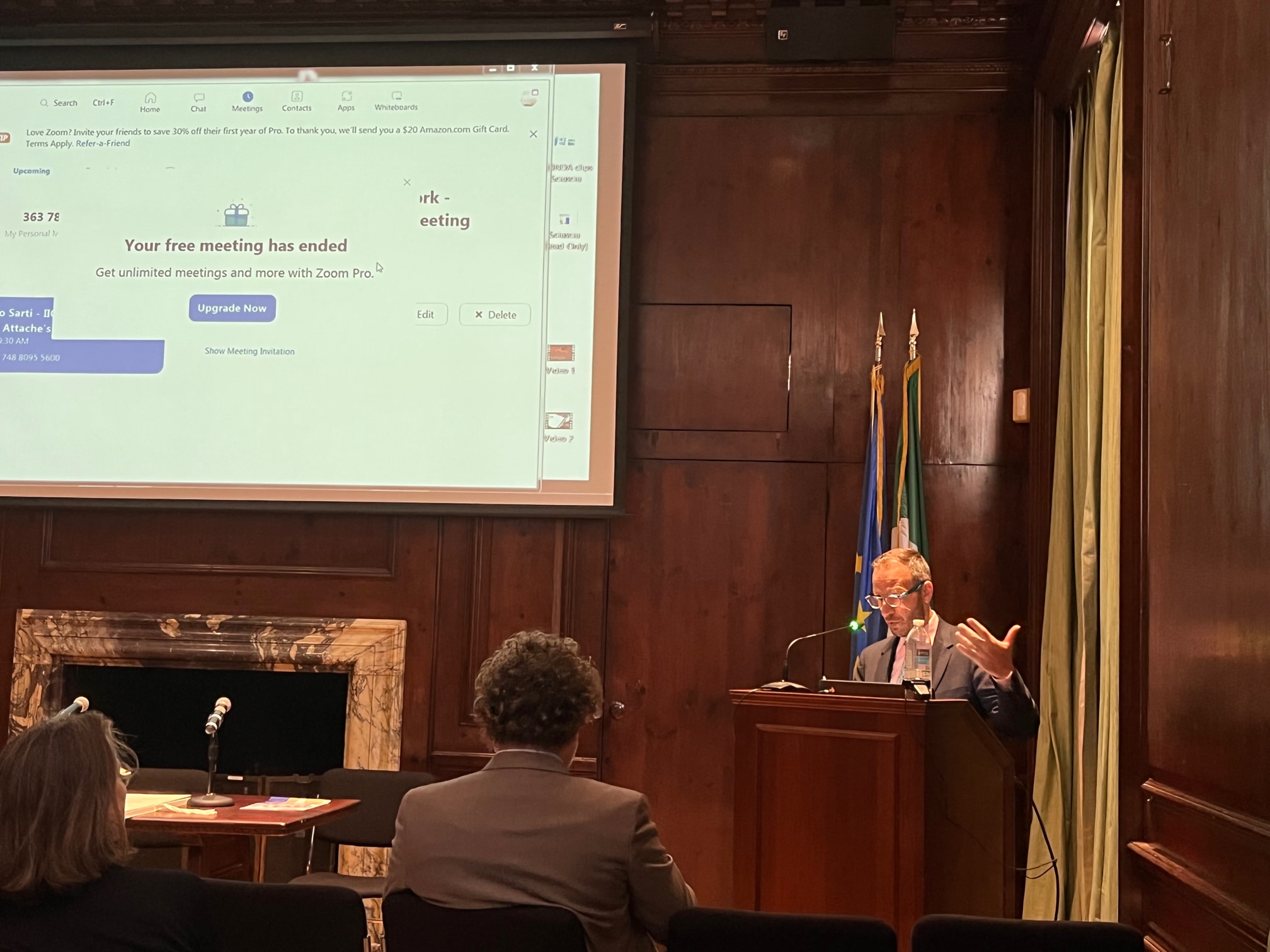
Pappalardo ha spiegato come gli studenti americani comprendono il potere “totalizzante” della mafia nei romanzi di Sciascia, e arrivano poi a fare paragoni su Trump e il fascismo “per certi modi di nominare i giudici”. Un altro aspetto la conoscenza del passato in Sicilia che viene rapportato alla esperienza degli afro americani negli USA. “Ai miei studenti faccio leggere gli scritti di Booker T. Washington, nato schiavo e che, diventato un letterato, viaggiò in Sicilia proprio nel 1912 (l’anno che Pasquale Sciascia andò in America). Le sue osservazioni sui contadini siciliani gli ricordano gli schiavi americani. Sì, studiando Sciascia, dibattiamo di razzismo e gli studenti riconoscono che lo scrittore resta così rilevante nel dibattito attuale”.

Gli atti del convegno verranno pubblicati (in italiano e in inglese) come secondo tomo della rivista Todomodo (Olschki 2023). Per seguire le iniziative dell’Associazione e per diventare membri, si veda il sito amicisciascia.it












