Siamo nel cuore di New Haven al 31.mo piano del Financial Building nell’ufficio del giudice federale Guido Calabresi, ex Professore di giurisprudenza e Dean della prestigiosa Law School della Yale University. Vogliamo augurare al giudice buon compleanno, ed abbiamo colto l’occasione per intervistarlo e parlare un po’ della sua vita e della sua brillante carriera. Calabresi, nato a Milano nel 1932, figlio del cardiologo Massimo Calabresi e della studiosa Bianca Maria Finzi-Contini, si trasferì con la famiglia a New Haven, nel Connecticut.
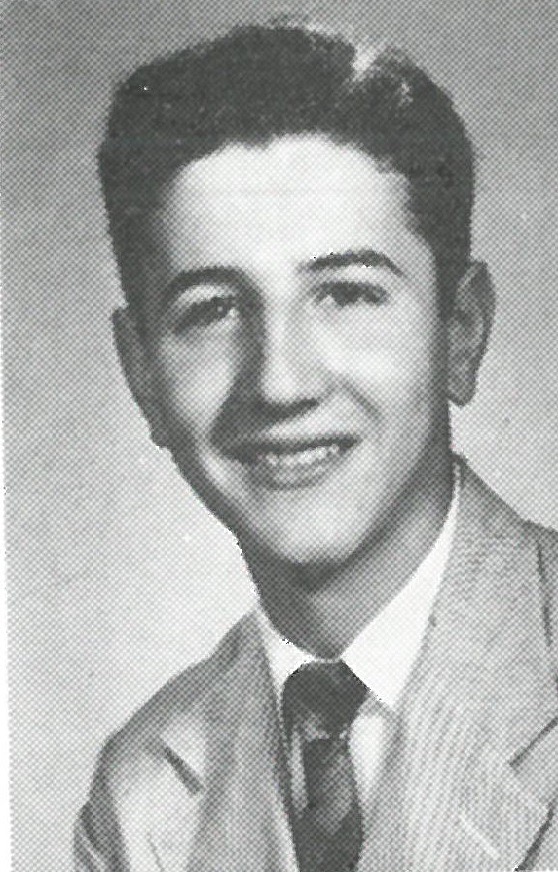
Nel 1953 si laurea in scienze presso lo Yale College dell’ università, specializzandosi in economia, e nel 1955 riceve un bachelor of arts dal Magdalen College dell’Università di Oxford. Successivamente, nel 1958, si laurea in legge dalla Yale Law School, lavorando poi come consulente legale per il giudice associato della Corte suprema statunitense Hugo Black. Frequenta la facoltà di Giurisprudenza di Yale come completamento al suo incarico presso la Corte Suprema, diventando il più giovane professore nella storia di Yale Law School, della quale fu preside dal 1985 al 1994. Sotto la sua leadership intellettuale e amministrativa, la Yale Law School divenne un punto di riferimento dell’analisi economica del diritto. Ha ottenuto inoltre un master in scienze politiche, filosofia ed economia dall’Università di Oxford nel 1959, una laurea magistrale Honoris Causa in giurisprudenza dall’Università degli Studi di Pavia nel 1987 e numerose lauree honoris causa dalle Università di tutto il mondo. Attualmente è professore emerito alla Yale Law School.
Il 9 febbraio 1994 il presidente statunitense Bill Clinton lo nomina giudice della U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, primo italo-americano ad essere nominato Giudice Federale della Corte d’Appello del Second Circuit con giurisdizione di tre stati, Connecticut, New York e Vermont. Oggi alcuni dei suoi studenti sono attuali giudici della Corte Suprema americana: Samuel Alito, Clarence Thomas, Sonia Sotomayor e Brett Kavanaugh.

È autore di sette libri e più di 150 articoli di diritto e argomenti correlati. Il suo saggio “Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral,” è uno dei lavori scientifici più citati nella letteratura giuridica mondiale.
Una carriera incredibile, ricca di successo. Qui cerchiamo di approfondire alcuni aspetti della vita del giudice Guido Calabresi.
Quale influenza ha avuto sua madre? Non dimentichiamo che è Maria Finzi Contini.

“Mia madre era una persona brillante, era riuscita a inserirsi in ambito accademico e a fare carriera qui in America in un periodo in cui a Yale le donne quasi non erano accettate. Qui in America ha conseguito un dottorato di ricerca in letteratura francese che si è aggiunto a quello in filosofia conseguito in Italia. Le sue idee erano molte diverse da quelle di mio padre in tantissimi aspetti. Mia madre si era convertita al cattolicesimo, lo aveva deciso poco dopo la mia nascita, non tanto come avevano fatto in molti per motivi legati alle leggi razziali, ma perché credeva in Dio. Questo é anche uno degli aspetti in cui sono più simile a mia madre, perché mio padre non era credente come tanti italiani.
L’ elemento più interessante é il fatto che il mio modo d’insegnare e quello di mia figlia, che porta il nome di mia madre Bianca Finzi Contini e insegna alla Columbia University, é molto simile a quello di mia madre. Infatti alcuni studenti di mia figlia che sono stati anche miei alunni, dopo due settimane mi hanno detto: “ma lei insegna proprio come sua figlia?” Ed io, rimasto sorpreso, ho risposto, “Credo che sia io che lei insegniamo come mia madre”.”
Qual é il ruolo di suo padre nella sua educazione?
“Mio padre era una persona “di principio”. Era antifascista già nel 1924, quando frequentava l’università. Infatti, durante un discorso del Ministro per l’Educazione fascista, si rifiutò di applaudire e dopo il discorso, lo presero, lo portarono in una stanza al piano superiore e lo bastonarono, e il ministro per l’istruzione fascista gli disse: “Sei stato molto buono, non hai fatto chiasso, ma non hai applaudito”. Da quel momento mio padre diventò un attivo antifascista. Negli stessi anni i suoi amici più cari i fratelli Rosselli furono ammazzati, e cosi mio padre decise di lasciare l’Italia, dopo la morte del nonno. Noi eravamo benestanti in Italia e siamo arrivati in America senza un centesimo per ragioni di coerenza politica. Credo che mio padre mi abbia lasciato in eredità questo: il coraggio delle proprie idee e la integrità morale”.

La relazione con l’opera di Bassani.
“La storia del rapporto Finzi Contini e il libro di Bassani è un po’ più complicata, il suo libro è stato ambientato nella casa antica della famiglia di mio padre a Ferrara, una casa del duecento….trecento, dove ci sono affreschi giotteschi magnifici, casa di cui era proprietario il cugino di mio padre, patrono di Bassani. Ancora oggi questa parte della casa è di proprietà dei miei cugini. La parte che noi chiamavamo “il vaticano” perché aveva i grandi affreschi, ora appartiene alla città e all’università; al pian terreno c’è il museo dedicato a Bassani e al primo piano ci sono i grandi affreschi di famiglia.
Naturalmente quello di Bassani è solo un romanzo e non sempre le descrizioni sono puntuali.
Solo da poco ho scoperto la ragione per cui ha scelto questo nome per il romanzo: pare che la sorella minore del suo patrono, avesse conosciuto, al matrimonio dei miei, il fratello di mia madre, di cui si è innamorato e, successivamente, si sono sposati.
Quindi, la sorella minore del suo patrone era Finzi Contini, questo lo avevo sempre pensato e siamo riusciti a verificarlo ora che è morto il figlio. Tra le sue carte abbiamo trovato una lettera a suo padre scritta da Bassani che raccontava questi particolari. Mia madre diceva che il nome poi era stato scelto perché dava un carattere aristocratico, piuttosto decadente.
La casa a Ferrara oggi si chiama Museo Minerbi del Sale perché in tempi antichi quando sono stati fatti gli affreschi apparteneva ad una famiglia che aveva il monopolio del sale sotto gli Estensi”.
Come è nato il suo amore per il diritto e la sua scelta di studio?
“Quando cominciai l’università pensavo di fare matematica perché ero sempre stato molto bravo in questa materia. Mi accorsi che non riuscivo a trovare delle prospettive. Pensai allora di studiare storia perché la storia è stata sempre un mio hobby, ma lasciai anche la storia perché non mi piaceva fare le ricerche, cosi provai economia mi è piaciuta molto e avevo risultati positivi tanto che in Inghilterra, quando avevo solo 23 anni, mi hanno offerto una Fellowship.
Dopo un po’ frequentando la facoltà di economia, sentivo la mancanza degli aspetti teorici che m’interessavano di più e mi pareva di non poter interagire con le persone. Cosi decisi di lasciare anche economia e provare Diritto.
Quando arrivai a New Haven nel 1955, per guadagnare un po’ di soldi, cominciai ad insegnare economia, ma lo feci anche perché gli economisti cercarono di attrarmi.
Insegnare mi piacque moltissimo, e per questo che ho scelto di fare l’insegnante. Contemporaneamente cominciai a studiare anche diritto e mi accorsi subito che il diritto era la mia materia; capivo tutto, guardavo e vedevo tutto, potevo fare lavori teorici, ed era un campo dove c’era la necessità del rigore e anche la necessità di trattare con la gente, e poterla aiutare. Mi ha dato grande soddisfazione sin dall’inizio”.

Lei ha insegnato per molti anni all’Università di Yale. Ci racconti della sua esperienza di docente e della sua relazione con gli studenti.
“Quando ho cominciato ad insegnare mi è piaciuto subito ma avevo un po’ d’incertezza, non ero sicuro che avessi tanto da trasmettere. Quando affermo questo molti ridono perché ho scritto tanto e sono abbastanza famoso, ma è stato proprio il rapporto con gli studenti che ha rafforzato il mio desiderio d’insegnare. Mi volevano bene, e io volevo bene a loro e avevo una capacità di farli fiorire, di fare una specie di appello ai loro ideali che fossero di sinistra o di destra non importa; era importante far capire loro che si può fare il bene comune, a prescindere da come uno la pensa. Ecco perché insegno ancora, nonostante la mia anzianità. L’estate scorsa i miei studenti mi hanno chiesto di essere l’oratore alla cerimonia di consegna dei loro diplomi. Altri miei studenti che erano a Yale quando io insegnavo economia e si laurearono nel 1959, in occasione di una loro recente riunione qui a Yale, dopo sessant’anni si sono ricordati di me e mi hanno invitato e voluto loro ospite”.
Lei ha mantenuto contatti con il mondo universitario italiano e ha avuto modo di incontrare personalità di rilievo. Ci ricorda qualche incontro importante?
“In Italia ho avuto contatti con grandissime personalità; la prima laurea Honoris Causa che ho avuto in Italia mi è stata data dall’Università di Torino ed i due relatori erano Rodolfo Sacco, giurista, grandissimo professore di diritto comparato che è ancora vivo ed ha quasi cent’anni, e Norberto Bobbio, filosofo storico e politologo italiano. Altre personalità con cui ho avuto contatti molto stretti, sono stati Stefano Rodotà che era un grande giurista maestro di sinistra, che purtroppo, quando la destra lo voleva come presidente della Repubblica, la sinistra non lo ha voluto perché era troppo indipendente; Guido Rossi, grandissimo avvocato che è morto pochi anni fa, lui aveva una collezione d’arte fantastica. Tutti molto miei amici, anche Sabino Cassese e Giuliano Amato ex presidente del Consiglio dei Ministri, Franco Modigliani grande economista Premio Nobel, sua moglie era una cugina lontana di mia madre, le loro bisnonne erano sorelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver letto il mio libro mi ha chiesto di andarlo a trovare e fare due chiacchiere con lui al Quirinale e anche Marta Cartabia, recentemente nominata nuova presidente della Corte Costituzionale in Italia, l’ho sempre invitata a Yale, alla conferenza “Guido Calabresi” su “Diritto e religione”.
Nel 1985, qui a Yale ho ospitato anche il presidente della Repubblica Francesco Cossiga.
Posso dire in un certo senso di far parte dell’ambiente accademico italiano, quanto lo sono qui. Una volta incontrai un barone accademico che aveva tanti allievi, appena mi vide mi disse: “Calabresi, lei ha più studenti in Italia di me!”. Io gli dissi ridendo: “sono ragazzi che son venuti in America a studiare con me e son tornati in Italia”. Quindi c’è stato sempre un buon e bel rapporto. Mia moglie che è americanissima, discendente dalla nonna di Elihu Yale e del primo governatore di New Haven dice sempre: “Quando sono in Italia non appena si arriva qui si diventa completamente Italiani””.

Come è riuscito a gestire tutto in tutti questi anni professore, scrittore, preside della facoltà di legge a Yale e oggi, giudice della Corte d’Appello federale?
“Una volta quand’ero preside, il mio vice preside mi ha visto correre da una parte all’altra mentre mormoravo qualcosa e mi ha chiesto: “cosa dici?”. Io ridendo gli risposi: “sto ringraziando Dio che mi ha fatto svelto e veloce”. Agli italiani piace essere svelti e veloci, io riesco a fare tutte queste cose perché Dio mi ha creato svelto e se andassi adagio non mi farebbe bene; dà un enorme soddisfazione poter fare l’insegnante, lo studioso e il giudice tutte queste cose insieme e ancora lo faccio perché ho ancora la sveltezza. È il mio modo di essere italiano”.
Cosa pensa della giustizia italiana? Può fare un confronto con quella americana?
“La procedura della giustizia americana in molti casi mi sembra sia migliore. Quella italiana invece è più lenta e contorta, ci vuole molto tempo per risolvere le questioni. La procedura americana è più svelta e meno burocratica, ma spesso la sostanza del diritto italiano è migliore, Il diritto penale è molto più sensibile ai bisogni della gente. Forse, guardando alla sostanza del diritto italiano, è preferibile rispetto a quello americano.
Per esempio, in Italia a livello costituzionale c’è l’idea che è stata accettata in tutta l”Europa di suggerire ai legislatori di cambiare alcune leggi che al momento sono state superate e col passare del tempo diventano sempre meno applicabili. In America questo concetto non c’è, aiuterebbe moltissimo perché le cose cambiano. In America, quando la legge è invalida o dubbia, diventa inefficace e i giudici spesso non sono in grado di cambiarla, ma non si rivolgono ai legislatori”.

Come ha vissuto il suo essere italiano in America e cosa pensa dell’Italia di oggi?
“Una delle cose più belle nella mia vita è stato poter essere sia americano che italiano. Ricordo che molto tempo fa ho avuto degli studenti stranieri e uno di questi che veniva dal Pakistan mi chiese: “ma lei è italiano o americano?” Ed io gli ho detto di essere sia italiano che americano. Lui insistendo mi chiese: “nei mondiali di calcio lei per chi tifa? Ed io: “per l’Italia, ma non necessariamente perché l’Italia gioca bene, ma perché è una cosa italiana e quando c’è qualche cosa italiana mi sento completamente italiano. Se ci fossero i mondiali di Baseball tiferei per l’America”. Ed è anche stato proprio per questo che sono riuscito a fare molte cose nella mia vita sia qui che in Italia.
Quando sono venuto a New Haven, gli Italiani erano considerati il peggio del peggio, era un momento poco bello. Infatti, prima che arrivassimo noi, nel 1938 il sindaco Celentano, perse le prime elezioni proprio per il razzismo enorme contro gli italiani. Noi siamo arrivati dal nord Italia e qui erano tutti del meridione, e dal momento che eravamo collegati con l’università siamo stati gli unici italiani a creare un ponte tra i Yankees universitari e l’Italia. Mia madre è diventata cavaliere in Italia per il suo lavoro qui e in Italia. Oggi la posizione degli italiani è cambiata molto, ma per gli italiani in America, la situazione è un po’ complicata perché c’è ancora tanto pregiudizio. Io dico anche che noi italiani facciamo un grande sbaglio. Molti italiani sia in Italia che qui parlano male dell’Italia, dicono cose negative, questo non funziona, questo fa male e gli americani ci credono. I francesi invece, al contrario parlano sempre bene della Francia e gli americani ci credono.
Se invece parlassimo delle eccellenze italiane e dicessimo …..sai che i treni in Italia sono una cosa incredibile, vorrei che ci fossero anche in America i treni cosi, il servizio medico in Italia è fantastico gli americani rimarrebbero a bocca aperta. Queste sono cose di cui dovremmo parlarne spesso, senza falsi orgogli ma dire quello che c’è veramente”.











