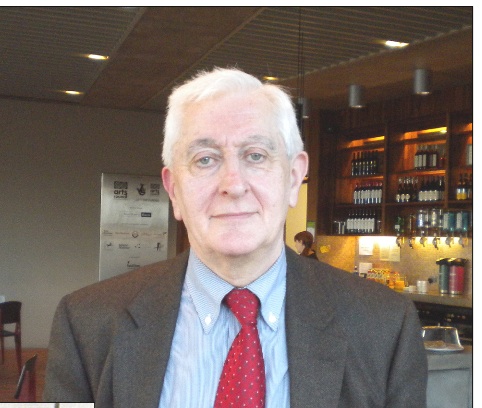Irlanda del Nord, terra di lotta cruenta per la libertà e l’indipendenza, di un Paese che si è a lungo sognato affrancato dalla colonizzazione britannica, che forse non ha Ia mai smesso di contestare alla parte protestante unionista la dipendenza dall’Inghilterra. Terra di trasformazione, di conflitti sedati, di accordi raggiunti che vogliono mostrare un altro volto del Paese, pacificato e in cammino verso una convivenza auspicata, dopo il tempo severo e tragico di guerre civili e morti, terrore e sangue come il Bloody Sunday del ’72 sta a testimoniare, affinché la memoria sia d’ammonimento a chi oggi, forse con superficialità, parla di pace e di “normalità”.
La dichiarazione d’indipendenza venne proclamata dal Parlamento irlandese nel gennaio del 1919, ma l’accordo anglo-irlandese del ’21 limitò il nuovo Stato libero dell’isola, divisa tra Irish Free State e Northern Ireland, dipendente dalla sovranità britannica. Tutto il ventesimo secolo racconta di uno Stato attraversato più volte da guerre civili, determinate da questa dipendenza che ha fatto la storia d’Irlanda, rimasta fuori dal secondo conflitto mondiale, non allineata durante gli anni della guerra fredda.
L’ingresso nel ’73 nella Comunità Economica Europea segnò una svolta, ma non interferì con il “Problema Nazionale Irlandese” culminato nel ’69 nei Troubles, turbolenze, in realtà trenta anni di guerra civile che ha causato oltre tremilacinquecento morti e decine di migliaia di feriti, tra forze protestanti e cattoliche. Il dieci aprile del ’98 si compie quel Good Friday Agreemente che ha creato un clima di speranza per il futuro del Paese, sancendo la suddivisione dei poteri tra le varie fazioni politiche all’interno della Northern Ireland Assembly, ma la speranza venne meno nel 2002, quando crollarono le istituzioni nate dagli “Accordi del Venerdì Santo” e venne ripristinata l’amministrazione diretta di Londra. Nell’Ulster non esiste una nazione o un popolo nord-irlandese perché vi convivono due realtà diverse, la protestante unionista e la cattolica nazionalista, quest’ultima, minoranza, guarda all’integrazione delle sei contee nord-irlandesi nella Repubblica d’Irlanda (Eire). Sinn Fèin, in gaelico, lingua ufficiale insieme all’inglese, significa Solo Noi, è il partito repubblicano più forte tra gli elettori cattolici nord-irlandesi e il secondo più importante nell’Irlanda del Nord, dopo il Democratic Unionist Party.
Il Sinn Fèin, nato nel ’70, da quasi trent’anni guidato da Gerry Adams, è stato visto da sempre come l’ala politica dell’Ira (Irish RepublicanArmy), divenne politicamente più influente nell’81, con l’elezione al Parlamento Britannico di Bobby Sands, detenuto nel carcere di Maze a Long Kesh, dove morì, nel maggio ’81, dopo sessantasei giorni di sciopero della fame, senza aver mai varcato l’aula parlamentare. L’Ira nel 2005 ha posto fine alla lotta armata, smantellando il proprio arsenale militare, e, sull’onda di questa svolta, l’otto maggio del 2007 il predicatore protestante e leader del Democratic Unionist Party, reverendo Jan Paisley, e Martin Mc Guinness, deputato del Sinn Fèin ed ex comandante dell’Ira, sono divenuti rispettivamente primo ministro e suo vice, insediandosi a Stormont, per la conduzione di un governo congiunto.
Tuttavia a Belfast le “linee di pace” ancora separano le comunità protestante e cattolica, mentre lo scorso autunno è stata aperta una barriera nel “muro di pace” che divide Alexandra Park, permettendo a cattolici e protestanti di mischiarsi almeno durante il giorno, ma è sufficiente girare la città, che ha ancora in piedi i suoi novantanove “muri di pace” per constatare l’evidenza di comunità lacerate dall’odio.
Ne è consapevole anche Leo D’Agostino, console onorario a Belfast, originario di Casalattico, in provincia di Frosinone, terra d’immigrazione, che ha trovato nell’Irlanda una benevola terra d’accoglienza.
Da quanto tempo è a Belfast?
«Da una vita intera, ho fatto le scuole qui, mi sono laureato qui, ho vissuto sempre qui».
Quando è stato nominato console onorario?
«Da quasi vent’anni, dipendo dal Consolato di Edimburgo e anche dall’Ambasciata italiana a Londra».
Fu una vera svolta l’accordo del 2007 tra Sinn Fèin e Democratic Unionist Party?
«La firma per l’”accordo del venerdì santo” risale al ’98, nel 2007 ci fu l’accordo sulla giustizia e la polizia. Si deve dire che negli ultimi dodici anni e anche prima si è fatto sempre un po’ di progresso, tre passi in avanti e uno indietro, lentamente qualche parvenza di normalità esteriore prende corpo nella vita quotidiana dell’Irlanda del Nord, venti anni fa vi era una situazione che sfiorava la guerra civile, avevamo l’esercito per le strade, parecchi gruppi paramilitari erano in azione, ora si gira per le strade tranquillamente, oggi è tutto abbastanza normale. Dovremmo riflettere sulla parola “cattolico” che, in realtà, è un codice politico, che sta per nazionalista, anche la parola “protestante” è un codice politico, sta per unionista, cioè unione con il Regno Unito».
La realtà è che a Belfast ai protestanti e ai cattolici corrispondono classi sociali diverse.
«Non è più così netto, prima degli anni Settanta, quando iniziò la protesta, lo scoppio dei Troubles, c’era una borghesia nei quartieri protestanti, che erano l’80%; per i cattolici allora c’erano pochissime possibilità di miglioramento, ora questa possibilità c’è perché il governo britannico capì subito, dopo il ’69, che le cose non potevano andare avanti in quel modo, per cui già dagli anni Settanta il governo laburista di Welles aveva introdotto un pacchetto di riforme sull’edilizia, sulle pari opportunità, investimenti per cui già negli anni Settanta si cominciava a vedere una differenza».
Bambini in uno dei quartieri cattolici di Belfast
Si può dire che la società è pacificata, che si è arrivati alla comprensione reciproca?
«Si è compiuto un processo politico che ha avuto molto successo, tuttavia non credo che si possa ancora dire che abbiamo compiuto un processo di pace, come dire che il processo politico dall’alto è andato molto bene, invece, dal basso ancora continua ad esistere quella mentalità settaria, propria dei quartieri più poveri. La prova di ciò è che dal ’97 hanno eretto più muri di prima per separare i quartieri protestanti dai cattolici. La cosa più deprimente è incontrare ancora persone, anche tra i cattolici, che vogliono la presenza dei muri, alcuni protestanti che hanno sempre vissuto qui, si considerano britannici e vogliono i militari per le strade. Accadono ancora episodi che rivelano l’odio tra le due comunità, odio che cresce nei luoghi del disagio, dunque non possiamo dire che qui la pace sia una missione compiuta. Ci vogliono investimenti per rilanciare questi quartieri sul piano del lavoro, sul piano sociale, per incoraggiare le persone! So di protestanti che non ture religiose, da questo punto di vista è un passo avanti».
Qual è stato l’impatto della crisi economico-finanziaria del 2008 in Irlanda?
«E’ aumentata soprattutto la disoccupazione giovanile nei quartieri di Belfast, ma anche a Derry, arriva ad una percentuale spaventosa, la tentazione, il pericolo è che tanti giovani vadano a finire nelle mani di questi gruppi paramilitari che vanno ancora in giro e sono abbastanza attivi, creando una situazione fortemente a rischio».
La presenza di questi gruppi paramilitari è ancora forte?
«Diciamo che non è forte, per la parte repubblicana, ad esempio, ci sono ben tre gruppi diversi che vogliono continuare la lotta contro la presenza militare britannica, ma non hanno appoggio elettorale, nelle comunità sono forse un po’ di più, la settimana scorsa a Derry hanno piantato due bombe nell’ufficio del Turismo, non sono scoppiate perché scoperte
e disinnescate in tempo, anche a Belfast ogni tanto ci provano, qualche settimana fa hanno messo una bomba sotto l’automobile di un poliziotto, anche lui scampato per poco alla morte. I gruppi paramilitari non godono di molto appoggio, però hanno un appoggio sufficiente per continuare a creare queste tensioni, qualche attentato, qualche autobomba, ma rispetto all’Ira, e al potere militare che poteva esprimere, questi sono poca cosa».
Sono gruppi che hanno avvertito come un tradimento la posizione assunta dall’Ira negli accordi di pace?
«Sicuramente, infatti i militanti dello Sinn Fèin adesso si muovono nel disagio, una volta erano quasi padroni, ora no perché all’interno della comunità repubblicana c’è questo forte senso di tradimento tra i militanti».
Si ricorda una storia diversa in questo Paese?
«Questa storia dice, però, che il governo britannico è stato una forza positiva per l’Irlanda, Tony Blair si è impegnato moltissimo per favorire il processo di pace, con Tony Blair la Gran Bretagna si è liberata da una visione faziosa e settaria e si è posta con forza come fautrice della convivenza. C’è una lunga lista di leggi che proibiscono la discriminazioni, l’esercito del Nord Irlanda non è più quello che è stato, la maggior parte dei contendenti riconosce che oggi c’è un ventaglio di opportunità, molti cattolici occupano posti importanti nella società».
Possiamo dire con certezza che non si tornerà indietro?
«Non si torna indietro, i caratteri dell’accordo di pace del governo irlandese hanno una democraticità evidente, Blair non ha sostenuto la posizione classica unionista e ha imposto la collaborazione con Dublino».
E’ stato facile portare l’Ira a questa posizione?
«Facile no, ci sono voluti almeno un paio d’anni per condurre l’Ira alla posizione di dover cedere, c’è stato forte dibattito al suo interno, e i contrasti determinatisi hanno dato origine ai gruppi paramilitari di oggi, loro considerano il possesso delle armi una cosa sacrosanta. L’altro punto fondamentale per i cattolici è di accettare il diritto dei protestanti di rimanere parte del Regno Unito».
La decisione di liberare i detenuti dell’Ira era nella clausola dell’accordo di pace?
«Sì, hanno liberato tutti coloro che erano stati coinvolti nella lotta armata, dunque anche unionisti, la borghesia ne è rimasta sconvolta, si tratta di persone colpevoli di fatti atroci, ma il grande segnale di apertura era liberare tutti, con ciò si è voluto sanare tutte le ferite del passato».
Però i muri che separano i quartieri rivelano tutta la fragilità di questa pace.
«Anche le scuole sono separate, abbiamo scuole cattoliche, poi scuole statali protestanti, per cui questi bambini, questi allievi non si incontrano mai. Un conflitto, quello dell’Irlanda del Nord, che non è mai stato teologico, bensì politico e di classe, per cui quando parliamo di cattolici e di protestanti, stiamo parlando di posizioni politiche e di classi sociali».