Umberto Eco è un gigante della cultura italiana e le critiche eccellenti che il suo ultimo romanzo edito da Bompiani, Numero zero, ha collezionato – ad esempio quella di Goffredo Fofi – non scalfiscono minimamente tale verità. Pur essendo un accademico di formazione – ma la sua verve era già emersa nella celebre fenomenologia di Mike Bongiorno del 1961 – Eco è sempre riuscito a costruire romanzi avvincenti, al tempo stesso colti e popolari, soprattutto attenti alla trama, e quindi, al piacere di chi legge. In fin dei conti, nella sua prima fiction, Il nome della Rosa, ci ha tenuti inchiodati ad una storia che girava attorno all’idea di una serie di delitti commessi per un libro (di Aristotele, avente per tema la commedia! Quanto attuali sono quelle pagine oggi…).
La sua nuova opera letteraria è più breve delle maggior parte delle precedenti. È ambientata nel 1992, all’epoca del crollo della Prima Repubblica e delle stragi di mafia, mentre stava per iniziare la lunga stagione del berlusconismo. Tuttavia, il tema centrale riporta per molti versi ad un romanzo del passato, Il pendolo di Foucault, il secondo dei sette di Eco: ci riferiamo al tema del complotto. Nel Pendolo avevamo un gruppo di studiosi che, un po’ per gioco, un po’ sul serio, ricostruiva un pezzo di storia dell’Europa e del mondo alla luce delle dottrine esoteriche, finendo poi vittima di chi a quelle dottrine credeva ciecamente (e la cosa paradossale fu che dopo la pubblicazione del libro nacquero un po’ ovunque nel “mondo reale” nuovi circoli esoterici e neo-Templari, segno che spesso il lettore non capisce nulla del messaggio contenuto nei libri).
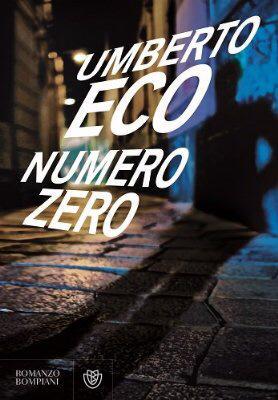 Questa volta abbiamo un giornalista e ghost writer (“negro”, si diceva un tempo) cinquantenne, deluso dalla vita, che viene incaricato, per una cifra notevole – 6 milioni al mese delle vecchie lirette – di scrivere la storia di una nuova testata in realtà mai arrivata in edicola. La testata, affidata a una pattuglia di giornalisti o aspiranti tali, come ce n’è ovunque nel mondo delle redazioni, è il parto di un imprenditore spregiudicato, il commendator Vimercate, con le mani in pasta in tanti business diversi. Si tratterebbe, più che di un giornale, di una “macchina del fango”, che racconti, diciamo così, l’altra verità, quella che potrebbe essere davvero vera ma che in realtà è spesso davvero falsa, ovvero costruita ad arte per insinuare il dubbio nel lettore e screditare – o ricattare – il personaggio di turno. L’obiettivo di Vimercate è usare questo strumento per avere accesso ai grandi giri, per farsi strada a colpi di scoop più minacciati che realmente dati alle stampe nella giungla affaristico-politica.
Questa volta abbiamo un giornalista e ghost writer (“negro”, si diceva un tempo) cinquantenne, deluso dalla vita, che viene incaricato, per una cifra notevole – 6 milioni al mese delle vecchie lirette – di scrivere la storia di una nuova testata in realtà mai arrivata in edicola. La testata, affidata a una pattuglia di giornalisti o aspiranti tali, come ce n’è ovunque nel mondo delle redazioni, è il parto di un imprenditore spregiudicato, il commendator Vimercate, con le mani in pasta in tanti business diversi. Si tratterebbe, più che di un giornale, di una “macchina del fango”, che racconti, diciamo così, l’altra verità, quella che potrebbe essere davvero vera ma che in realtà è spesso davvero falsa, ovvero costruita ad arte per insinuare il dubbio nel lettore e screditare – o ricattare – il personaggio di turno. L’obiettivo di Vimercate è usare questo strumento per avere accesso ai grandi giri, per farsi strada a colpi di scoop più minacciati che realmente dati alle stampe nella giungla affaristico-politica.
A ben guardare, l’ambizione di svelare ciò che si nasconde dietro ai fatti, di scrivere addirittura la “controstoria d’Italia”, è parte integrante del nostro giornalismo, basti pensare al mito di Montanelli. Ad essa l’italiano medio sembra essere particolarmente sensibile, forse a causa della sua sfiducia nelle verità ufficiali. Un riflesso, questo, della sua più generale sfiducia nei confronti delle istituzioni. Su queste stesse qualità, che marchiano in maniera indelebile il tipo-italico, facendone un modello antropologico riconoscibilissimo, poggia anche il successo dell’informazione fasulla, che fabbrica complotti, altarini, leggende metropolitane, e che scatena a volte passioni fortissime.
I protagonisti del romanzo di Eco maneggiano fatti reali, come quelli legati alla Gladio o alla P2, per rileggere vicende chiave della storia del Belpaese, ipotizzando ad esempio che Mussolini non sia stato effettivamente ucciso e poi appeso per i piedi all’insegna di un distributore ma sia scappato in Argentina, lasciando dietro di sé il cadavere di un sosia. Baggianate, diremmo. E tuttavia, rimane il fatto che i misteri irrisolti esistono, la recente storia d’Italia, specie quella più dolorosa, ne è piena. Così come esistono, fra tanti complotti finti o solo presunti, anche complotti reali, e che di fronte ad un inappuntabile documentario della BBC non si può far finta di non vederli.
Come sempre con Eco siamo di fronte ad un romanzo che si presta a più livelli di lettura. Il piacere della narrazione si coniuga con la passione civile e con il bisogno di confrontarsi con tematiche di attualità. Non solo quelle legate alla stagione di Tangentopoli, anche quelle che riguardano il mondo dei media come lo conosciamo oggi. Il romanzo, perciò, contiene spunti di interesse generale, ed in questo senso ci ha visto giusto chi lo ha definito un po’ un phamplet: ci parla del giornalismo disonesto o strumentale, ci parla della necessità di verificare le fonti ma anche della difficoltà di farlo bene nell’era di Internet, quando è tanto facile ricostruire una notizia – un complotto, o semplicemente una bufala – con dei clic (vale appena la pena di menzionare che una polemica partita su Twitter ha svelato come lo stesso Eco abbia preso un passaggio del romanzo, riguardante Licio Gelli, direttamente da Wikipedia, cosa che in realtà a chi scrive non sembra per nulla scandalosa).
In fondo è di nuovo quello che facevano, con altri e più sofisticati mezzi, gli studiosi della Cabala, associati in una piccola casa editrice, ne Il Pendolo di Foucault; mettere assieme dati diversi, suggerire diverse relazioni fra cose note. Ed è anche quello a cui i semiologi come Eco si dedicano nelle loro aule universitarie (in questo senso l’ossessione di Eco per i complotti è forse anche un modo per riflettere criticamente sul suo lavoro intellettuale e su quel tanto di arbitrario che esso contiene). Il punto è vedere a cosa porta tutto questo. Quali cause inconfessabili può servire e quali interessi può andare a toccare.
Altro sulla trama non diremo, a parte il fatto che l’azione è ambientata a Milano. Lo stile è quello di sempre, al tempo stesso alto e basso, scorrevole come un giallo ma anche ricco di citazioni (una per tutte: “Chiamatemi Ismaele”). Proprio in questo suo citazionismo, a volte può apparire un po’ retrò, un po’ anni ’90, appunto. Ma questo è Eco, prendere o lasciare. E noi diciamo: prendere. Perché nelle sue pagine ci sono sempre interrogativi che continueranno a lavorare dentro di noi, nella nostra testa. Anche quando saremo passati ad altre letture.
Umberto Eco, Numero zero, Bompiani, 2015. In traduzione un po’ ovunque nel mondo.












