L’Odissea è il racconto di un viaggio intorno alla Sicilia e Ulisse può essere considerato il primo viaggiatore a fare il Gran Tour dell’isola; le sue impressioni della terra dei Ciclopi sono una descrizione delle ricche terre vulcaniche ai piedi dell’Etna, dove gli abitanti «…fidando nei numi immortali, non piantano pianta di loro mano, non arano; ma inseminato e inarato là tutto nasce, grano, orzo, viti, che portano il vino nei grappoli, e a loro li gonfia la pioggia di Zeus». I versi omerici ci introducono così ad uno fra i leitmotiv più frequenti nelle osservazioni dei viaggiatori stranieri che attraverso i secoli hanno girato per la Sicilia, guardando con stupore i fenomeni che i siciliani danno per scontati, assaggiando come novità i cibi a loro quotidiani, rimanendo a volte incantati, a volte inorriditi, ma sempre annotando in diari e lettere le loro impressioni, e fornendo una preziosa fonte per la storia culinaria dell’isola.
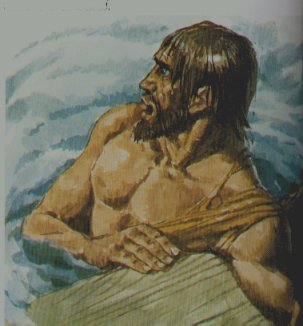
La fecondità di una terra che produce senza fatica, come descrivono i versi omerici, è un tema predominante, o meglio, un tema che si alterna con quello della povertà: la Sicilia è spesso vista come una terra di estremi, dove l’opulenza contrasta con la scarsezza, e lo sfarzo più sregolato convive con la miseria più nera. Una Sicilia allegra luminosa festosa da una parte, cupa amara malinconica dall’altra. Un’isola nell’isola, con una sorprendente varietà di razze umane, di culture e di paesaggi, che fanno di questa regione un continente, ancora oggi, non sempre facilmente decifrabile.
Uno dei primi, e forse il più insigne, dei visitatori a rimarcare gli eccessi siciliani fu Platone, a cui in verità l’isola piacque poco:
«“la vita beata”, come viene chiamata lì, strapiena come è di banchetti italiani e siracusani: si passa la vita nell’abbuffarsi due volte al giorno, la notte non si dorme mai senza compagnia, e si ci dedica a tutte quelle abitudini che accompagnano un tale stile di vita»2.
Quelli che vennero dopo di lui s’indignarono di meno, ma non mancarono di registrare lo sfarzo quando lo incontravano, sia nelle case aristocratiche che nei refettori monacali. In questo caso, le parole di W.H. Smyth in Memoir descriptive of the resources, inhabitants and hydrography of Sicily and its Island:
«La voglia di eccellere nella grandezza del pesce da servire per le occasioni importanti persiste ancora, e io vidi il defunto principe di Butera, che più di qualunque altro capiva la buona ospitalità, disporre un tonno intero, guarnito tutto attorno come fosse un muletto e messo come un leviathan al centro della sua tavola festiva».
Maggiore stupore si registrava di fronte ai pasti consumati nelle istituzioni ecclesiastiche, o almeno in quelle appartenenti agli ordini aristocratici. Se i frati agostiniani di Taormina offrivano un pasto umile (ma apprezzato) ai loro visitatori – pane, latte di capra e miele – un pranzo nell’Abbazia di San Martino delle Scale a poca distanza da Palermo, come spiega A.J. Strutt in A Pedestrian Tour in Calabria and Sicily, era tutt’altra cosa:
«I benedettini hanno fama di vivere bene, e il menù servitoci non smentisce questa reputazione… In primis – niente minestra – piattini di acciughe, prosciutto, olive condite, e salame; un piatto dolce di frittelle; poi una grande aragosta, o piuttosto un pesce simile ad un gambero gigante in quanto gli mancavano le chele; pasticcio di maccheroni con regaglie, un infreddo (qualcosa simile al bollito) in gelatina; pollo arrosto e insalata; un piatto, una specie di pan di spagna, guarnito di una crema dolce, rossa e bianca, il quale ho saputo a mia sorpresa era fatto di patate; budino e dessert…».
Si nota spesso la differenza fra la dieta cittadina, segnata da grande abbondanza e varietà del cibo, e la difficoltà di reperire qualcosa da mangiare nei villaggi dell’interno, dove il cibo scarseggiava e il pane era “così nero e acido, che dovesse arrivare su una tavola inglese, troverebbe pochissimi clienti”. Se i visitatori del primo Seicento restano ammirati delle ricchezze e del benessere che vedono nelle città costiere, e colpiti dalla fertilità delle pianure, dove cresce soltanto il frumento rosso e il miglior pane, i diari dei secoli seguenti riflettono una situazione diventata sempre più drammatica nell’interno dell’isola.
Mentre i viaggiatori in cerca del pittoresco non mancano di descrivere con dovizia di particolari ed entusiasmo le bancarelle dei fruttivendoli, di cui esaltano la ricca varietà, i colori esuberanti, la cura espositiva, il consumo di tali verdure viene sempre giudicato eccessivo e nocivo alla salute, sia da un inglese dell’Ottocento che da uno che avrebbe dovuto meglio intendere la dieta mediterranea, come Ibn Hawqal, arabo del X secolo che nel suo Libro delle vie e dei reami denuncia i gravi danni recati ai palermitani a causa di un eccessivo consumo di cipolle:
«…E veramente codesto cibo, di cui son ghiotti e il prendon crudo, lor guasta i sensi…Ecco ciò che ha offuscata la loro immaginativa; offesi i cervelli; perturbati i sensi, alterate le intelligenze…».
Peggio ancora l’abuso del finocchio e del sedano, alimenti preponderanti nella dieta siciliana secondo il francese Pietro di Blois, che scrivendo due secoli dopo ammonisce che “ciò genera un umore che putrefa il corpo e lo porta agli estremi di malattia e morte”.
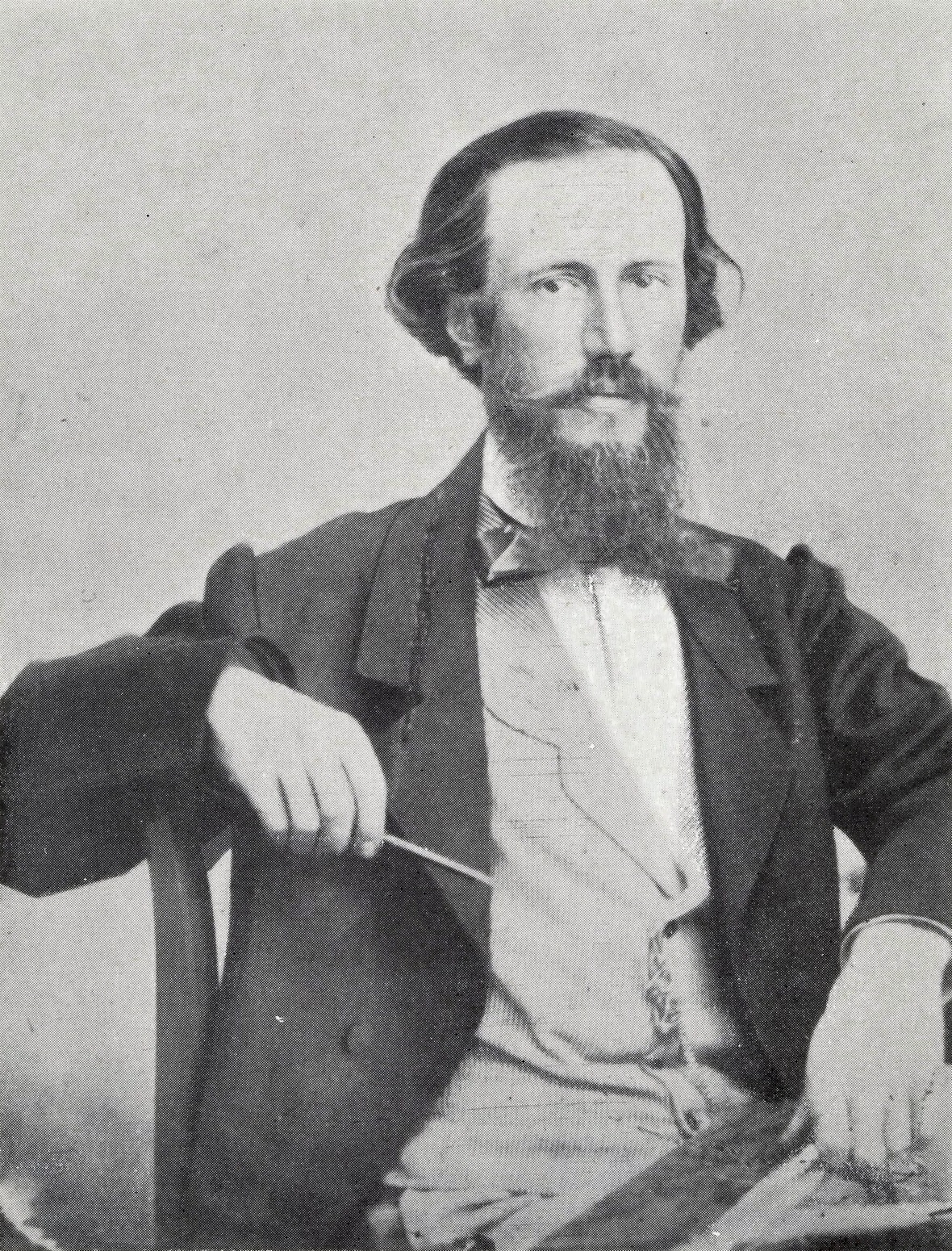
La pasta è un altro alimento che affascina i visitatori del Nord Europa. Verso la fine del Settecento i maccheroni erano arrivati nei cafè eleganti di Parigi e soprattutto in Inghilterra, dove il poeta Byron ne cantò le lodi. Alcuni viaggiatori si lamentavano di non poter trovare altro da mangiare in Sicilia, ma altri ne rimangono entusiasti, come Goethe9, che intraprende il suo famoso viaggio nell’isola dopo aver letto Brydone. Tuttavia, egli non dice nulla su come gli hanno servito la pasta o con quale condimento né è facile sapere come il pomodoro, portato dal Nuovo Mondo dagli spagnoli per essere coltivato come pianta ornamentale nei giardini aristocratici del Cinquecento, sia stato gradualmente ammesso agli onori della cucina. Brydone dice d’aver visto i pomodori coltivati nei campi fra Siracusa e Catania, ma forse il primo viaggiatore a raccontare di averli mangiati, anche senza capire cosa fossero, fu George French Angas, che dà una divertente descrizione di come nel 1841 si serviva la pasta nel villaggio di Scaletta, che era il punto di partenza per la salita sull’Etna, impresa obbligatoria per qualunque turista che si rispettasse:
«Una volta seduto, la buona donna ha versato un rotolo di maccheroni in un grande piatto, che pensavo fosse per me ma con mia sorpresa e meraviglia, fu circondato da tutta la famiglia, che cominciò a demolirlo con forchette di legno, prima riempiendo la bocca il più possibile, poi con destrezza spingendo dentro i filamenti pendenti con le dita. Questo è il vero modo siciliano di mangiare la pasta…Un secondo pasto è stato preparato per me, che la mia oste servì in un piattone di legno, e senza cerimonia e nemmeno chiedendo il mio parere in materia, essa ci versò sopra della tomata, ossia salsa di peperoni dolci, fritti in olio».
I viaggiatori britannici scrivono parecchio a proposito della beefsteak, la cui mancanza li lascia sconsolati, mentre saperla preparare a modo diventa la carta vincente per l’Albergo del Sole a Siracusa, il cui oste – molto lodato – ha imparato il suo mestiere al servizio della Marina inglese. Dove non trovano la bistecca, gli inglesi si accontentano del tonno, gradito sia nel Settecento da Brydone che all’inizio del Seicento da Sandys, proprio per la sua somiglianza con la carne tanto rimpianta. I viaggiatori in genere sanno apprezzare un buon pesce, e addirittura rimangono affascinati dai riti con cui viene pescato, venduto o conservato. Già nel 1682 Ellis Veryard resta colpito da come si svolge la pesca del pescespada nello Stretto di Messina, dove le barche dei pescatori sono guidate dalle grida degli avvistatori a terra, e quasi cento anni dopo Brydone descrive una scena molto simile:
«La presa del pesce spada è uno sport nobile; non si usa nessun’arte per intrappolarlo, ma con un piccolo arpione attaccato a una lunghissima corda, lo attaccano in mare aperto…una caccia alla balena in miniatura. I pescatori siciliani (che sono molto superstiziosi) hanno una frase greca che usano come incantesimo per farlo avvicinare alle loro barche. Questa frase è la loro unica esca…».

La pesca meno nobile con cui Brydone fa il confronto è quella del tonno, che attira l’attenzione degli stranieri sia per la sua complessità che per l’aspetto cruento. Di essa il pittore Jean Houel coglie dettagli molto particolari e insoliti:
«…Dopo l’Arcivescovo, è il turno del Grande Ammiraglio; egli detiene il diritto di scegliere il migliore tonno su ogni sessanta…Infine, mentre i pesci che rimangono vengono tagliati, salati e messi in barili, arriva una folla di parassiti. Questi sono le nuvole di cappuccini, di francescani, e d’altri ordini di penitenti ed eremiti, che rassomigliano piuttosto alle vespe che si raccolgono per rubare il miele dall’alveare. Senza alcun pudore attribuiscono a sé il buon esito della pesca: senza le loro preghiere non sarebbe riuscita, i pesci avrebbero preso un’altra rotta, le reti sarebbero strappate. La sfrontatezza con cui fanno queste affermazioni, con voci pie e melliflue, persuade i poveri pescatori ignoranti…che vengono alleggeriti di buona parte dei frutti delle loro fatiche».
Sono pochissimi i riferimenti alla pasticceria, settore in cui la Sicilia aveva acquisito fama da secoli. Già nel II secolo d.C. Alcifrone ci parla di “una torta, del tipo che prende nome da Gelone il Siceliota, alla vista di cui il mio cuore si dilettava e la bocca aveva l’acquolina…ornata con prelibatezze – pistacchi, datteri e noci”. Questo vuoto è poi tanto più notevole se si pensa che più tardi, quando i piatti siciliani cominciarono ad emigrare dall’isola, i primi in assoluto a raggiungere celebrità mondiale sono stati il cannolo e la cassata. D’altronde molti di questi viaggiatori sono arrivati o nel Settecento o nei primi decenni dell’Ottocento, quando le grandi pasticcerie commerciali non si erano ancora affacciate al mercato e l’arte della pasticceria era rinchiusa nei monasteri femminili, ognuno dei quali aveva un “piatto” identificativo e i dolci erano legati alla simbologia liturgica scandendo il calendario delle festività cristiane. La tradizione pasticcera isolana deve infatti molto all’inventiva e all’abilità delle monache nel manipolare ingredienti semplici, per ottenere dolci elaborati e ricercati, degni della tavola di un re.
Ad ogni modo, a meno di essere invitati a pranzare in uno dei grandi monasteri o palazzi aristocratici, il turista completava il suo pasto con la frutta, quasi sempre ammirandone la qualità. Un frutto in particolare colpiva per il suo aspetto esotico, il ficodindia, originario del Messico e diffuso a partire dal Cinquecento in Sicilia, dove oltre a rappresentare un elemento costante nel paesaggio naturale, è divenuto anche ricorrente nelle rappresentazioni letterarie e iconografiche dell’isola, fino a diventarne in un certo qual modo il simbolo. Di esso possiamo leggere una poetica descrizione uscita dalla penna del grande romanziere francese Alexandre Dumas: «…manna eterna e continua che la Sicilia offre tanto generosamente sia alla golosa sensualità dei ricchi sia alla fame miserrima del povero…».
Un altro fenomeno culinario che colpisce tutti i viaggiatori che vengono in Sicilia è la passione degli isolani per il gelato, cibo simile alla pasta per l’intensità delle passioni che suscita, sia nel momento di mangiarlo, sia quando se ne discutano le origini. Quasi tutti i visitatori rimangono meravigliati davanti al consumo di gelato in Sicilia: Patrick Brydone riferisce ai suoi lettori che “i villani di questi paesi caldi [Sicilia e Malta] si dilettano con gelati durante la calura estiva, e non c’è intrattenimento offerto dalla nobiltà in cui questi non fanno la parte principale: una carestia di neve, loro stessi dicono, sarebbe più grave che non una carestia di grano o di vino”.

Oggi come ieri la scenografia palermitana più adatta al gelato rimane quella della Marina, dove tutt’ora nelle serate estive la gente affolla le gelaterie sparse sul lungomare, sebbene in modo più “democratico” che non negli anni prima dell’ultima guerra, quando questioni di galateo e di reddito ne determinavano quantità e modalità di consumo. Malgrado ciò, i palermitani godevano del gelato (bombe variegate, spumoni con pan di Spagna, gelati a panetto da affettare come il semifreddo di mandorla) ma anche della freschezza della brezza marina, della bellezza ed eleganza di questo luogo: «la baia adesso è argentata…il mare respira frescura, l’aria è piena di profumo, ogni cosa è intrisa di bellezza, e il cuore e i sensi si aprono alle più tenere e contagiose emozioni. Ora dopo ora passa così, si lascia con rimpianto, e sovente si fa mezzanotte prima che la folla malvolentieri si discioglie, e la Marina rimane deserta fino alla prossima sera».
In conclusione, non è possibile parlare di cucina siciliana come di un’unica entità: le diversità originate dalle differenti influenze culturali, frutto di secoli di dominazioni, si sono incrociate con quelle determinate dalla diversità tra cucina della costa e dell’interno. Pensare alla tradizione gastronomica siciliana è allora come immaginare una tavolozza di colori, tonalità forti accanto a tinte sfumate, un gioco di richiami e di rimandi suggestivi non facilmente decifrabili ma unici e indimenticabili.












