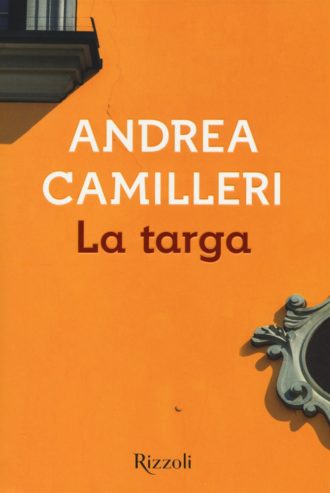
Nell’entroterra ionico dell’isola di Sicilia, là dove il tuono pose il suo passo e l’Ammiraglio divenne Duca, un delicato germoglio sbadiglia tra le pieghe del terreno sciaroso, sfamato dalla lava del vulcano[1]. Nasce qui, infatti, cullata dagli sbuffi dell’Etna e nutrita dall’ardore della pietra catanese, una fra le massime eccellenze dell’industria alimentare italiana: il pistacchio di Bronte.
Sin dall’infanzia quei rugosi semini sono stati per me tra gli sfizi più ricercati. Semplici o salati, tritati o tostati, a condimento di un’insalata o spalmati su una fetta di pane bianco… ho adorato ogni loro espressione, con una singola ma significativa eccezione: il gelato.
La declinazione nevosa del pistacchio, infatti, era recepita dalle mie papille come l’unione di due galassie antitetiche, un affronto che non ero disposto a tollerare e che comportò la decisione di bandire dai miei assaggi quell’oltraggioso dessert. Con simili convinzioni si cresce finché non ci si può più venire a patti, specie se a suffragarle giungono indizi paralleli, all’apparenza distanti eppure fondati sulle medesime strutture.
Culturalmente parlando, ad esempio, mi sono sempre considerato un lettore onnivoro, aperto al dialogo e all’esplorazione dei mondi più disparati; nonostante ciò, tuttavia, non sono mai riuscito a provare sincera attrazione per le opere topiche di Andrea Camilleri. Pur riconoscendone il genio narrativo, infatti, non capivo il motivo delle scelte linguistiche dello scrittore agrigentino che, affondando le proprie trame nel dialetto siculo, sembrava quasi volersi sottrarre a chi non poteva vantare frequentazioni con quell’idioma; anzi, siamo onesti, ritenevo Camilleri ostinatamente colpevole di privarmi delle esperienze a me care di abbandono ludico al mondo del giallo.
Oltre a una buona dose di complottismo, come avrete ormai capito, questa storia è ricca di pregiudizi, dettati in parte da un incontro eccessivamente precoce con il Pasticciaccio di Gadda, in parte generati dalla superficiale lettura di miseri estratti delle inchieste di Montalbano e radicati, soprattutto, da un funesto ingresso adolescenziale in una gelateria della riviera ligure. Con i pregiudizi, tuttavia, ci si deve fare i conti prima o poi, un po’ come con con la bilancia e la mia prova costume si presentò come un opuscolo di sessantasei pagine avvolte in una sovracoperta color caco su cui campeggiava, granata, il titolo: La Targa.
Comparso come allegato al Corriere della Sera del 30 giungo 2011 e abilmente riproposto da Rizzoli in occasione del novantesimo compleanno del suo fumoso autore, tale racconto, sviluppato attorno alla figura di Emanueli Persico – attempato fascista la cui morte innesca un grottesco processo di riesumazione e revisione alla ricerca dell’etichetta più adatta da apporre, appunto, alla targa postuma a lui dedicata -, al primo impatto poteva sì apparire spogliato delle asprezze più acute della parlata di Trinacria, eppure continuava a richiedere l’innegabile adattamento a un ritmo grafico-melodico al quale il lettore doveva essere anzitutto educato.
Dibattendomi in maniera disarmonica tra le onde d’inchiostro, percepivo però il lento assopirsi dello sciocco istinto preventivo che intimava la fuga da quegli esotici capitoli, i cui gorgoglii, anzi, cominciavano ad acquietarsi nella loro sempre più nitida veste di “giallo col sorriso”. In un esile e grottesco gioco da commedia degli equivoci, qualsiasi debolezza costituzionale non imbarazzava, al contrario, era sostenuta proprio da quel mimetismo verbale che prima consideravo avverso e che ora, invece, vedevo ammiccare con toni guasconi verso la perfetta caratterizzazione scenica. E mi perdevo tra il chiacchiericcio dei personaggi, rincorrendone lo sviluppo di pagina in pagina, consumandoli con curiosa avidità.

La Targa si era tradotto nell’entrée ideale alla letteratura di Camilleri, proposto in un formato capace di non risultare indigesto neppure al più reticente dei commensali.
Pur non facendo sussultare per originalità, infatti, il racconto dimostrava come uno spunto minuto potesse divenire insospettabilmente guizzante se governato da un autore capace di rinnovare continuamente un meccanismo che in altre mani avrebbe, invece, presto scocciato. La lingua stessa, protagonista assoluta della pagina camilleriana, scioglieva i suoi nodi, che erano solo apparenti e a cui, anzi, ci si affezionava in maniera inaspettata, giacché proprio tra le pieghe della grammatica sicula affiorava il fedele affresco delle ambiguità umorali del periodo fascista, sfondo della farsesca odissea umana di Emanueli e della sua piccola corte caricaturale.
Terminata la lettura di quell’opuscolo iniziatico, qualche settimana più tardi, tornando dall’ufficio con la schiena leggermente sudata, custodivo nello zaino Un filo di fumo, secondo romanzo di Andrea Camilleri in cui è conservato un curioso glossario che ora non guardo più; il primo editore, Garzanti, aveva voluto inserirlo affinché vi fossero illustrate le numerose voci dialettali utilizzate dall’autore. Era un tardo pomeriggio di fine estate e la mia sete fu attratta dalla vetrina di una pasticceria siciliana, su cui bivaccava la scritta “Granite al Cucchiaio”.
Entrai, ne ordinai una al limone, chiesi una bottiglietta d’acqua frizzante e domandai infine un assaggio di gelato al pistacchio di Bronte… lo amavo.
[1] La città catanese, infatti, si lega al mito del ciclope Bronte, che in greco significa appunto «tuono», ma anche alle gesta del celeberrimo Ammiraglio Nelson, insignito dai Borboni del titolo di Duca di Bronte come pegno di riconoscenza per averne agevolato la fuga da Napoli nel 1799.











