Continuiamo con le riletture estive, dedicate in particolare a romanzi di autori newyorkesi o ambientati a New York. Dopo Henry Miller e Rick Moody questa volta parliamo de La lingua perduta delle gru, di David Leavitt (Pittsburgh, 1961), l’esponente più noto di quella corrente che negli anni ’80 venne definita “minimalista”. Primo romanzo di Leavitt dopo i racconti di Ballo in famiglia, che avevano dato all’autore una grande notorietà sia in America che in Europa, il libro, uscito nel 1986, è al tempo stesso uno specchio della condizione omosessuale in quegli anni – abbondano quindi temi come il coming out, il “dichiararsi” ai propri genitori o amici, ma anche i club, i cinema porno, la minaccia dell'Aids e così via – e uno splendido romanzo sull'amore e la famiglia, così, senza ulteriori aggettivi.
Il titolo scelto da Leavitt si riferisce non alla specie animale, ma ai mezzi meccanici e prende spunto da una piccola “leggenda metropolitana” riportata da uno dei personaggi (non direttamente collegata alla trama, ma che funge da possibile chiave di lettura): un bambino di due anni allevato in un casamento popolare di New York, circondato da cantieri, con una madre che non si curava di lui, aveva imparato ad imitare i movimenti e i rumori delle gru che vedeva affacciandosi alla finestra, e che erano di fatto i suo unici interlocutori. Il senso è: “Ciascuno, a suo modo, trova ciò che deve amare, e lo ama”, e rimanda al relativismo implicito in tutte le scelte, condizionate come sono dall'ambiente e dalle circostanze: “(…) Come dovevano essere parse meravigliose e grandiose quelle gru a Michael, in confronto alle piccole e goffe creature che lo circondavano”. Sembra di sentire i Velvet Undeground che sullo sfondo intonano Some Kinda Love, con quel verso definitivo: “Nessuna specie d'amore è migliore di altre”.
 Leavitt non racconta una storia di degrado sociale e urbano, alla Hubert Selby jr. Come osserva Fernanda Pivano nella prefazione all’edizione italiana del romanzo, è uno scrittore romantico. La vicenda narrata rispecchia questa sua inclinazione e contiene diverse situazioni veramente indimenticabili, in cui la psicologia dei personaggi viene rivelata non da un monologo interiore o dall'occhio onnisciente del narratore, ma dai fatti in sé. E quando questo avviene, la scrittura narrativa dà veramente il suo meglio. I minimalisti vennero definiti tali sia per lo stile – piano, conciso, privo di barocchismi o sperimentazioni esasperate – sia per i temi trattati, orientati all'esplorazione della dimensione familiare ed in generale affettiva (al “privato”, avremmo detto in Italia).
Leavitt non racconta una storia di degrado sociale e urbano, alla Hubert Selby jr. Come osserva Fernanda Pivano nella prefazione all’edizione italiana del romanzo, è uno scrittore romantico. La vicenda narrata rispecchia questa sua inclinazione e contiene diverse situazioni veramente indimenticabili, in cui la psicologia dei personaggi viene rivelata non da un monologo interiore o dall'occhio onnisciente del narratore, ma dai fatti in sé. E quando questo avviene, la scrittura narrativa dà veramente il suo meglio. I minimalisti vennero definiti tali sia per lo stile – piano, conciso, privo di barocchismi o sperimentazioni esasperate – sia per i temi trattati, orientati all'esplorazione della dimensione familiare ed in generale affettiva (al “privato”, avremmo detto in Italia).
In questo libro la protagonista principale è proprio una famiglia: Rose Bejamin, editor, qualche velleità accademica nel suo passato, presto abbandonata, un matrimonio di quieta insoddisfazione; il marito Owen, insegnante, tormentato dai suoi demoni privati; il figlio della coppia, Philip, personaggio principale, che rivelando ai genitori la sua omosessualità costringe il padre a fronteggiare la propria, che ha governato tutta la vita perlopiù con la rimozione e le fantasie. Ci sono poi diversi personaggi minori, a partire da Jerene, afroamericana, esperta di “linguaggi perduti”, messa alla porta dalla famiglia – molto meno tollerante di quella di Philips – dopo il suo outing. Ed inoltre, i due amori di Philip, attraverso i quali il ragazzo impara a conoscersi e a conoscere la vita, delusioni comprese. Sono ben più che semplice contorno e danno spessore alla storia.
Facendo un paragone con altri romanzi del periodo, come ad esempio Altri libertini di Tondelli, la materia dell'omosessualità qui viene trattata con delicatezza, pur se in maniera pienamente realista. Si vedano ad esempio due delle situazioni indimenticabili a cui accennavamo sopra: la prima è l'incontro casuale fra Rose e Owen, una piovosa domenica pomeriggio, all'angolo fra St. Mark's Place e la Second Avenue (ognuno aveva detto all'altro che andava a fare due passi). Marito e moglie, persone che vivono sotto lo stesso tetto, si riscoprono all'improvviso estranei a causa di un evento minore e del tutto imprevisto. Con un filo di imbarazzo. “Ventisette anni di matrimonio – pensa Rose – e questa è la prima volta che ho visto com'è quando pensa che non ci sia, è la prima volta che mi sono imbattuta nella vita che lui conduce da solo”. Una vita – questo Rose ancora non lo sa – che porta spesso il marito nelle strade dei cinema a luci rosse.
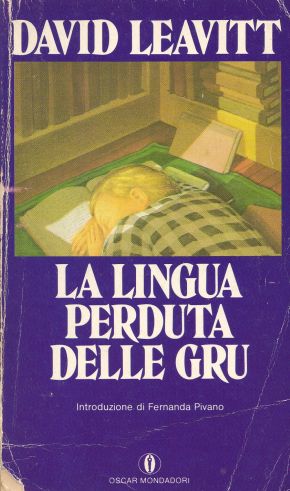 La seconda situazione è l'invito a cena che Owen rivolge a un suo collega insegnante che presume essere gay, dal quale si sente attratto, ma che intende al tempo stesso presentare al figlio come un possibile partner, in uno slancio di liberalità genitoriale. Rose, sulla quale si scaricano tutte le tensioni esistenziali della famiglia, compreso un imminente sfratto, assiste con muta sofferenza allo “spettacolo” del marito e del figlio che cercano entrambi di entrare nelle grazie dell'ospite. E alla fine, dopo averlo incontrato brevemente in cucina, realizza trionfante che lui, almeno lui, non è come loro, è come lei, invece, è “regolare” (per dirla con Delfina Vezzoli, che ha curato la traduzione, leggasi “eterosessuale”).
La seconda situazione è l'invito a cena che Owen rivolge a un suo collega insegnante che presume essere gay, dal quale si sente attratto, ma che intende al tempo stesso presentare al figlio come un possibile partner, in uno slancio di liberalità genitoriale. Rose, sulla quale si scaricano tutte le tensioni esistenziali della famiglia, compreso un imminente sfratto, assiste con muta sofferenza allo “spettacolo” del marito e del figlio che cercano entrambi di entrare nelle grazie dell'ospite. E alla fine, dopo averlo incontrato brevemente in cucina, realizza trionfante che lui, almeno lui, non è come loro, è come lei, invece, è “regolare” (per dirla con Delfina Vezzoli, che ha curato la traduzione, leggasi “eterosessuale”).
Libro dove il mondo gay non viene dipinto come un universo pacificato, attraversato com'è da tensioni, sensi di colpa, segreti che faticano ad uscire e che quando escono mandano in crisi equilibri consolidati, La lingua perduta delle gru regge, mi pare, gli anni passati dalla sua uscita (che per certi romanzi sono un'inezia, ma che per altri, sociologicamente molto caratterizzati, rischiano di essere fatali). Un libro neanche tanto minimalista, considerati i temi senza tempo che affronta: l'amore, la sincerità, la solitudine coniugale, il diritto ad essere felici e ad esprimere liberamente la propria affettività/sessualità, ma anche quello di non accettare necessariamente tutto dagli altri, che è in fondo il diritto che rivendica Rose.
Nel 1991 la BBC ne fece una riduzione televisiva, credo ignorata in Italia.
David Leavitt, La lingua perduta delle gru, Mondadori, 1990.
Originale USA: The Lost Language of Cranes, Bantam, 1987.












