Due scrittori italiani in rapida sequenza, questa settimana e la prossima: prima Kareen De Martin Pinter, nata a Bolzano, attualmente a Strasburgo, a cui seguirà il veneto Matteo Strukul, che sta per approdare anche nel mercato americano (e in altri 15 paesi di lingua inglese fra cui Inghilterra e Australia). Cos'hanno in comune questi due autori, a parte i cognomi strani? Il loro essere relativamente nuovi, ed il loro testimoniare quanto il panorama letterario italiano possa essere vario e vivace anche al di là dei nomi più noti, come i soliti Baricco e Camilleri.
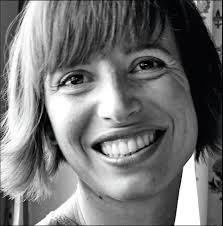
Kareen De Martin Pinter
Il romanzo d’esordio della De Martin Pinter, L’animo leggero, uscito lo scorso anno per Mondadori, racconta – sulla scia di un’altra fortunata opera recente, Eva dorme di Francesca Melandri – quella strana, complicata, a volte fraintesa terra di confine che è l’Alto Adige/Südtirol. Ora, voi lo sapete che l'Italia è un paese intimamente centralista; è anche un paese di campanili e di piccole patrie, certo, ma al fondo, è sempre stato restio a concedere responsabilità e poteri alle regioni. Oggi, poi, con il dibattito in corso sulla riforma del Senato (curioso dibattito quello che punta a creare un senato delle Regioni senza che si sia prima definita una qualche idea di federalismo) il tema delle identità territoriali è più attuale che mai e quindi, ben venga chi queste identità le sa raccontare.
L’inizio del romanzo è un po' crudele, pur parlando di un gioco. Quattro amiche, quattro ragazzine poco meno che adolescenti, eleggono a turno ogni settimana una di loro “nemica del gruppo”. Contro di lei le altre tre si coalizzano, con minacce, insulti, scherzi crudeli. Alla vittima non resterà che cercare di superare quei sette giorni nella maniera più indolore possibile. Nelle settimane successive, potrà vendicarsi di volta in volta contro ognuna delle sue aguzzine.
Questa la situazione da cui parte l'autrice per raccontarci una terra alpina, a ridosso del confine del Brennero, per secoli tedesca, annessa alla fine della Prima guerra mondiale all’Italia, che mai aveva dichiarato di battersi per essa, quanto piuttosto per Trento e Trieste. Tutt'oggi, pur essendo diventata una destinazione turistica di primo piano, grazie in particolare alle Dolomiti, gruppo montuoso patrimonio dell'umanità Unesco, la storia dell'Alto Adige rimane un oggetto misterioso per la gran parte degli italiani, che quando arrivano da queste parti si chiedono come mai tanta gente parli il tedesco e se lo faccia apposta. In realtà, è una storia travagliata: il fascismo in queste valli ha picchiato duro, con i suoi programmi di italianizzazione forzata. Poi ci fu il tentativo di pulizia etnica operato da Hitler e Mussolini con le Opzioni del 1939: agli "optanti", cioè a quei sudtirolesi che avessero accettato di lasciare l’Alto Adige per trasferirsi nei territori del Reich, facendo posto quindi agli italiani, Hitler aveva promesso di dare nuovi paesi, nuove case e nuovi campi da coltivare (il progetto si realizzò solo in parte a causa dello scoppio del secondo conflitto mondiale, ovviamente). Infine la stagione del terrorismo, e finalmente la concessione dell’Autonomia speciale, per la precisione del Secondo Statuto, quello del 1973, che oggi tante altre regioni italiane invidiano, per i benefici economici che ha portato con sé.
Va detto che qui, a differenza che altrove, le tensioni accumulatesi nel tempo non sono mai sfociate in vera guerra civile. E ci sono stati anche dei protagonisti positivi, persone che si sono date da fare per favorire il dialogo fra la comunità tedesca quella italiana dell’Alto Adige (un unicum, quest'ultima, sul suolo italico, essendo formata da tante diverse correnti migratorie generatesi, in tempi diversi, un po’ ovunque nel resto del Paese, dal Veneto alla Sardegna, dal Friuli alla Puglia): fra questi Alexander Langer, indimenticato leader di Lotta Continua e di NeueLinke/Nuova Sinistra, europarlamentare dei Verdi/Grünen, suicidatosi nel 1995 vicino a Firenze, che la De Martin Pinter ricorda nelle sue pagine.
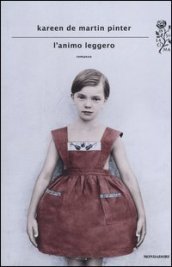 Il romanzo rilegge queste vicende con gli occhi di una bambina, che un po’ subisce e un po’ condivide le piccole, ordinarie – ma a loro modo eccezionali – crudeltà di un microcosmo diviso fra K e V, ovvero fra Krucchi (i tedeschi) e Valsce (gli italiani). Crudeltà che, lo ripetiamo, non deflagrano mai nelle tragedie epocali che hanno segnato altre terre, anche “sorelle” dell’Alto Adige, perché parte un tempo del medesimo Impero austroungarico: si pensi alla Bosnia Erzegovina, ancora oggi lacerata, ancora divisa. Ma che lasciano comunque un segno, nella vita quotidiana delle persone, nel loro bagaglio emotivo, nelle scelte che alla fine decideranno di intraprendere. Come quella di Marta, la protagonista, che alla fine sceglierà un linguaggio che trascende ogni divisione, quello della musica.
Il romanzo rilegge queste vicende con gli occhi di una bambina, che un po’ subisce e un po’ condivide le piccole, ordinarie – ma a loro modo eccezionali – crudeltà di un microcosmo diviso fra K e V, ovvero fra Krucchi (i tedeschi) e Valsce (gli italiani). Crudeltà che, lo ripetiamo, non deflagrano mai nelle tragedie epocali che hanno segnato altre terre, anche “sorelle” dell’Alto Adige, perché parte un tempo del medesimo Impero austroungarico: si pensi alla Bosnia Erzegovina, ancora oggi lacerata, ancora divisa. Ma che lasciano comunque un segno, nella vita quotidiana delle persone, nel loro bagaglio emotivo, nelle scelte che alla fine decideranno di intraprendere. Come quella di Marta, la protagonista, che alla fine sceglierà un linguaggio che trascende ogni divisione, quello della musica.
Insomma, volete un pezzo di Italia lontano dagli stereotipi? Leggetevi questo libro, e poi magari andate a recuperavene anche un altro, L'italiana, di Joseph Zoderer (Einaudi), autore sempre altoatesino ma questa volta di lingua tedesca. Il libro venne dato alle stampe nell'ormai lontano 1982, quando ancora qualche bomba in Alto Adige ogni tanto scoppiava, ricordando che a toccare i confini si rischia sempre qualcosa. Al centro della storia, quello che all'epoca era un argomento tabù, l'amore fra una tedesca (di montagna) e un italiano (di città). Ma poi, chissà se tabù del genere, anche in altre parti d'Italia, sono davvero caduti: quanti padri leghisti oggi darebbero volentieri le loro figlie in spose a un calabrese, per non dire di un tunisino?
Kareen De Martin Pinter, L’animo leggero, Mondadori, 2013, pp.211











