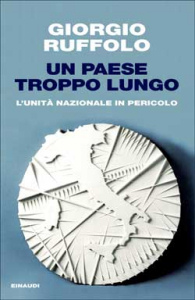Gli italiani, come ha detto di recente il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, non brillano per la conoscenza della propria storia. Soprattutto i giovani. Invece è importante sapere chi siamo e chi siamo stati. Per due lunghi periodi l’Italia è stata una superpotenza e lo è stata nel corso di due egemonie successive. Superpotenza militare all’epoca dell’Impero romano. Superpotenza commerciale durante il Medioevo. Eppure, nell’attuale memoria collettiva, di queste due fasi importanti è come se si fosse perso traccia. Poi, è vero, le cose sono andate molto storte. E continuano ad andarlo. Perciò stavolta in questo mio ultimo libro, mi occupo di questo ciclo di crisi».
Giorgio Ruffolo parla di un Paese troppo lungo (Einaudi Editore), un saggio da poco nelle librerie che sta facendo molto discutere intellettuali e politici: un’analisi impietosa, o meglio realistica, ma non cinica. Perché, al contrario di altri pamphlet che si limitano a denunciare tutto quello che non va nel Belpaese, facile gioco in questa stagione di scandali, escort e disgregazione del tessuto sociale, qui c’è una proposta concreta e possibile per il futuro. Per uscirne, dice lui, con «la forza della normalità».
A 84 anni, gli occhi azzurri sempre gentilmente ironici, un passato nella consulenza politica (dapprima a fianco di Enrico Mattei all’Eni fino alla morte di questi nel 1962, poi di Ugo La Malfa che lo nominò Segretario generale della Programmazione economica negli anni Settanta, incarico che lasciò per presiedere la Fime, Finanziaria meridionale) a cui è seguita una lunga stagione nella politica attiva (deputato, senatore, ministro dell’Ambiente, tra gli estensori del manifesto del Partito democratico a cui non risparmia le sue critiche come, da socialista di vecchia data, non le risparmia al Partito socialista e a Bettino Craxi), Ruffolo è sempre stato, in realtà, prima di tutto un maître à penser e un autore di libri. «Non sono uno storico, ma un appassionato di storia» precisa. A lui si deve, assieme a Paolo Flores d’Arcais e un ristretto gruppo di altri intellettuali, la nascita nel 1986 di Micromega, rivista pensante del Gruppo L’Espresso-Repubblica, molto “opinionated” ma fondamentale nel tenere vivo ciò che resta del dibattito politico in Italia.
 Innanzi tutto ci deve spiegare il titolo. Perché Un paese troppo lungo?
Innanzi tutto ci deve spiegare il titolo. Perché Un paese troppo lungo?
«Furono gli arabi a chiamare così l’Italia. Quando rinunciarono a conquistarla tutta, o meglio non ci riuscirono. Proprio per la sua particolarità territoriale, più di mille chilometri in lunghezza. Una difficoltà di cui solo i Romani ebbero ragione ma che, successivamente, si è ripresentata puntuale. Fino all’unità d’Italia e ai giorni nostri».
E oggi, lei dice, questa unità è a rischio.
«Io distinguo tre momenti, che chiamo: l’unità mancata, l’unità incompiuta e l’unità minacciata. La prima, quella mancata, occorse nel Medioevo. In un’Italia sempre divisa tra Nord e Sud – questa è una caratteristica strutturale della nostra storia – c’era stata la possibilità che il Sud, all’epoca molto potente militarmente, e il Nord, frazionato in tanti statarelli e comuni ma molto ricco, si fondessero. E Federico II, straordinariamente moderno sia in politica interna sia in politica estera, un p’ meno in quella economica, sarebbe stato il re ideale, il federatore di un Paese che, in quel momento, sarebbe stato il primo Stato europeo, unendo il Sud del Regno normanno e il Nord delle repubbliche, naturalmente con Roma capitale. Si sarebbe potuto fare nel 1200 quello che si realizzò solo nel 1861. Fantasia pura, lo so. Ma, spesso, interrogarsi sui “se” aiuta a comprendere la Storia».
Invece, che cos’è l’unità incompiuta?
«Nasce dai tre secoli successivi. Passati in servitù sotto l’invasione dei grandi stati europei, Francia e Spagna soprattutto. Una servitù dalla quale mentalmente non ci siamo ancora liberati; ed è uno dei nostri vizi, assieme alla teatralità, al provincialismo e, soprattutto, alla mancanza di senso dello Stato. In nessun altro Paese, per dirne una, il fisco viene visto solo come un mettere le mani nelle tasche della gente, quando invece, anche se a nessuno piace pagare le tasse, nelle altre nazioni avanzate è vissuto per quello che realmente è: la massima espressione di solidarietà collettiva e di unità tra cittadini. Quei tre secoli, poi, sono stati deleteri anche perché hanno approfondito il divario tra Nord e Sud. In questo periodo si è consolidata e incancrenita la tara storica italiana: l’incapacità di fondersi da parte di due realtà politiche importanti, una per ricchezza, l’altra per potenza, compattezza territoriale e militare».
E perché, al termine di questi tre secoli bui e deleteri, si sarebbe potuta realizzare l’unità che invece, lei sostiene, è rimasta incompiuta?
«Perché un generale italiano, proveniente dalla Corsica per la precisione, Napoleone Bonaparte, invase l’Italia alla testa di un esercito straccione ma potente. La liberò dal controllo che, direttamente o indirettamente, gestivano gli austriaci. Risvegliando gli spiriti nazionali e determinando un grande movimento popolare, il Risorgimento. Oggi, per citare ancora il presidente Napolitano e uno dei suoi ultimi e grandi discorsi, è in atto una tendenza a denigrare il Risorgimento. Ed è un grave errore. Per me il Risorgimento si divide in Risorgimento caldo e Risorgimento freddo. Il primo è, ripeto, un movimento nazionale popolare, svegliato sì da Napoleone ma che prese vita propria. Si rifaceva alla perduta grandezza italiana del passato ma nasceva da eventi attuali per l’epoca e di grande contenuto patriottico: la Repubblica partenopea, le due Repubbliche romane successive, le Cinque giornate di Milano, le dieci giornate di Brescia, la disperata resistenza di Venezia. Poi c’è stato il Risorgimento freddo, quello di Cavour».
Anche lei ce l’ha con Cavour?
«No, Cavour era un moderato. Ma capì che si offriva al piccolo regno di Piemonte, di cui era ministro, la possibilità di realizzare in Italia quella che, in Germania e certamente con mezzi militari superiori, aveva fatto la piccola Prussia: diventare il fulcro di una nuova unità nazionale. E lo fece cercando di trasformare e modernizzare uno Stato, quello piemontese, che era uno dei più retrivi ma dotato, va detto, di una grande capacità di educazione e di civiltà. Ci riuscì. Pochi sanno che i patrioti meridionali affluirono in più di ventimila nel piccolo regno piemontese, attirati proprio dal progetto cavouriano».
Ma, allora, dove è fallito il Risorgimento, se è fallito?
«Nella parte più importante: quella del realizzare la vera e quotidiana unità di un Paese troppo lungo. La colpa, per la verità, non fu di Cavour, morto troppo presto a 50 anni, proprio in quel 1861 che vide la nascita dell’Italia unita. Furono i suoi successori a non essere all’altezza. Non riuscirono a venire a capo di una vera e propria guerra interna, paragonabile a quella che in America è stata la Guerra di secessione: il Sud contro il Nord. Quella che nei sussidiari scolastici passa ancora come la lotta contro i briganti meridionali fu, in realtà, una guerra contro i contadini, cioè contro la struttura portante del Meridione agricolo e agrario. In Francia il movimento contadino venne catturato e aggregato dalla borghesia che ne fece una sua grande forza. In Italia questo non avvenne. Come disse Gramsci, le cui tesi in questo caso condivido, la cosiddetta guerra al brigantaggio fu una sciagura. Non causò il divario, ma lo approfondì in modo irreparabile».
Poi vennero il nazionalismo e il fascismo…
«Che sono proprio l’antitesi del Risorgimento. Vennero ispirati, secondo me, da una reazione a quei secoli di servilismo. Ma si tradussero in un’aggressività che non poggiava su basi concrete né militari né economiche né di reale senso dello Stato. Il Risorgimento invece, da Mazzini a Garibaldi, era ispirato a quello che con un termine odierno si chiamerebbe pacifismo. E anche a un europeismo ante-litteram. Mazzini fondò sì la Giovine Italia ma diede vita anche alla Giovine Europa. E cercò sempre il raccordo con gli altri movimenti internazionali ispirati al progresso e all’innovazione».
Fin qui lei mi ha dato una bella lezione di storia di cui ringrazio. Veniamo però alla cronaca attuale, alla terza fase, quella dell’unità minacciata. Stiamo davvero correndo il rischio?
«Quando, dopo la seconda guerra mondiale, nasce la Repubblica questa si presenta come un fatto nuovo, fondato su basi serie e persino consapevole dei propri limiti. E subito realizza due miracoli. Quello economico: in pochi anni l’Italia passa dagli ultimi posti fino ai vertici della classifica delle potenze economiche. E quello politico-strategico: in piena guerra fredda si dota di una delle Costituzioni democratiche più avanzate, frutto dell’incontro e confronto tra i vari partiti anti-fascisti. C’era così la possibilità di realizzare quell’unità fallita dal Risorgimento. E così sembrò all’inizio. La politica meridionalista messa in piedi attraverso strumenti come la Cassa per il Mezzogiorno voleva dare una risposta al divario tra Nord e Sud. Poi le cose sono andate come sono andate. Non c’è stata l’industrializzazione del Sud che doveva essere il passo obbligato. I problemi sono cominciati con l’istituzione delle Regioni: avrebbero dovuto rappresentare il passo in avanti della politica italiana, invece hanno aumentato la corruzione. Perché a fronte di alcune regioni con una propria coscienza collettiva e territoriale – il Veneto, la Toscana, la Lombardia, il Piemonte, la stessa Sicilia unica regione del Sud – altre grandi regioni ne erano e ne sono prive: per esempio la Campania e la Puglia. In queste condizioni la regionalizzazione ha portato a una dispersione delle risorse e alla corruzione. E ha dato vita a una classe dirigente locale basata sul peggiore clientelismo e affarismo».
Quindi, la sua proposta qual è?
«È provocatoria. Realizzare quello che il Risorgimento non è riuscito a fare: uno Stato federale vero, che superi quell’accentramento di poteri che fu uno degli aspetti risorgimentali negativi e portò anziché all’unità del consenso all’unità imposta. Il federalismo a cui penso, però, si basa sulle macro-regioni: non quindi un federalismo tra le 21 regioni, alcune piccolissime, in cui è frazionato il potere amministrativo italiano. Ma, sostanzialmente, un’intesa tra Nord e Sud, con anche il Centro certo. E che abbia Roma come capitale federale, alla stregua di ciò che Washington è per gli Stati Uniti. Un’utopia? Forse, non me lo nascondo. Ma la Storia che cos’è se non una serie di utopie realizzate?».
Giorgio Ruffolo leghista?
(Ride) «Il mio amico Mario Pirani, editorialista di la Repubblica, ha scritto che la mia proposta è un’occasione per la Lega per assumere un ruolo veramente nazionale nel cammino verso un federalismo che però non sia limitato alla Padania, entità che a livello europeo non verrebbe mai riconosciuta e non avrebbe alcun peso, ma sia davvero unitario. Un federalismo, insomma, che “federa” e non divide. Quello di cui si parla in Italia è un federalismo balordo, che non federa nulla, perché si basa su aggregati troppo piccoli. E, tra l’altro, non coglie nemmeno una questione fondamentale: quella della immigrazione. Siamo stati un Paese di emigrazione e oggi che siamo un Paese di immigrazione, che cresce demograficamente e economicamente grazie all’apporto degli immigrati, vorremo chiuderci? Qui, mi perdoni il termine che non mi piace, sta la “stupidità” della Lega: avrebbe dovuto essere l’espressione di un federalismo capace di aggregare le nuove forze. Il vero federalismo è un’altra cosa. Basta vedere ciò che avviene in Germania, in Svizzera e, per guardare oltre l’Europa, negli Stati Uniti d’America: tutti paesi dove il federalismo non è certo separatista ma è, anzi, l’espressione più pura di un nazionalismo patriottico. Un patto di sviluppo nazionale tra Nord e Sud è l’unica via possibile. E si integra con il federalismo europeo».
E i partiti di governo e di opposizione come potrebbero reagire a questa sua proposta?
«Non sono all’altezza. Non hanno coscienza, nè il Pdl nè il Pd, di questo problema italiano. Non hanno dato vita a una classe dirigente nazionale. Nel Sud, per esempio, la realizzazione in chiave moderna di quello che fu il Regno delle due Sicilie, con un Parlamento costituente permetterebbe di generare finalmente una nuova classe dirigente. Che potrebbe superare quella borghesia mafiosa che nel corso dei decenni si è venuta creando dalla disgregazione della classe agraria». E così siamo arrivati alla mafia.
«L’unità del Paese è a rischio disgregazione. Al Nord sotto il peso delle frantumazioni e degli egoismi di città e regioni che, oltre tutto, non hanno più il peso industriale ed economico di un tempo. Al Sud sotto il controllo sempre più serrato della mafia e della criminalità organizzata che, ormai, sta coscientemente tentando di sostituirsi allo Stato. E la risposta è nelle città: vi si affollano sempre più persone ed è nei tessuti urbani che si svolge il processo di degradazione. Le metropoli stanno diventando la vera barriera allo sviluppo. Occorrono seri piani di risanamento urbanistico, ma soprattutto civile ed educativo. Invece i partiti, tutti, non ci pensano proprio. Anche Forza Italia, e questa è una cosa da dire con le dovute cautele e i distinguo, nasce dalla disgregazione e da un patto scellerato in cui, da subito, sono entrati elementi di corruzione. E, oggi, all’interno del Pdl queste componenti sono sempre presenti, assieme alle altre certo: ho seguito con simpatia l’evoluzione di Fini che credo sia autentica».
E il Pd di D’Alema e Bersani?
«Non ha la capacità di generare una politica di unità nazionale, non capisce che oggi la sinistra in Italia può assumere un ruolo soltanto se interpreta l’unità nazionale. Ma lo sbaglio del Pd e dei partiti da cui nasce parte da lontano, da un gravissimo errore storico: il non essersi voluto riconoscere nel socialismo democratico».
Ne usciremo? E come?
«Se ce la faremo, ce la faremo con la forza della normalità. L’Italia è un Paese sorprendente per la sua vitalità, le cui grandi possibilità non vanno sottovalutate. Siamo individualisti e questo è un bene. Ma corriamo il rischio di essere anche “privatisti”, ognuno per sé, e questo è un male. Il problema, insisto, è nella mancata coscienza nazionale. Alla quale si arriva con l’educazione, cioè appunto per vie normali».
ten.iggoacirema@oniuqadn