Se non avete motivi plausibili per venire a New York, il museo Whitney ve ne offre in questo momento uno interessante oltreché divertente: si chiama Dreamlands: Immersive Cinema and Art, 1905-2016. È un’escursione attraverso mondi creati nel corso di più di un secolo da un numero insospettatamente alto di artisti con lo scopo di avvolgere, impegnare tutta la vostra persona e i vostri sensi, e non soltanto la sola vostra vista.
Conoscevamo già il cinema tridimensionale, le installation e i video audiovisivi. Ma chi si aspettava questa vastità e molteplicità di esperimenti in ogni serie di ambienti e con lo stimolo di tante percezioni diverse, incluso l’udito, il tatto e perfino l’odorato? E soprattutto, chi si aspettava esperimenti tanto antichi e nell’oggi una proliferazione così varia di sforzi in quella direzione da parte di artisti di ogni continente?
Una mostra di questo genere, d’altro lato, non poteva essere tentata che in un museo dalla superfici così sterminate e così aperte come il Whitney, dove ciascun piano dell’edificio di Renzo Piano affacciato sulla baia dell’Hudson offre una superficie espositiva di oltre duemila metri quadrati. Uno di questi piani è stato per questa mostra ripartito in una trentina di ambienti di tutte le dimensioni e forme geometriche, oltre a una cupola geodetica per rappresentare le “dreamlands”, o zone oniriche, del titolo; ambienti che, nelle diverse gradazioni di luce e insieme a pareti e soffitti, permettono la presentazione dell’opera di molte decine di artisti.
La mostra è organizzata in tre parti. La prima, dall’inizio del secolo scorso al 1930, parte da un breve film in 16mm. realizzato nel 1905 dal fotografo Edwin S. Porter con la camera cinematografica da poco inventata da Thomas Edison per rappresentare le luci elettriche – pure inventate da poco – che di notte delineano il Luna Park di Coney Island: una festa luminosa intitolata a suo tempo, appunto, Dreamlands.
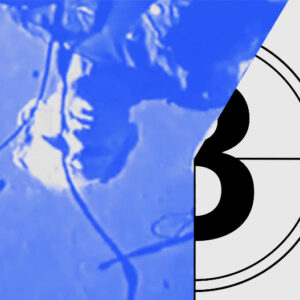 La mostra è poi centrata sul periodo 1920-1930 e s sull’opera di artisti della repubblica di Weimar, un periodo di intensa creatività esemplificato dal “balletto triadico” di Oskar Schlemmer (1922), direttore dell’attività teatrale della Bauhaus; una raffigurazione via film in cui danzatori androgini si muovono su uno spazio piatto multicolore a un tempo trasognato e surrealistico, in cui spazio, colore, movimento e suono sono coordinati in un insieme di sconcertante elementarità.
La mostra è poi centrata sul periodo 1920-1930 e s sull’opera di artisti della repubblica di Weimar, un periodo di intensa creatività esemplificato dal “balletto triadico” di Oskar Schlemmer (1922), direttore dell’attività teatrale della Bauhaus; una raffigurazione via film in cui danzatori androgini si muovono su uno spazio piatto multicolore a un tempo trasognato e surrealistico, in cui spazio, colore, movimento e suono sono coordinati in un insieme di sconcertante elementarità.
Da questo punto la ricerca artistica sembra procedere dai tentativi di investigare con modi nuovi la realtà, a quelli di trasformarla con l’impiego di nuove tecnologie. Così nell’opera Raumlichtkunst (Arte, Spazio, Luce) di Oskar Fischinger (1926) consistente di tre pellicole colorate a mano proiettate contemporaneamente. Del 1936 è il rarissimo film Rose Hobart di Joseph Cornell (lo stesso delle famose scatole astratte), creato attraverso la frammentazione del film americano Ad est di Borneo, del 1931, in cui i frammenti sono colorati e riorganizzati in una pellicola astratta.
La seconda parte dell’allestimento, dal 1940 al 1980, riflette un’epoca di conflitto e tensione politica con opere concettuali e che frantumano lo spazio e sconvolgono utopie futuristiche; dominato, il tutto, da una straordinaria ricostruzione filmistica dell’esplosione di una bomba a idrogeno sull’atollo di Bikini, fatta nel 1976 da Bruce Conner col titolo di Crossroads. È, in effetti, un crocevia esistenziale quello suggerito dal montaggio di frammenti di un documentario del Pentagono, rimasto per molti anni invisibile perché coperto dal segreto militare; una suggestione di immenso e inevitabile annientamento, attuale oggi mentre fanno ritorno in un campo politico globale fantasmi di distruzione che sembravano esorcizzati.
Sullo sfondo di questa rinnovata minaccia si colloca, nella terza parte della mostra, la fantasmagoria cibernetica che anima la maggior parte delle opere concettuali realizzate tra il 1980 e oggi. Sono i sogni e gli incubi rievocati da artisti di ogni continente, attraverso la creazione di spazi virtuali, la confusione delle identità e degli spiriti, le rappresentazioni multi-sensoriali, l’intrusione dei robot e lo sconcerto prodotto da tecnologie ancora in gran parte inesplorate. Da segnalare la cupola geodetica del bostoniano Ben Cooley in cui proiezioni contemporanee su 360 gradi cercano di annullare negli spettatori la forza di gravità, e l’installazione Sonnenfabrik, o fabbrica solare, dell’artista tedesca Hito Steyerl, già esposta nel padiglione tedesco della Biennale di Venezia del 2015.
Giungono infine inattesi i tentativi di intrecciare antiche mitologie africane con escursioni futuristiche negli spazi e nel tempo, compiuti da artisti della diaspora africana in Occidente, tra cui molte donne. Una lacuna di questa mostra coraggiosa e rivelatrice è tuttavia, a mio giudizio, l’assenza di un qualunque sforzo per identificare la paternità del lato sonoro, o musicale, delle opere. Nessun credito viene dato, ad esempio, alle fondamentali innovazioni acustiche di Edgar Varèse.
La mostra, organizzata da Chrissie Iles, è accompagnata da un programma di film surrealistici e astratti della durata di quattro mesi e si concluderà il 5 febbraio del 2017.












