La scorsa settimana ho contratto un prestito con uno sconosciuto, ma spero che grazie a ciò diventeremo amici. Di solito non si diventa amici con chi si entra in affari, ma qui si tratta di un altro genere di affari: affari culturali. E forse non dovremmo nemmeno chiamarli così, piuttosto condivisioni culturali. Perché questa è la cultura. Fatto sta che ero a Link, il Festival del Buon Giornalismo a Trieste, e mi sono fatta prestare una frase preziosissima appena pronunciata, certa che facesse al caso mio. Più che mio, della mia famiglia, della sua storia. La frase di Marco Damilano, direttore del settimanale L’Espresso, è: “Chi racconta una vita, racconta un popolo intero”.
La storia di quella che è stata la mia famiglia, di quello che ha patito, di quanto ha perso non è commensurabile – né mi interesserebbe fare questa operazione – ma racconta un mondo che è stato annientato. Racconta di come è stato annientato e del perché. Perché l’occasione fa l’uomo ladro. Si è detto e ridetto che gli esuli istriani, fiumani, dalmati sono stati perseguitati, derubati, assassinati perché erano italiani. E’ vero solo in parte. Erano la classe più colta e produttiva della costa dell’Italia orientale, i loro beni facevano gola da un secolo all’etnia slava, presa nell’entroterra montuoso e sistemata dall’impero austroungarico in Istria e Dalmazia per mettere in minoranza l’oligarchia italiana. Nel frattempo molti italiani sono emigrati e diversi slavi si sono arricchiti, hanno occupato posti di potere, si sono imparentati con gli italiani rimasti. Il cui sangue blu si è stinto parecchio, ma amore e affari hanno assicurato una pacifica convivenza. Fino al dopoguerra, fino all’arrivo dei partigiani titini, fino all’avvento del comunismo. “Il ribaltòn?” chiesi qualche anno fa a un’anziana parente, Anna Mosca. “No, no quello è avvenuto nel 1797, con la caduta di Venezia. Parlo del patatràc del 1943: la rovina del nostro piccolo mondo italiano al di là dell’Adriatico. Ero di una famiglia bene, vivevo a Zara, mio padre era magistrato. Avevo trascorso con la mamma l’estate dagli zii sull’isola di Arbe. L’8 settembre non siamo potute ritornare a Zara, ho patito la fame sull’isola quell’inverno, mi sono ammalata… Non ho più rivisto mio padre: scomparso, come tanti altri italiani. La casa saccheggiata”.
I partigiani jugoslavi, spesso albanesi al soldo di Tito, risalivano la Dalmazia dal sud perpetrando eccidi efferati per rubare tutto quello che potevano. Non stavano a guardare se uno aveva il pedigree italiano o slavo, bastava che possedesse qualcosa. Gli veniva legata una pietra al collo ed era gettato in mare. Non erano ancora state inventate le stragi nelle foibe. Ad Arbe tutti i possidenti sono stati impiccati sui pali della luce lungo il porto. Mio padre con la sua famiglia si è salvato imbarcandosi sull’ultimo traghetto per Fiume quell’8 settembre. Poi a piedi fino a Trieste. Non ha più rivisto i suoi nonni materni, rimasti a Zagabria, derubati e privati di tutto pure loro.
Fascista un esule in Italia lo diventava per forza. Primo perché era considerato tale essendo scappato dal comunismo, secondo perché non poteva non odiare il comunismo. Questo lungo preambolo solo per arrivare alla minaccia del sorpasso del Partito comunista in Italia. Nel 1975 la Democrazia cristiana uscì con uno slogan vincente: “Trent’anni di libertà. Alcuni anni buoni, altri meno buoni ma tutti in libertà”. La mia famiglia, come gran parte del Paese, votò Dc . Ma il compromesso storico non era scongiurato: l’artefice era Aldo Moro. Il 16 marzo del 1978, l’annuncio in tv del suo rapimento. Molti esultarono: “Vade retro, comunismo”. E così fu. E a quanti vivevano a Trieste, in bilico sul confine orientale – non era un bel vivere gomito a gomito con i soldati serbi –sembrò la fine di un incubo: che potessero risvegliarsi nel comunismo, da dove erano scappati.
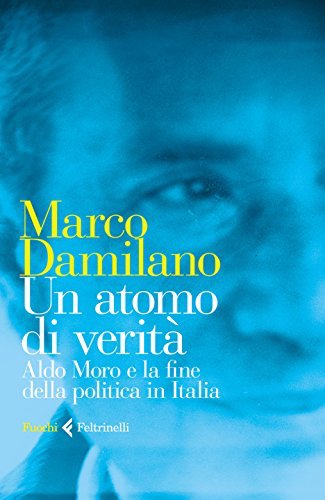 Marco Damilano aveva solo 9 anni nel 1979, viveva a Roma – in un’altra Italia, quella vera – e quel 16 marzo era sul pulmino che lo portava a scuola passando proprio per via Fani a prendere un suo compagno. E da questo ricordo è iniziata la ricostruzione della storia dello statista. Nel suo libro “Un atomo di verità. Aldo Moro e la fine della politica in Italia” (Feltrinelli) spiega cosa abbia perso l’Italia con la morte dello statista: la possibilità di far cadere quel muro, che divideva l’Italia a metà, dieci anni prima di quello di Berlino. Mi pare che quel muro continui ad essere tirato su con mattoni freschi da muratori improvvisati alla bisogna: lo spauracchio comunista funziona ancora.
Marco Damilano aveva solo 9 anni nel 1979, viveva a Roma – in un’altra Italia, quella vera – e quel 16 marzo era sul pulmino che lo portava a scuola passando proprio per via Fani a prendere un suo compagno. E da questo ricordo è iniziata la ricostruzione della storia dello statista. Nel suo libro “Un atomo di verità. Aldo Moro e la fine della politica in Italia” (Feltrinelli) spiega cosa abbia perso l’Italia con la morte dello statista: la possibilità di far cadere quel muro, che divideva l’Italia a metà, dieci anni prima di quello di Berlino. Mi pare che quel muro continui ad essere tirato su con mattoni freschi da muratori improvvisati alla bisogna: lo spauracchio comunista funziona ancora.












