Raccontare identità e rappresentazione degli Italoamericani non è mai stata impresa facile. E lo ha confermato anche la presentazione del libro di Maria Laurino The Italian Americans. A History che si è tenuta la scorsa settimana alla Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University.
Il libro accompagna l'omonimo documentario della PBS diretto da John Maggio e, come indica il sottotitolo, racconta una storia degli Italoamericani, in maniera documentata e abbastanza esaustiva, utilizzando in buona parte proprio le interviste, i materiali e la voluminosa documentazione raccolta in anni di ricerche da John Maggio per lo sviluppo e la produzione del documentario.
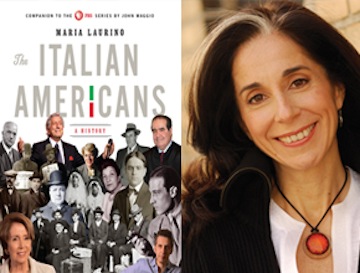
La copertna del libro e l’autrice Maria Laurino
Alla Casa Italiana, accanto a Maria Laurino e John Maggio, erano presenti il direttore della Casa Italiana Stefano Albertini, che ha moderato la discussione, e Martino Marazzi, visiting professor del “Tiro a Segno”, il club italoamericano più antico degli Stati Uniti che da alcuni anni ha istituito una cattedra di studi italoamericani alla New York University.
Dopo la presentazione di un estratto del documentario, fatto di interviste, riprese nei luoghi segnati da una forte presenza italoamericana negli Stati Uniti e belle immagini di repertorio, l'attenzione si è concentrata sul libro di Maria Laurino, che ha presentato ragioni e punto di vista del suo libro, e soprattutto l'intenzione di andare a fondo e scardinare quei luoghi comuni che hanno per troppo tempo caratterizzato gli italoamericani, creando cliché negativi che hanno danneggiato l'intera comunità italiana in America. Bersaglio principale della Laurino nella sua presentazione: Mario Puzo con il suo Padrino, il maggiore responsabile, secondo l'autrice, della cattiva immagine degli Italoamericani, indelebilmente legata alla Mafia. Ed è quest'immagine e questa tanto immediata quanto ingiustificata identificazione che Maria Laurino, con il suo libro, intende scardinare, andando invece a raccontare quella che è stata la storia dell'immigrazione italiana in questo paese e la vera identità delle comunità italoamericane, fondate sulla famiglia, la solidarietà e il lavoro, aspetto che per molto tempo non è stato giustamente valorizzato.
Se questo è doveroso e fondamentale lì dove, nel 2014, si vanno a raccontare gli Italoamericani, e altrettanto vero che nella stessa presentazione alla Casa Italiana grande spazio è stato dedicato proprio al Padrino, spiegando la scarsa informazione di Puzo stesso nelle sue ricerche per il libro e le ragioni meramente economiche che lo hanno portato a scrivere il suo celebre romanzo, oltre alla responsabilità morale di aver creato un'idea romantica della Mafia che rimarrà indissolubilmente nell'immaginario d'America.
Se tutto questo è senza dubbio moralmente riprovevole, nei confronti di una comunità che da quando è arrivata ha lavorato duramente e ha influenzato positivamente proprio la struttura sociale americana e a causa del libro si è vista additare come mafiosa da una buona parte dell'opinione pubblica americana, è anche vero che parliamo di un romanzo di finzione, che è stato un grande evento mediatico, non solo il romanzo quanto il successivo film di Francis Ford Coppola. E questo è un fatto, e fa parte della storia e della rappresentazione degli italoamericani, giusto o sbagliato che sia, e l'impressione è che continuare a parlarne e a scriverne non faccia che avvalorare questa tesi.
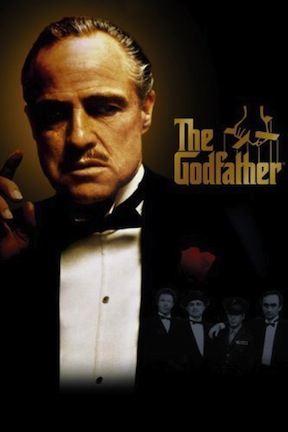
Il Padrino con Marlon Brando attore protagonista del film con cui vinse l’Oscar nel 1973
Se The Godfather rappresenta per molti ancora il demone della storia italoamericana, uno degli esempi più positivi è invece rappresentato, come racconta bene la Laurino, da quello che è diventato poi famoso come il “Roseto effect”: nel 1882 undici uomini di Roseto Valfortore in Puglia sono emigrati in America e hanno fondato un paesino in Pennsylvania, il più possibile simile al loro paese di provenienza, chiamandolo poi proprio Roseto, e qui negli anni sono arrivati altri Italiani (da Roseto ma in generale dal sud Italia), e nel tempo è diventata una cittadina abitata per la quasi totalità da italoamericani che qui hanno riprodotto lo stile di vita che avevano in patria. Negli anni Sessanta del secolo scorso, alcuni medici hanno cominciato a notare che a Roseto si moriva d'infarto molto meno che in qualunque altro posto d'America, e dopo anni di studi sono giunti alla conclusione che la ragione era emotiva e non genetica o alimentare, perché la comunità di Roseto era coesa e solidale, e gli individui si sentivano safe, avendo abitudini ben radicate e sapendo di poter contare sui vicini in caso di bisogno, dove non c'era invidia economica vivendo tutti in condizioni simili e non esibendo mai la propria ricchezza per paura del malocchio, come spiega Maria Laurino.

Alcuni abitanti di Roseto, Pennsylvania
Il “Roseto effect” non è durato negli anni, le generazioni sono cambiate ed è intervenuta la globalizzazione, ma è stato un buon esempio di come valori e stile di vita degli italoamericani fossero stati positivi.
Sicuramente di esempi come questo ce ne sono a migliaia in giro per l'America: comunità solidali e individui che si sono distinti per etica del lavoro, battaglie sindacali, nell'arte, nei diritti civili, e la Laurino nel suo libro porta decine di ottimi esempi, da Sacco e Vanzetti a Florence Scala a Fiorello la Guardia, e numerosi artisti, come John Fante e Gregory Corso.
Il professor Marazzi, apprezzando il libro “per il grande lavoro fatto in termini di documentazione e di equilibrio rispetto proprio al delicato tema della Mafia”, porta l'attenzione dall'“effetto Roseto” a quello che chiama l' “effetto Rosarno”, e cioè alle condizioni disumane di vita e di lavoro degli immigrati in Italia oggi, “nella totale colpevole indifferenza da parte delle istituzioni, del Governo e anche dell'opinione pubblica italiana, in quello stesso sud da cui un tempo gli italiani partivano per l'America in cerca di lavoro e dove oggi sono gli stessi abitanti che sfruttano il lavoro immigrato e sono i primi ad ammazzare gli immigrati quando diventano scomodi o non servono più”.
A questo punto c'è un brusio di orrore e scandalo da parte del pubblico presente – si, esattamente come succede qui in Arizona o California con i braccianti agricoli messicani. E qui si apre un capitolo tanto complesso quando fondamentale per quel che è oggi l'Italia da un punto di vista sociale, economico e culturale e anche per quel che riguarda gli italoamericani qui.
La storia si ripete, semplicemente si sposta da un punto all'altro del mondo, lì dove si sposta la ricchezza o meglio, lì dove diventa insopportabile la miseria. Perché è tanto vero, come sottolinea Maria Laurino nel suo libro, che gli italiani sono venuti in America per lavorare e si sono trovati a fare i lavori più umili, sottopagati, denigrati per il loro accento o il loro gesticolare o le loro abitudini alimentari, quanto è vero che una buona parte degli italoamericani di prima, seconda o terza generazione è ben poco solidale verso gli immigrati che arrivano oggi in America, e anche verso quelli che arrivano in Italia e di cui sanno solo per sentito dire o attraverso certa informazione. E qui si aprirebbe un'altra questione ancora.
E accanto a questo c'è qualcos'altro, che emerge prepotentemente negli interventi della Laurino e di alcuni dei presenti: l'annosa questione/contrapposizione tra italiani e italoamericani. “Lì dove c'era inizialmente una storia comune – spiega Martino Marazzi – questa storia a un certo ha cominciato a divergere, con gli italiani che vivono in Italia da una parte, e gli italoamericani discendenti da italiani che vivono in America dall'altra”, ed è una questione molto sentita e non risolta. Laurino stessa si sorprende quando va in Italia in vacanza e non viene considerata italiana, mentre lei si sente italiana, i suoi nonni erano italiani. Eppure a noi che siamo italiani e arrivati di recente negli Stati Uniti non sorprende affatto, non parlando lei italiano e vivendo lei in America, ma dalle reazioni dei presenti si capisce che non è questione facile da risolvere: dipende dalla differenza di percezione, dal vissuto, dalle esperienze culturali, dalla lingua, da mere questioni geografiche, legali e di cittadinanza, e altro ancora, ed è una questione ancora aperta, e molto emozionale.

Da sinistra, Martino Marazzi, John Maggio, Maria Laurino, Stefano Albertini
Noi italiani (anche quelli che vivono qui) solitamente non ci sentiamo offesi dal Padrino o dai Soprano o da Fonzie, molto diversa è la percezione degli italoamericani che sono qui da generazioni, e che si sono sentiti stigmatizzati. Per gli italoamericani la questione delle radici e dell'identità culturale è (o è diventata) importante, per noi esiste quasi esclusivamente in termini elettorali o separatistici all'interno del nostro stesso paese.
The Italian Americans. A History è un buon contributo allo studio e alla divulgazione di questa storia: riporta fatti, documenti, storie e fa riflettere, e giustamente si propone come una storia, non la storia. E' un peccato però che, per esempio, che si parli quasi esclusivamente di emigrazione dal sud Italia, mentre sono emigrati in massa dal Veneto, dal Friuli e dall'Istria, che quand'era italiana era la seconda regione più povera d'Italia. Sicuramente dal sud Italia sono partiti in numero maggiore e venivano da tradizioni più antiche e radicate, e hanno quindi dato la connotazione più forte agli Italoamericani in termini di lingua, cultura e abitudini, tant'è che in certe parti d'America per anni gli italiani venivano chiamati “Sicilians”.
Ma spiegare tutto il fenomeno migratorio che ha dato luogo agli “Italian Americans” esclusivamente con la questione del sud, in senso economico e culturale, è un po' riduttivo, come lo è, dal punto di vista di chi scrive, l'idea di struttura e potere mafioso (inteso come fenomeno legato solo al sud Italia) spiegata agli americani da Maria Laurino in pochi minuti.
Del documentario della PBS si è parlato poco alla Casa Italiana, e dovremo aspettare ancora un po' per vederlo: la messa in onda sarà il 17 e il 24 febbraio 2015, quattro ore in tutto, importanti per far conoscere la storia (o forse, anche in questo caso, una storia) degli Italoamericani a un pubblico americano che ancora ne sa pochino. Come ammette lo stesso regista, “io stesso non sapevo quasi nulla dei miei nonni se non che fossero arrivati dalla Sicilia, e questa per me è stata una bellissima occasione per cominciare a cercare, e saperne di più.”
Maria Laurino ha spiegato come il suo libro mantenga “la stessa struttura del documentario, con l'aggiunta di un paio di capitoli, tra cui quello dedicato alla controcultura degli Italoamericani.” All'interno di ogni capitolo sono riportati alcuni “Documenti”, estratti da scritti, lettere e poesie di scrittori italoamericani molto noti come John Fante e Gregory Corso e altri meno noti ma altrettanto importanti, come Arturo Giovannitti, poeta e leader sindacale che nei primi anni del XX secolo ha condotto battaglie fondamentali per il miglioramento delle condizioni di lavoro in Massachusetts. Accanto ai Documenti, Maria Laurino inserisce dei sottocapitoli, quasi dei ritratti, dedicati a quelli che chiama “I nostri antenati” – Garibaldi, Toscanini e Florence Scala – e alcune brevi interviste a quelli che chiama “I nostri paesani”, italoamericani diventati illustri in vari campi dal dopoguerra ad oggi: Gay Talese, Davy Chase, John Turtrurro.
Per conlcudere, un piccolo aneddoto personale: quando sono andata in libreria per comprare The Italian Americans. A History, che era esposto su un bel tavolo fra i picks del mese, accanto a me, seduto ai piedi di uno scaffale, c'era un signore sui sessant'anni, immerso nel suo cappotto, con gli occhiali calati sul naso, tutto assorto a leggere Il padrino…











