Provate a fare questo semplice esperimento. Chiedete ad un amico o ad un conoscente di scegliere tra due tipi di vacanza:
- Vacanza A: una settimana con la famiglia in un posto piacevole (al mare, se vi piace il mare. In montagna, se vi piace la montagna) dove non succederà nulla di eclatante, ma vi rilasserete sicuramente.
- Vacanza B: due settimane nel posto più entusiasmante e costoso che possiate immaginare, tutto pagato, da soli o con la compagnia che volete voi, con la possibilità di indulgere nei vostri vizi più godosi. Con una clausola importante, però! Dopo la vacanza dovrete bere una pozione che cancellerà totalmente il vostro ricordo di quelle due settimane. Video, foto e resoconti della vacanza saranno ugualmente cancellati. Sarà come se quella vacanza non ci fosse mai stata.
Dopo qualche domanda per investigare sulla possibilità di aggirare la clausola, il soggetto del vostro esperimento si arrenderà:
“Scelgo la vacanza A. Che senso avrebbe una vacanza bellissima se poi non ci rimane niente da raccontare e neppure da ricordare?”
Non siate sorpresi. Una vacanza “memorabile” è la vacanza migliore a cui si possa aspirare quasi per definizione: la misura della sua bontà è data dal periodo di tempo per cui ve la ricorderete.
Le storie danno senso alla nostra vita in qualche modo. La nostra capacità di ricordarle e raccontarle è alla base di una vita soddisfacente e del nostro benessere. Togliete la narrazione ed ecco tolto l’ingrediente che rende la vita degna di essere vissuta un po’ per tutti. Non è una coincidenza che tutti scelgano la vacanza A. Meglio una vacanza normale piuttosto che una eccezionale che non saremmo in grado di ricordare.
La Storia della Vita
Questo esperimento non è farina del mio sacco, naturalmente. Questi meccanismi mentali ci sono stati illustrati dalla psicologia cognitiva di Daniel Kahneman e Amos Tversky.
Kahneman stesso ha fatto l’esempio della vacanza in un noto Ted Talk per spiegarci l’experiencing self (l’Io che vive di esperienze) e il remembering self (l’Io che ricorda), due aspetti della nostra psiche che, incredibilmente, agiscono uno all’insaputa dell’altro.
Come illustrato in un’intervista al New York Times, la differenza tra experiencing self e il remembering self non è un mero esercizio filosofico. Essa è la chiave con cui il premio Nobel Daniel Kahneman ha decifrato la felicità umana, dopo anni di ricerche sull’argomento (e secoli di fallimenti da parte della filosofia, aggiungo io). Pensare a noi stessi come ad un io unico in grado di decidere cosa ci piace o cosa no è l’assunto errato che, fino ad oggi, non ci ha permesso di dire cose sensate quando ci siamo chiesti cosa sia la felicità.
Le nostre vite sono fatte di momenti più o meno piacevoli che scorrono senza che quasi ce ne rendiamo conto. Se qualcuno ci chiedesse come ci sentiamo in questo momento, sarebbe il nostro experiencing self a rispondere.
Se la domanda riguardasse come siamo stati durante un evento passato, invece, a rispondere sarebbe qualcun altro: il remembering self !
In quest’ultimo caso, difficilmente il resoconto rispecchierà la nostra esperienza molto fedelmente. I momenti salienti che ricordiamo, belli o brutti che fossero, dominerebbero il nostro racconto. Il resoconto sarebbe frutto della narrazione che intorno a quei momenti abbiamo costruito per poterli ricordare.
Spiega Kahneman nell’intervista al New York Times che ho citato:
“È il Remembering self a comandare, non l’ Experiencing self. […] Per quanto possa sembrare strano, io sono un tutt’uno con l’io che ricorda, mentre l’Io che vive la mia vita mi è quasi estraneo.”
Potremmo quasi affermare che noi “siamo” la narrazione che facciamo della nostra vita e degli eventi che la circondano. E non parlo solo delle nostre vacanze, ma dell’intero meccanismo che dà un senso all’intera nostra esistenza.
La domanda sulla vacanza preferita altro non è che un thought experiment, un esperimento mentale finalizzato a porre i due io in antitesi diretta, facendoli emergere nitidi davanti a noi.
Teniamo questo aspetto ben presente perché è la chiave che ci permette di comprendere il comportamento di tutti noi.
Riprendiamo il discorso sul populismo
In un mio articolo del marzo 2018, avevo spiegato i meccanismi che portano al successo dei movimenti populisti tramite la psicologia cognitiva. Nell’era dei social media, la comprensione della narrazione e dei bias cognitivi è lo strumento principe per decifrare le evoluzioni della società, intesa nel senso più globale possibile del termine.
Una delle principali conclusioni a cui ero arrivato nell’articolo era questa: i populisti inneggiano allo scardinamento di pezzi dello status quo e delle istituzioni che lo sottendono, come se queste fossero responsabili di una condizione esistenziale fattasi insostenibile. Vasti strati della popolazione appoggiano idee anti-sistema spesso balorde e impraticabili, senza accorgersi che esse potrebbero essere nefaste, in primo luogo, proprio per loro.
Scrivevo:
In questo contesto, è comprensibile che molti optino per la scelta populista, benché essa sia assolutamente irrazionale dal punto di vista logico. Non è annientando il sistema che offre 1300 Euro di stipendio che si finisce col guadagnare di più. Molto più probabile che si finisca per perdere anche i 1300 euro. Ma da quell’orecchio, in tanti, non ci sentono. Non ci vogliono sentire, preferendo comunque puntare su una scelta che scompigli le carte ad un “sistema” da cui non sentono di ricevere abbastanza.
L’articolo ha avuto una certa risonanza e ha ricevuto molti commenti, non tutti positivi, inclusi quelli di qualche succube di Dunning-Kruger che non si rendeva neanche conto di essere egli stesso la prova vivente di quello che avevo scritto nell’articolo. Ma non tutti i commenti critici sono stati sciocchi.
Ad esempio, Igor Santarpia ha scritto un commento degno di nota, anche se ha avuto il difetto di prendersela un po’ troppo con me anziché confrontarsi con l’articolo:
Ed è qui che lei, il nostro “chief” che probabilmente fa parte di quel mondo di “specialisti” che la globalizzazione premia, cade in contraddizione. Ammettendo che i no vax o altre teorie anti-scientifiche siano effettivamente fuffa e frutto di narrazioni, purtroppo mi scivola nello stesso meccanismo…quanto di tutto ciò che pensa lei su debito, macroeconomia e altri aspetti davvero critici del nostro contemporaneo( e alla base del populismo) pesano sulla sua narrazione?
Il tentativo di spostare la discussione sul personale non è bello, ma l’osservazione merita attenzione. È per questo che l’ho avuta presente per tutto questo tempo.
Possibile che anch’io sia influenzato da narrazioni che offuschino la mia capacità di analizzare la realtà?
Ed in generale, se davvero i bias cognitivi possono influenzare così tanto i nostri pensieri, come ci proteggiamo da suggestioni che ci impediscano di percepire la realtà qual’essa sia?
Un modo è senz’altro quello di “testare l’ipotesi alternativa”. Preso atto che l’informatica e la tecnologia offrono da anni posti di lavoro al riparo dalle sfide della globalizzazione, l’ipotesi alternativa si traduce in pratica nella seguente domanda:
“Se io non operassi nel settore tecnologico, sarei così veloce a liquidare la situazione attuale con un “tant’è”? Oppure mi unirei al folto gruppo di quelli che, magari con l’ausilio di narrazioni buffe, sarebbero disposti a votare anche il pagliaccio del circo pur di scardinare il sistema?”
Domanda interessante. Esiste quindi una nuova edizione 2.0 della classi sociali? Un fenomeno che differenzia le persone tra quelli che dal nuovo mondo globalizzato ci guadagnano e quelli che non lo fanno?
Anche un noto personaggio della cultura italiana sembra aver fatto propria quest’ipotesi recentemente.

Le élite di Alessandro Baricco
Alcune settimane fa Alessandro Baricco è intervenuto su Repubblica. Nel suo “E ora le élite si mettano in gioco” l’autore parla del populismo, pur evitando l’uso del termine stesso.
Semplificando molto, il noto scrittore raffigura una società separata in due: da una parte un’élite, appunto, di gente “in gamba” che farebbe girare il mondo; e dall’altra “gli altri”, quelli che fino ad oggi si sarebbero accontentati di quanto gli passava il sistema messo su dalle élite.
Adesso però qualcosa è cambiato. Qualcosa si è rotto. Gli altri non si accontenterebbero più e si sarebbero convinti che le élite non svolgano più il loro compito di generare benessere e lavoro (e con essi giustizia sociale) per tutti. Gli “eletti” tengono duro per preservare lo status quo, ma il popolo si è incazzato e non se la beve più. La crisi economica poi avrebbe esacerbato la situazione. Da questo contrasto nascerebbe il casino populista a cui assistiamo.
Una domanda spontanea è: chi sono le élite?
Scrive Baricco:
“Capiamoci su chi sono queste famose élites. Il medico, l’insegnante universitario, l’imprenditore, i dirigenti dell’azienda in cui lavoriamo, il Sindaco della vostra città, gli avvocati, i broker, molti giornalisti, molti artisti di successo, molti preti, molti politici, quelli che stanno nei consigli d’amministrazione, una buona parte di quelli che allo stadio vanno in tribuna, tutti quelli che hanno in casa più di 500 libri: potrei andare avanti per pagine, ma ci siamo capiti. I confini della categoria possono essere labili, ma insomma, le élites sono loro, son quegli umani lì.”
A pelle, quella di Baricco è una narrazione interessante, ma, come tutte le narrazioni interessanti, al solito, la domanda è: “…ma è anche vera?”
Esaminiamo da vicino.
Una popolazione è fatta da persone con istruzione, personalità, ricchezza e intelligenza diverse, tutte caratteristiche di per sé difficili da categorizzare rigidamente. Ed ho solo nominato le prime che mi vengono in mente. Una popolazione può essere “segmentata” in vari modi: Maschi e femmine. Chi guadagna più di X e chi di meno. Chi vive in questo o quel quartiere di qualche metropoli. E così via.
La “segmentazione” può avere un qualche senso per creare modelli che ci permettano di descrivere le società in cui viviamo, o qualche altro fenomeno. Alla fine della fiera, però, non scordiamo che, come tutti i modelli, stiamo descrivendo la realtà solo con approssimazione. Non a caso gli statistici e i data scientists ripetono spesso il detto: “tutti i modelli sono sbagliati. Qualcuno è utile”.
Sorge naturale la domanda: può essere preciso un modello che pretenda di separare l’intera società italiana, europea o addirittura mondiale secondo una logica binaria?
Risposta: no. È praticamente impossibile. Un modello così semplice non ha nessuna chance di produrre analisi sensate. Il mondo è molto più complesso di così.
Ci sono persone di potere che non sono ricche, persone ricche che non hanno cultura, altre che non provano neppure a influenzare la politica, politici che contano tanto e tanti che contano poco o niente.. e così via.
Secondo il racconto di Baricco, l’élite complotta per tenere sotto controllo gli altri secondo un piano ben definito lungo secoli. E chi sarebbe stata la mente di questo piano? E come è avvenuto l’arruolamento degli eletti? Domande interessanti a cui Baricco non risponde, un po’ come un complottista qualunque tra quelli che si trovano sul web. Mi chiedo: in qualità di programmatore informatico sono anch’io élite? Devo contare se in casa ho più di 500 libri?
E se scoprissi di essere élite, dove potrei trovare i dettagli del piano? Oppure mi contatteranno i servizi segreti quando dal quartiere generale si accorgono che ho le qualifiche necessarie?
Dubbi grossi, insomma. Il mondo è vario e una classificazione primitiva, buoni e cattivi, lenti da una parte e rock dall’altra, poteva forse andare bene per il molleggiato ad uso di un pubblico non particolarmente sofisticato, ma da un intellettuale come Baricco mi aspetterei un po’ di più.
Baricco, però, dice anche altro. Nel testo che segue, the Game indica la rivoluzione digitale degli ultimi 20 anni, con riferimento al suo ultimo libro:
Non sarebbe forse successo niente se non fosse per un altro tratto del Game, una sua imprecisione fatale. Il Game ha ridistribuito il potere, o almeno le possibilità: ma non ha ridistribuito il denaro. Non c’è nulla, nel Game, che lavori a una ridistribuzione della ricchezza. Del sapere, della possibilità, dei privilegi, sì. Della ricchezza, no. La dissimmetria è evidente. Non poteva che ottenere, alla lunga, una rabbia sociale che è dilagata silenziosamente come un’immensa pozzanghera di benzina. Devo aver già detto che poi la crisi economica ci ha tirato un fiammifero dentro. Acceso.
Élite a parte, un sentimento condiviso da molti c’è: il sistema economico globalizzato in cui viviamo vede qualcuno guadagnarci molto, altri guadagnarci meno o altri ancora perderci. In quel caso, non appare strano che gruppi diversi creino narrazioni contrapposte per difendere o per condannare lo status quo, in modo perfettamente analogo a quanto avveniva (e avviene!) per la dicotomia classica del secolo scorso tra destra e sinistra, anche se, a quanto pare, secondo linee di demarcazione diverse
A questo punto il discorso si fa interessante e, al tempo stesso, più complesso.
Cominciamo con i punti fermi. Se paragoniamo la situazione attuale a quella di trenta, quaranta o cinquant’anni fa, in generale, stiamo meglio o peggio?
Questa è una domanda difficile perché, come ci ha insegnato Kahneman, la risposta dipende in larga parte dalla narrazione ‘mitologica’ che abbiamo costruito del passato, oltre al peso che diamo alle sensazioni personali del momento. Il divario tra queste e la risposta data dalle metriche classiche con cui tradizionalmente misuriamo la qualità della vita può essere abissale
Ho letto di recente un libro abbastanza mallopposo che dimostra, dati alla mano, che la condizione umana è migliorata tantissimo secondo un po’ tutte le metriche. Per dirne una, ci basta guardare il grafico delle aspettative di vita per renderci conto che pure in Africa le persone hanno oggi l’aspettativa di vita che nei paesi occidentali abbiamo raggiunto negli anni 50.

Il libro in questione è “Enlightenment NOW” (“Illuminismo ADESSO”) dello psicologo americano (nonché divulgatore scientifico) Steven Pinker.

Pinker guarda la vita dell’uomo contemporaneo valutando diversi aspetti: Cosa si può comprare con uno stipendio. Le cure mediche a cui la popolazione ha generalmente accesso. Il livello di istruzione generale. Le aspettative di vita nei diversi paesi e così via.
In estrema sintesi: a livello globale, stiamo generalmente meglio ora di quanto siamo mai stati in passato. Non solo. Pinker spiega che tutto questo è stato reso possibile dalla globalizzazione, ovvero l’architettura mondiale grazie alla quale ogni paese produce i beni che gli vengono meglio e li esporta a basso costo un po’ in tutto il mondo. Pinker afferma anche che le differenze di censo e di classe sociale hanno funzionato per creare benessere anche per i più poveri, e che se il ricco guadagna molto e gli altri guadagnano qualcosa, in generale è una cosa buona: alla fine tutti ci hanno guadagnato.
Personalmente penso che l’ottimismo di Pinker vada preso con le molle. Se da una parte è vero che il sistema basato su libero mercato, diritti civili e libero movimento di persone e merci ha funzionato bene fino ad oggi, dall’altra nulla ci garantisce che la formula continuerà a funzionare all’infinito. Il problema ecologico è la prima conseguenza di una crescita che non può essere illimitata. Oltre a quello, gli sviluppi tecnologici tumultuosi a cui assistiamo avranno conseguenze enormi sul lavoro e su altri aspetti della nostra società.
Ma non solo.
Se consideriamo l’Italia, vediamo, ad esempio, che il debito pubblico ha portato ad un calo della spesa sanitaria e con esso un certo calo delle aspettative di vita medie dei cittadini italiani, peraltro piuttosto alte rispetto a quelle di altri paesi.
Detto questo, è sicuramente vero che oggi non si sta male se paragoniamo la vita di un individuo medio a quella di anche pochi decenni fa. Prendiamo quindi per buona, con beneficio di inventario, la tesi che, secondo un po’ tutte le metriche classiche, l’umanità stia molto meglio ora di come stava prima.
Come mai allora i conti non tornano e i populisti riescono ad arruolare milioni di incazzati un po’ in tutti i paesi occidentali? Logica vorrebbe che una persona che vede soddisfatti i suoi bisogni primari meglio di quanto il sistema facesse alcuni decenni prima fosse relativamente contenta della situazione.
Qual’è il meccanismo che porta una persona con un lavoro decente ad indossare un gilet giallo e ad andare a sfasciare tutto? Oppure a votare convintamente partiti e personaggi platealmente inadeguati che non hanno proposta politica praticabile, ma solo una vaga promessa di cambiare tutto senza neanche spiegare come?
Se avessi davanti a me Pinker, gli chiederei: “Come puoi dire che le persone sono felici se si dichiarano insoddisfatte e, soprattutto, agiscono come tali?”

Al solito, la psicologia spiega in modo abbastanza semplice ciò che svariate narrazioni buffe non spiegano affatto. In particolare, occorre capire tre aspetti che giocano un ruolo fondamentale nel formare le narrazioni e i convincimenti di ogni persona.
Ho già parlato della dicotomia experiencing-self / remembering-self di Kahneman. Questo è uno degli aspetti. Gli altri due sono l’invidia e la paura. L’invidia e la paura possono alimentare narrazioni buffe e portare milioni di persone a percezioni non coerenti con la realtà “misurata”. Da lì a scelte dirompenti, anche irrazionali, il passo è breve. Ciò è tanto più vero in un mondo in cui media e social sono uno strumento formidabile (e disponibile a chiunque) per influenzare le menti tramite i bias cognitivi.
Procediamo con ordine.
L’invidia
Per quanto riguarda l’insoddisfazione, stare bene noi non è necessariamente sufficiente per essere felici. Crediateci o no, avere quanto ci basta potrebbe non essere abbastanza se quelli intorno a noi hanno di più. Specialmente se TV e social sono lì a ricordarci questa cosa continuamente. Specialmente se ci convinciamo che la felicità la portino l’iPhone da 1000 euro, le vacanze esotiche o la macchina nuova. Specialmente se arriviamo alla conclusione che nel mancato accesso a certe vanità consumistiche ci sia qualcosa di ingiusto.
L’invidia è un sentimento profondo. Essa è così forte e radicata che non è nemmeno un’esclusiva umana: l’invidia è stata dimostrata nelle scimmie e anche in altri mammiferi.
Un etologo olandese, Frans de Waal, è autore di scoperte sorprendenti riguardo alle scimmie e al fatto che anch’esse abbiano valori morali che, se De Waal non ci avesse dimostrato il contrario, attribuiremmo solo agli umani. Un esperimento particolarmente significativo ha posto due scimmie cappuccine in gabbie limitrofe. L’operatore indicava a ogni scimmia di restituire una delle biglie che aveva nella gabbia. Come ricompensa, ogni scimmia riceveva una fettina di cetriolo, ricompensa che entrambe trovavano adeguata per lo sforzo profuso.
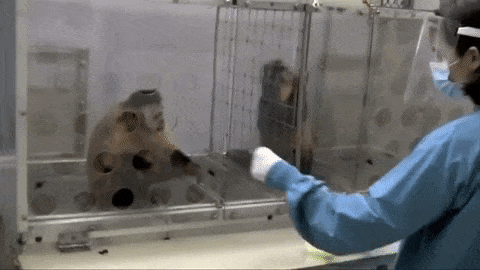
Ad un certo punto l’operatore ha iniziato a premiare la seconda scimmia con un più ghiotto chicco d’uva, mentre la prima continuava a ricevere il cetriolo. Ebbene, la prima scimmia si risente della cosa platealmente, tirando il cetriolo all’operatore, scuotendo la recinzione della gabbia per manifestare la sua rabbia contro l’ingiustizia subita. “Che cacchio mi hai dato? Voglio anch’io l’uva!” avrebbe urlato la scimmietta se avesse avuto il dono della parola.
Evidentemente l’invidia e il senso di equità non sono una caratteristica esclusivamente umana, ma la condividiamo con altri animali. Sono certo di aver letto da qualche parte che esperimenti con cani ed elefanti hanno portato a risultati analoghi.
Stando così le cose, non stupisce che anche molti umani trovino ingiusto che alcuni membri della società abbiano più di altri (in particolare loro). E non stupisce che la storia dell’umanità sia passata attraverso il marxismo, ovvero il tentativo più potente in assoluto di creare una narrazione egualitarista.
Il marxismo è sostanzialmente tramontato davanti alla constatazione che si stava meglio nei paesi democratici ad economia di mercato. Meglio un sistema che distribuisce le ricchezze in maniera non equa rispetto a uno che, equamente, distribuisce la povertà a tutti.
Il tramonto del marxismo, però, non ha rappresentato il tramonto dell’invidia. Se al posto del cetriolo ci mettiamo uno stipendio da 1300 euro, la somiglianza tra l’homo populista e lo scimpanzé di Frans De Waal appare sorprendente.
Piccola parentesi sulla crisi della sinistra italiana
Volendo aprire una parentesi, la cosiddetta “crisi della sinistra italiana” può essere spiegata facilmente nei termini di invidia e di tensione tra experiencing e remembering self. Fino a pochi decenni fa la sinistra italiana di stampo marxista sosteneva una narrazione secondo cui sarebbe arrivato il socialismo a riportare “giustizia” ed equità sociale. Tanto bastava ad un operaio per fare quotidianamente il suo lavoro nella fabbrica del ricco in attesa della venuta di ‘baffone’ o chi per lui. La narrazione del lavoratore era salvaguardata e l’invidia era tenuta a bada.

Con la caduta del Comunismo globale, una parte della sinistra italiana ha ceduto dinanzi ad una constatazione che appariva ovvia: “Possiamo fare maggiormente l’interesse delle classi meno abbienti abbracciando il Capitale, anziché ponendoci in modo antagonista ad esso. Se l’economia di mercato tira, tante più risorse ci saranno per migliorare la vita del nostro elettorato.”
In effetti, se l’obiettivo principale di un leader di sinistra fosse quello di massimizzare la creazione dei posti di lavoro e allargare lo stato sociale, scendere a patti con industriali e imprenditori apparirebbe una scelta logica, o addirittura scontata. Meglio uno che lavori senza l’articolo 18 rispetto a un disoccupato che, se lavorasse, avrebbe tutele che neanche in scandinavia.
Questo ragionamento non fa una piega dal punto di vista dell’experiencing self. Dal punto di vista dell’io che ricorda e che costruisce una narrazione di vita, però, questo approccio è una catastrofe.
L’accettazione (alcuni direbbero la resa) dei partiti di sinistra alla forza del Capitale è stato un colpo non da poco per la narrazione di chi si sente di sinistra. La storia che l’imprenditore non fosse più l’antagonista, ma, anzi, era un amicone a cui era pure meglio essere grati per averci portato un po’ di lavoro ha fatto traballare le certezze di molti: dal purgatorio (con speranza di paradiso) si è passati all’inferno.

Detta in altro modo, se aggiungiamo all’equazione il remembering self, i conti non tornano più. “Ridateci la storia di baffone” gridano, più o meno consciamente, buona parte di quelli che votavano per il PCI una volta. E se il marxismo non è più praticabile, anche un movimento sgangherato come quello di Beppe Grillo è meglio della resa incondizionata al credo capitalista. “Non hanno un piano. Sparano cazzate a tutto spiano. Sono impreparati. Sono stupidi come capre…ma almeno giurano di voler far la guerra al Capitale e tanto ci basta.”
Ecco bella e spiegata la crisi della sinistra italiana e lo sbandamento davanti al populismo.
Fine della parentesi.

La Paura
Come sapevano (e ancora sanno) perfettamente quelli di Cambridge Analytica, se si vuole manipolare il consenso, il modo migliore è spostarlo a poco a poco, facendo balenare immagini minacciose nella mente delle persone. Ci penseranno loro da sole a creare “narrazioni di reazione” alla minaccia che viene percepita. Ovviamente queste reazioni vanno nel verso voluto dal manipolatore di turno.
Che la paura abbia un peso tanto predominante negli umani non ci deve stupire. Fino a due o trecentomila anni fa, gli umani stavano più o meno a meno a metà della catena alimentare. Leoni, pantere, coccodrilli, squali erano tutte specie da cui era meglio tenersi alla larga: il confronto sarebbe stato perdente. Poi abbiamo scoperto che, con il linguaggio, potevamo organizzarci e infinocchiare tutte le altre specie, rendendole pressoché innocue o, addirittura, soggiogandole.
Il nostro senso del pericolo, però, è rimasto uguale: ipertrofico rispetto alle minacce reali del mondo (ma, al tempo stesso, poco sviluppato rispetto alle minacce nuove, qual’è l’uso dei social per manipolare i nostri pensieri).
Chi vuole manipolare i nostri pensieri ha buon gioco nel farci percepire paure esagerate al fine di convincerci a sottoscrivere una polizza assicurativa, comprare una pistola da tenere in casa o votare per un politico magari “maneggione”, ma nemico giurato della criminalità, particolarmente quella straniera.
Per i populisti di destra, spingere sulla paura dello straniero è fin troppo facile. Esiste un continente di 1,2 miliardi di persone che preme per venire in Italia e in Europa. L’etica dei diritti umani e del libero movimento di persone potrebbe non essere più adeguata a gestire il problema. La narrazione sovranista trova terreno fertile in questo contesto e la paura fa da ottimo concime. Non affronto la questione in questo articolo perché l’ho già fatto in precedenza, ma non stupisce che la gente si senta minacciata dal rischio di un’immigrazione massiccia dall’Africa.
L’aspetto dell’immigrazione non è l’unico che fa scattare la paura negli occidentali. Ce n’è uno più subdolo, ma anch’esso presente e forse ancora più pauroso.
La globalizzazione, che fino ad oggi ha avuto lati prevalentemente positivi, comincia a fare paura a tanti, specialmente considerando le ultime prospettive introdotte dall’Intelligenza Artificiale e che si tradurranno quasi sicuramente in centinaia di milioni di posti di lavoro persi.
Alcune sere fa giornali e telegiornali hanno parlato di Davide Dattoli, un connazionale che, grazie alla sua creazione, Talent Garden, è entrato nella lista dei “Forbes 30 under 30” dei giovani imprenditori, unico tra gli italiani. Un ragazzo veramente in gamba.

Anche il TG1 lo ha intervistato e Dattoli ha dichiarato:
“La vera sfida oggi è capire che i lavori cambieranno continuamente. Ogni cinque anni nascono e muoiono nuovi lavori. Il tema diventa formarsi, andare a lavorare e subito tornare a formarsi.
[giornalista] Quali saranno le professioni del domani, un domani che potrebbe essere non tra vent’anni, ma già tra un anno?
Vediamo sempre più la necessità di nuovi sviluppatori software che diventano i nuovi operai del futuro. Vediamo la necessità di esperti di dati, persone che li utilizzano per costruire nuove soluzioni. L’esperto di user experience quindi l’idea del design digitale applicato alla tecnologia. Ma anche esperti di marketing che siano in grado di comunicare alle aziende online.”
Sentendo questa dichiarazione ho pensato varie cose. Ho pensato che, almeno fino a qualche anno fa, anch’io avrei potuto rilasciare una dichiarazione del genere. Del resto chi lavora nel campo dell’informatica sa benissimo di cosa si parla. Fare gli informatici significa essere costantemente obbligati ad aggiornarsi. Non si fa in tempo a imparare per bene l’ultimo mirabolante framework di sviluppo per un qualunque linguaggio di programmazione che, tre anni dopo, quello è già considerato vetusto e un più moderno sfidante si propone per prenderne il posto.
Oggi, però, ci penserei bene prima di fare una dichiarazione come quella di Dattoli. E questo non perché io pensi che non sia più vera (lo è!), ma perché, guardandola bene, essa assomiglia dannatamente alla descrizione di un futuro distopico, un futuro in cui le persone, lungi dal vivere esistenze tranquille e soddisfacenti, sono più facilmente frustrate e costantemente in lotta con il senso di inadeguatezza. Per non parlare del tempo rubato alla propria famiglia e alle attività ricreative che rendono la vita un minimo piacevole (anche l’experiencing self vuole la sua parte).
Pensiamoci bene. Per tutta la vita, quando abbiamo parlato della bellezza e dei vantaggi della tecnologia, lo abbiamo sempre fatto spiegando tutte le brutte cose che sono state debellate e tutte le belle cose che sono arrivate. Vado a braccio: acqua pulita, cibo in abbondanza, case calde d’inverno e fresche d’estate, cure mediche efficaci, accesso libero e immediato alla conoscenza, cinema, televisione, ecc. Un affarone per tutti, quindi.
Tutto bellissimo, ma adesso i conti potrebbero non tornare più. Se per guadagnarci da vivere non basterà impararci un mestiere da giovani, ma saremo costretti fino a tarda età a reinventarci costantemente in un mondo del lavoro sempre più in movimento, cosa distinguerebbe la nostra condizione da quella di moderna schiavitù?
E questo senza considerare che non tutti hanno le capacità di adattarsi, specie dopo aver superato i cinquant’anni. Come la mettiamo con quelli che per campare fanno i camerieri o guidano un taxi? Consigliamo anche a loro di diventari sviluppatori software, graphic designer o esperti di Machine Learning?
Se poi pensiamo che oltre agli autisti rischiano il rimpiazzo anche dottori, avvocati, giornalisti ed insegnanti, l’angoscia potrebbe assalire anche quelli che si sono sempre considerati al sicuro.
Se la situazione è quella descritta da Dattoli, in effetti si può capire l’ansia che attanaglia l’uomo contemporaneo quando intuisce di non poter stare al passo col progresso tecnologico e tutto ciò che ne consegue. Da questo punto di vista Santarpia sembra avere qualche ragione.
Se questa è la situazione, non c’è da stupirsi se la gente, in Italia o altrove, cominci a perdere fiducia nella tecnologia come soluzione di tutti i mali: vedono con una certa chiarezza il giorno quando non avranno più un lavoro, ma nessuno gli spiega cosa faranno il giorno dopo.
La risposta alla domanda
“Se io non operassi nel settore tecnologico, sarei così veloce a liquidare la situazione attuale con un “tant’è”? Oppure mi unirei al folto gruppo di quelli che, magari con l’ausilio di narrazioni buffe, sarebbero disposti a votare anche il pagliaccio del circo pur di scardinare il sistema?”
La risposta alla domanda non c’è. Non la so nemmeno io con certezza. Potrebbe benissimo essere che, se la globalizzazione non mi avesse in qualche modo sorriso, adesso infoltirei la schiera dei populisti sproloquianti sui social. Oppure no. Forse il mio gusto acquisito per la verità non edulcorata mi avrebbe portato alle stesse conclusioni, benché amare in quel caso. Una cosa è certa però: non avrebbe fatto tantissima differenza nel grande schema delle cose.
Alla fine della fiera, giustizia, uguaglianza, diritti e doveri sono solo invenzioni umane. Gli attori umani si agitano sul palcoscenico del mondo, poi si calmano, piangono, ridono, cambiano idea a seconda della convenienza e del momento. A volte creano narrazioni abbastanza convincenti ed altri gli credono e le fanno proprie. Se si riesce a vedere le cose da fuori con un piccolo sforzo di astrazione, sembra un vecchio film comico in bianco e nero, uno di quelli coi movimenti accelerati accompagnati dal pianoforte.
Quando le cose vanno male, però, c’è poco da ridere. Potrebbe uscirne una bella rissa, tipo quella di cui noi sapiens siamo stati protagonisti nel secolo scorso. E se per caso partono le armi atomiche, oggi andrebbe anche peggio. Molto peggio.
Quindi?
Un’altra reazione interessante è stata quella di Patrizia su di un gruppo FB di Radio3 Rai in cui qualcuno aveva postato l’articolo sul populismo. La signora chiese a me per chi avrebbe dovuto votare alla luce di quanto avevo scritto e si risentì quando le dissi che non avevo una risposta per lei.
Lo scambio fu interessante. In pratica Patrizia diceva: “Come ti permetti di demolire la mia costruzione senza indicarne una alternativa?”
L’obiezione non stupisce del tutto. Le maggiorparte delle persone vogliono una narrazione da fare propria e poi basta. Che palle essere continuamente costretti a rivedere e a reinventare il proprio sistema di credenze e di valori. Come mi permettevo io di rimettere così tante convinzioni pesantemente in gioco per poi lasciare il lettore in mezzo al guado a cavarsela da solo?
Purtroppo per Patrizia non ho soluzioni facili ai problemi del mondo. Avallare un partito (italiano per giunta) rispetto ad un altro? Non ci penso neanche!
Quindi non ho pretese di indicare cosa occorra fare di preciso in futuro. Posso però fare alcune considerazioni ovvie su cosa non occorra assolutamente fare. Ci sono alcuni problemi seri davanti a noi, quelli che minacciano l’esistenza dell’umanità. E il modo per affrontarli sicuramente non è fare concessioni all’ondata di deficienza mentale populista che attraversa l’Italia, l’Europa e il mondo intero.
Le sfide del futuro prossimo
Le sfide che aspettano i governanti sono immense.
La catastrofe climatica appare incombente. Con buona probabilità, porvi rimedio significherà il redde rationem di un modello economico basato sull’assunto della crescita illimitata. Riuscirà il sistema attuale ad adattarsi e a dare risposte valide ad abbastanza persone? Oppure è reale il rischio che tutto crolli lasciando il mondo intero senza istituzioni in grado di gestire il caos ed evitare conflitti catastrofici?
Nessuno ha una risposta in questo momento. Non ce l’hanno i partiti tradizionali, e tantomeno ce l’hanno i populisti che brancolano nel buio, con l’aggravante della mancanza di una classe dirigente degna di questo nome.
L’altro grande problema è connesso ai cambiamenti introdotti dalla globalizzazione.
Scriveva “9702” in un commento all’articolo:
“perché scervellarsi per capire le istanze di milioni di persone che stanno rifiutando la globalizzazione, perché capire l’avversione delle fasce più deboli nei confronti delle ondate migratorie, è sufficiente credere che sia tutto un complotto della Russia per conquistare il mondo (?), con la complicità di governi deboli (??) per mettersi l’anima in pace e continuare a credere che oggi viviamo nel migliore dei mondi possibile.
L’articolista non vuole saperne dei grandi problemi del nostro tempo, dalle disuguaglianze al fatto che mezza europa ancora non è tornata ai livelli di reddito pre crisi, che in tutta europa non c’è mai stata così tanta povertà come oggi, che in USA il tasso di occupazione sta crollando da 20 anni: lui vuole solo credere che le cose vanno bene, perchè LUI sta bene”
Ogni volta che si parla di globalizzazione, inevitabilmente il discorso viene portato sulle disuguaglianze.
Questo, però, significa dare per scontato che le disuguaglianze siano in assoluto un male. E qui c’è un grosso problema: quest’affermazione è tutta da dimostrare.
Abbiamo detto che Steven Pinker pensa, dati alla mano, che non sia affatto così. Dalla globalizzazione alcuni ottengono più degli altri. Questo è vero. Molto di più, infatti. Se si pensa che alcuni dei “fortunati vincitori” hanno accumulato ricchezze pari al PIL di una piccola nazione, sicuramente è il caso di approfondire la questione.
Eppure, a rigor di logica, l’equazione disuguaglianza uguale male assoluto non è ovvia per niente.
Se incarcerassimo le 100 mila persone più ricche del pianeta, confiscassimo tutti i loro averi e li ridistribuissimo al 20% più povero della popolazione, riusciremmo a migliorare la situazione di questi ultimi e di altri in maniera significativa e duratura? Credo proprio di no. Non ci riusciremmo. Infatti sarebbe garantito l’effetto opposto. Verrebbe meno l’infrastruttura che permette al mondo di generare beni e servizi che tengono insieme la nostra economia. Gli stati perderebbero le risorse che servono proprio a fare il bene della società in generale, non solo dei ricchi. Qualsiasi cosa si faccia riguardo alla disuguaglianze, occorre fare attenzioni che non si butti via il bambino con l’acqua sporca facendo inceppare un meccanismo che offre qualcosa a tutti.
Detto questo, anche l’invidia e il remembering self della gente vogliono la loro parte, come abbiamo spiegato. Un meccanismo per diminuire la percezione di disuguaglianza sarebbe sicuramente positivo.
Come risolvere questo grattacapo?
Difficile dirlo con certezza, ma alcune linee guida sembrano chiare: con calma e razionalità. Occorrono riforme che massimizzino l’utilità sociale, magari diminuendo anche il senso di ingiustizia “percepito”, ma preservando il ceto medio e la classe imprenditoriale. Gli espropri proletari sarebbero una bella soddisfazione per molti, certo, ma, passata l’euforia iniziale, lascerebbero un paese nell’incapacità di far ripartire l’economia. Ed è l’economia che, funzionando, produce le risorse per lo stato sociale, mica lo Stato che stampa i soldi.
I populisti parte del problema
Il problema dei populisti è che essi sono l’antitesi della razionalità di cui il mondo ha bisogno.
Sfruttando i social, i populisti fomentano paura, invidia e scontento per arrivare al potere, ma non hanno uno straccio di piano razionale che porti a migliorare i problemi che hanno sfruttato per convincere la gente a votarli.
Se l’anno passato era facile prevedere cosa sarebbe successo ove i populisti fossero arrivati al potere, gli ultimi dodici mesi hanno fornito degli esempi pratici significativi, sia in Italia che all’estero, di come le variegate proposte populiste siano inapplicabili nella pratica.

L’uscita dall’Euro è forse l’esempio più eclatante: dopo aver fatto campagna elettorale contro l’Euro e contro l’Europa, il governo populista italiano ha scelto un ministro delle finanze che gira il mondo giurando che mai e poi mai il governo italiano ha pensato di lasciare l’unione monetaria europea.
L’aspetto economico è ugualmente importante. In passato i populisti italiani avevano parlato (anche) di decrescita felice, ma ovviamente non hanno prospettato un piano che indichi cosa significhi questo in pratica (e, soprattutto, chi pagherà per cosa). Il tema è stato prontamente abbandonato una volta arrivati al governo per timore delle ripercussioni economiche sulla crescita dell’Italia.
Per quanto riguarda la sensibilità ai problemi ambientali, il movimento di Beppe Grillo aveva rivendicato fin dalla sua fondazione una scelta ecologista. In Francia i gilet gialli sono scesi in piazza in rivolta contro l’aumento del prezzo della benzina che era stato deciso come parte degli accordi per il miglioramento climatico. I 5 Stelle in Italia hanno prontamente sostenuto la protesta francese in contraddizione con le parole del passato.
In Inghilterra i promotori della Brexit hanno avuto buon gioco nel vincere il referendum grazie a Cambridge Analytica. Peccato che nessuno avesse pensato a come risolvere tutta una serie di questioni fondamentali per il paese riguardanti il commercio e i confini dello Stato.
Sempre i populisti italiani (5 Stelle) parlano di Universal Basic Income, anche noto in Italia come stipendio di cittadinanza. Il finanziamento della misura assistenzialistica avviene facendo deficit (e quindi debito pubblico che pesa sulle generazioni future). Ad oggi, il ministro Tria rifiuta di spiegare come verrà finanziato il provvedimento il prossimo anno. Ovviamente il problema è solo rimandato.
Riguardo allo stipendio di cittadinanza, vale la pena aprire una breve parentesi. Appare ovvio fin da subito che chi propone la misura non tenga conto delle necessità del remembering relf. Ammesso (e non concesso) che lo stipendio di cittadinanza soddisfi le necessità dell’experiencing self, chi lo percepisce difficilmente sarà felice di trovarsi relegato nel ruolo di percettore di elemosina di Stato. Il remembering self ne esce totalmente umiliato.
Sarebbe molto più saggio adoperarsi affinché le persone trovino un’occupazione.
Conclusione
I movimento populisti continuano ad avere successo elettorale in tutto il mondo, nonostante la mancanza di un’offerta politica praticabile e adeguata a far fronte alle sfide che l’umanità ha davanti.
Alcuni ritengono il fenomeno populista in qualche modo positivo, in quanto foriero di cambiamento e capace di portare l’attenzione sui problemi della gente.
Chi scrive è in disaccordo con questa visione. Per mezzo dei social network, i popoli vengono manipolati da chi vuole raggiungere il successo elettorale e da chi vuole creare scompiglio in paesi terzi con finalità geopolitiche. Questo porta più lontano da soluzioni razionali dei problemi, che sono ciò di cui il mondo ha disperatamente bisogno.
Una cosa appare certa: non solo i populisti non hanno alcuna soluzione, ma appaiono, semmai, come parte integrante del problema.
L’incapacità dei populisti di confrontarsi con i problemi reali è conclamata in Italia come altrove. La loro speranza è che il riferimento costante alle sensazioni del popolo possa magicamente generare soluzioni, ma tale speranza è frustrata quotidianamente dall’esperienza pratica. Come già spiegato, la conseguenza diretta di aver selezionato i propri rappresentanti tra i succubi dell’effetto Dunning-Kruger ha portato a governi ridicoli e incapaci di elaborare piani a lungo termine.
Eppure di problemi da risolvere ce ne sarebbero molti e molto seri.
Il problema ecologico potrebbe accelerare il momento in cui l’economia del libero mercato non riesce più a soddisfare le esigenze dell’umanità, senza che un’organizzazione sociale alternativa sia stata ipotizzata.
L’automazione possibile grazie all’intelligenza artificiale promette di spazzare via centinaia di milioni di posti di lavoro in tutto il mondo, spingendo verso il basso i salari di chi ancora lavorerà. Anche quando i bisogni materiali delle persone fossero soddisfatti (experiencing self), la frustrazione che deriverebbe da tale situazione rischia di essere devastante per il remembering self di milioni di persone.
Il remembering self dell’uomo di domani potrebbe trovarsi davanti una sfida ben peggiore di quella rappresentata dallo sfruttamento capitalista: l’inutilità e l’irrilevanza. Non ho sentito nessuna proposta seria su come affrontare questi problemi, né da parte dei populisti né da altri.
Come gestiremo le sfide di un futuro prossimo che è praticamente già presente?
Questa è la risposta che mi piacerebbe sentire da chi si candida a governare una nazione. Le amenità propinate dai populisti sono una distrazione, non una soluzione.












