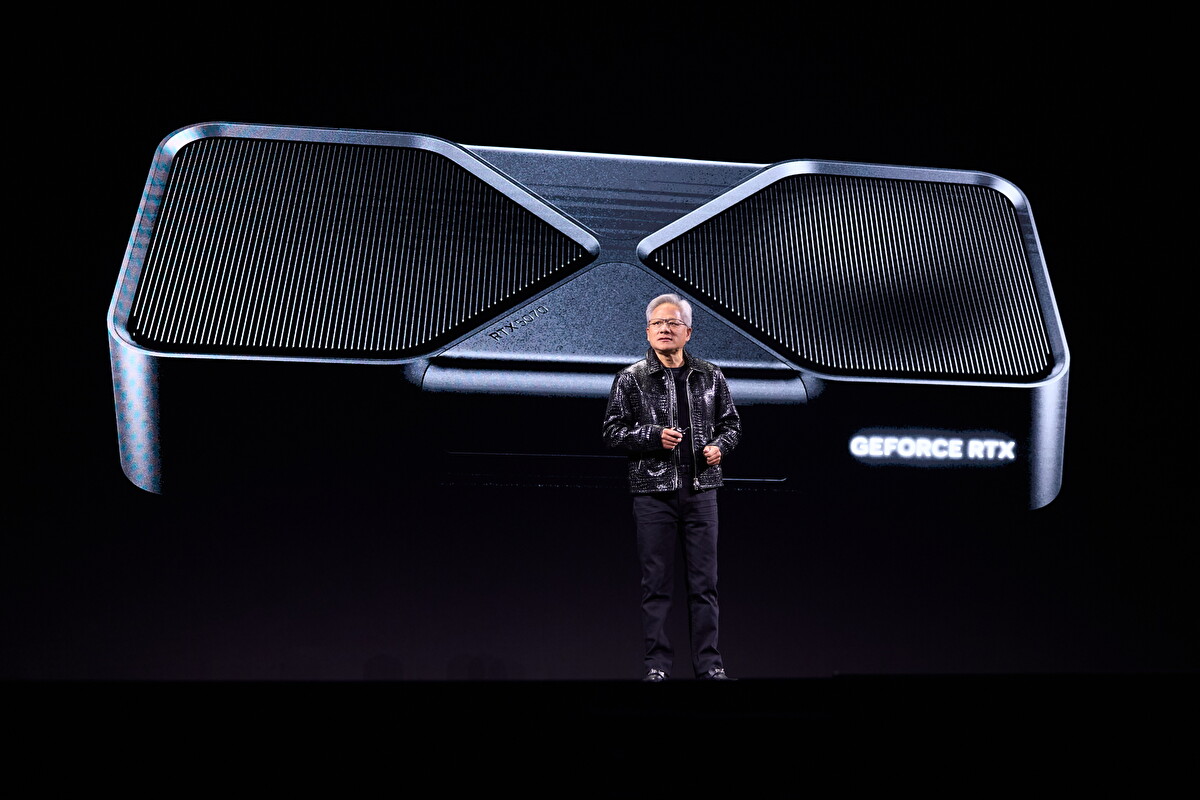È uno di quegli eventi che rimangono lì, sedimentati sul fondo, nella coscienza collettiva di un Paese che a ogni ricorrenza si guarda allo specchio e si scopre un tantino più vecchio, un tantino più stanco. Il caso Moro come la strage di via D’Amelio, è uno di quei “misteri italiani” o “ferite mai rimarginate”, così li ripropongono alla tv: sullo sfondo le immagini della tragedia raccontata dai giornali dell’epoca, che si alternano alle testimonianze di chi ancora sopravvive, anno dopo anno. È qualcosa che sai che c’è e che quasi sicuramente rimarrà così, irrisolto. Ogni tanto qualcuno fa una rivelazione, emerge una mezza verità, un anniversario tondo fa più rumore di altri. Si mettono meglio a fuoco alcuni contorni, ma al nocciolo, si fa sempre più fatica ad arrivare.
In questi giorni a cavallo tra via Fani e via Caetani, fra l’agguato del 16 marzo e il ritrovamento, il 9 maggio 1978, del cadavere dello statista della Democrazia Cristiana, la lettura del libro inchiesta “La criminalità servente nel Caso Moro” di Simona Zecchi (collaboratrice della prima ora della Voce) offre la preziosa occasione di una prospettiva altra.
Quella di una criminalità organizzata, la ‘ndrangheta su tutte, che si fa protagonista e non più presenza aleggiante e marginale nel rapimento e nell’uccisione del presidente: cruciale non soltanto sulla scena del crimine, ma soprattutto nei momenti chiave del sequestro e dei suoi sviluppi, nonché nella destabilizzazione del quadro politico-criminale che si andrà a delineare negli anni successivi.
Attraverso salti temporali e spaziali, fondamentali a comprendere la vicenda Moro nella sua regia capillare, e utilizzando la tecnica della piramide rovesciata, Simona Zecchi (già autrice per la Voce di New York di articoli in esclusiva sul caso) si propone di ricomporre ciò che in maniera così unitaria non si era ancora ricostruito. Per farlo, si serve di documenti, interviste, fotografie, analisi dimostrative, così da far emergere in controluce le connessioni tra i fatti. Fatti anche apparentemente slegati che, a distanza di decenni, si sovrappongono e si intersecano tra loro con importanti riverberi sino ai giorni nostri, rivelando tutta la drammatica attualità dell’affaire Moro.
Simona, partiamo dal titolo del tuo libro, che dà una chiave di lettura dirompente rispetto ai precedenti lavori sul rapimento e l’uccisione dello statista della Dc. Innanzitutto viene rovesciata la prospettiva: la criminalità si fa protagonista, e non più presenza marginale, sullo sfondo. Al contempo si ha l’impressione che la vicenda Moro funga anche da “espediente”, in quanto caso principe per mostrare come siano mutate le logiche politico-criminali che hanno profondamente trasformato il nostro Paese negli ultimi 40 anni. È così?
“Sì, ho rovesciato l’approccio dal quale partire per raccontare, attraverso l’inchiesta, il Caso Moro proprio perché era necessario si capisse che il ruolo della criminalità organizzata non è né una fantasia né tanto meno un qualcosa di aleatorio o marginale. Ed è più esatto dire che i ruoli e i livelli della criminalità organizzata sono stati diversi a seconda delle correnti, delle spaccature e del volere politico. Al centro il ruolo madre della ‘ndrangheta inserita in una struttura che ho chiamato “riservata”, espressione questa mutuata da una definizione del magistrato di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, audito dalla Seconda Commissione Moro nel settembre del 2017. Le sue parole valgono quasi la metà della intera Commissione. È proprio così, la tragedia di Moro e dei cinque agenti della scorta ha cambiato in quell’anno cruciale per il nostro Paese radicalmente gli equilibri politico criminali e quindi il nostro Paese”.

A colpire è poi l’utilizzo del termine “servente”, al quale all’interno del libro attribuisci una doppia valenza. Vuoi spiegarcela?
“Servente’ è un termine che ho voluto fortemente utilizzare con il rischio che potesse sembrare a primo impatto troppo criptico o tecnico. Ma credo che bisogna anche avere un po’ di “coraggio” quando si maneggia la inchiesta e far comprendere con altre parole quello che sta dietro i fatti tragici della nostra prima repubblica che ci hanno traghettato fino a questa terza fase. È una criminalità servente perché si è posta e si pone al servizio di altre strutture (servizi segreti, massoneria e politica) ed è da queste servita. È un ruolo che attraversa appunto il Caso Moro ma lo supera arrivando fino ai nostri giorni. Come ad esempio il cosiddetto processo trattativa stato-mafia di cui proprio il 20 aprile è emerso il verdetto di primo grado con la condanna di alti ufficiali del Ros, esponenti politici e criminali mafiosi. Questo non dovrebbe già dire qualcosa?”.

Negli anni che precedono e seguono il caso Moro, a cambiare sono anche la stessa struttura e il modus operandi delle mafie, in particolar modo della ‘ndrangheta, come tratteggi nel libro. Quali i cambiamenti più significativi che si realizzano intorno a quel 1978? Possiamo dire che il caso Moro faccia un po’ da spartiacque?
“I momenti di spartiacque che hanno caratterizzato questo Paese sono stati diversi e hanno di pari passo accompagnato anche le modifiche all’interno dei sistemi politico criminali, e ovviamente all’interno delle stesse organizzazioni criminali che si muovono su due livelli diversi tra loro. L’omicidio Moro in sé funge da elemento destabilizzante per la politica che stava avanzando così come era nelle intenzioni del presidente Dc”.
La Calabria in questa storia si fa luogo cruciale e nel tuo libro ne evidenzi anche degli aspetti poco indagati: negli anni si è parlato soprattutto dell’apporto della ‘ndrangheta in termini di armi e dell’emergere di ‘ndranghetisti sul luogo della strage di via Fani – tu stessa parli di De Vuono (da alcuni identificato come l’esecutore materiale dell’omicidio Moro) e di Antonio Nirta – ma tu spieghi anche che i cervelli delle Brigate Rosse operarono in Calabria, citando l’università di Arcavacata individuata quale ambiente favorevole all’eversione…
“Sì, esatto. La questione è che le due cose non sono soltanto elementi posti insieme per cercare di dare un quadro. Altri elementi indiziari vi si intersecano e li collegano e li percorrono come ho scritto (tipico del lavoro investigativo). Tutti questi elementi sono stati trattati in procedimenti diversi (quasi tutti altri lasciati andare diciamo) quindi spezzettati dispersi, e nessuno anche giudiziariamente ha mai pensato di riunirli. Le armi sono importanti certo, infatti è tema di indagine della procura di Roma che li ha acquisiti dalla procura di Reggio Calabria. E ci rendiamo conto?

Nell’arsenale della mafia calabrese ci sarebbero (se riscontrato) armi utilizzate per la strage di via Fani. Il ruolo della “macchina dei sequestri” che sviscero in più parti nel libro con un paragrafo apposito anche deve far comprendere come il Sequestro Moro senza la organizzazione della ‘ndrangheta in particolare, avallata da altre strutture, non poteva andare in porto. L’università calabrese porta all’emersione di diversi legami sia con le organizzazioni estreme legate ai vertici delle BR (le seconde BR nate nel 1975, è importante questo dato) sia con ambienti massonici e criminali. A dimostrazione che certi sistemi sono avulsi dalla ideologia. Ma è un capitolo che va letto bene e approfondito anche giudiziariamente”.
Un altro tema importante da te affrontato è quello delle connessioni della criminalità organizzata con l’eversione di destra, ma anche con quella di sinistra, nonché tra stessi rossi e neri: legami che, scrivi, “non sono mai emersi chiaramente, quasi fossero un tabù”. Pensi che lo siano tuttora?
“E appunto. Riagganciandomi alla tua domanda con quest’ultima parte è proprio così. E per quanto riguarda le connivenze fra rossi e neri diversi sarebbero gli episodi, soprattutto avvenuti a Roma, durante i cosiddetti anni di piombo, che vi si potrebbero ricondurre e che hanno cambiato assetti politici anche locali arrivando fino ai nostri giorni o fermandosi un poco prima…

Purtroppo sono diverse le resistenze che si oppongono alla ricerca della verità che possa dare anche un quadro storico condiviso, e non tanto perché resiste una certa “ideologia” che con la ‘idea’ di sinistra o di destra ha poco o nulla a che fare, quanto perché ci sono posizioni tuttora da difendere che non necessariamente riguardano “poltrone” o posizioni di potere. Anche, ma non solo. Nel libro ho riportato un esempio di questa connivenza perché più vicino al caso Moro, ma ve ne sono degli altri”.
Un passaggio importante per poter leggere la vicenda Moro in un contesto più ampio, è sicuramente quello che dedichi alla disamina del sequestro, inteso quale strumento di cui si servono i poteri forti per raggiungere i loro obiettivi. Citi quindi due preziosi contributi, uno del vicequestore di Trapani Roberto Peri, l’altro di Pier Paolo Pasolini, intellettuale peraltro a te molto caro. A quali conclusioni erano arrivate, pur nella loro diversità, queste due figure?
“Il rapporto Peri è un documento importante che avevo scoperto proprio durante la mia inchiesta su Pier Paolo Pasolini (è anche citato nel libro Pasolini, Massacro di un Poeta, Ponte alle Grazie 2015). Per quel rapporto ringrazio il professor Enzo Guidotto, ex consulente della commissione antimafia e studioso dei fenomeni mafiosi di cui diffonde i contenuti nel Veneto. Ma solo addentrandomi nel caso Moro ne ho compresa la valenza. Perché il rapporto Peri da solo non bastava e non basta a capire qual è stata la portata delle dinamiche che si sono coadiuvate per portare avanti un certo sistema.
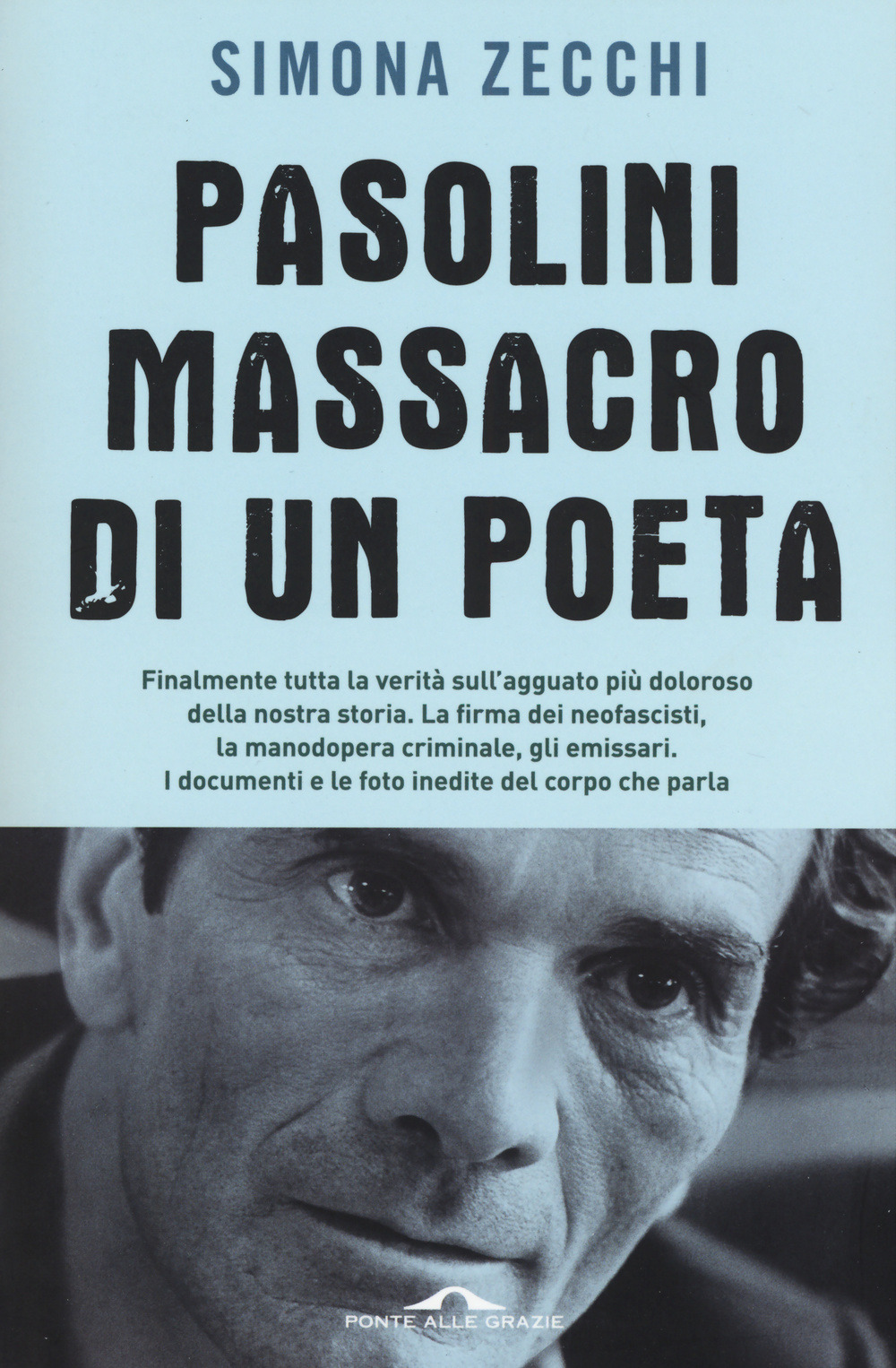
Infatti, ed è qui il cuore del libro, il rapporto Peri (nome del vicequestore di Trapani Roberto Peri che ha redatto il rapporto e svolto l’indagine, allontanato successivamente a questo rapporto) è il risultato di un’indagine sui sequestri, l’eversione e le mafie che anche il magistrato Vittorio Occorsio (ucciso sì da Concutelli di Ordine Nuovo nel 1976 ma il cui vero movente non è mai trapelato) stava portando avanti e l’indagine che anche il generale Dalla Chiesa stava svolgendo sugli stessi ambienti. Pasolini, dall’alto della sua profonda capacità di comprendere meccanismi e dinamiche indagare letterariamente (e non solo) i fenomeni, anche quando in corso, aveva compreso l’uso di certe strutture compresa la criminalità organizzata in certi sequestri e operazioni che avevano solo apparentemente una matrice terroristica (di sinistra o di destra). Nel libro, lo spiego attraverso la lettura e la citazione di un suo articolo che non è uno dei soliti citati che lo riguardano. È importante, leggetelo”.
Hai definito il lavoro dell’ultima Commissione Moro, “monco”, pur riconoscendone l’importanza. Perché? Quali elementi pensi avrebbero meritato maggiore approfondimento? Pensi la verità verrà mai a galla?
“Il lavoro della Commissione è secondo me incompleto per varie ragioni. Innanzitutto la brusca fine della legislatura che ha fatto uscire la terza e ultima relazione, (quella del dicembre 2017) che è importante ma appunto incompleta rispetto anche alle indagini che lì si sono svolte. Ma utilizzo il termine “monco” (le parole nel nostro mestiere sono importanti) perché più netto su molti aspetti. Una cosa è monca anche quando la si è voluta spezzare, tarpare o tombare.
Ci sono molti elementi riguardanti le strutture d’oltreoceano che sono solo affiorate in questa indagine svolta dalla Commissione e arrivate al grande pubblico e che alla fine del libro chiamo “interferenze” le quali in futuro potranno essere indagate. In questo senso lo ha appena fatto con il suo nuovo lavoro il giornalista Paolo Cucchiarelli nel suo libro “L’ultima notte di Aldo Moro” (Ponte alle Grazie 2018) che affronta in modo approfondito questo aspetto. Il lavoro della Commissione è stato monco anche sul ruolo della ‘ndrangheta da me approfondito e indagato ma alcuni dei consulenti che hanno svolto le indagini hanno fatto un egregio lavoro: i rapporti, le informative che costituiscono quella indagine (più delle relazioni in sé) sono molto importanti. Ma molte cose sono rimaste secretate”.