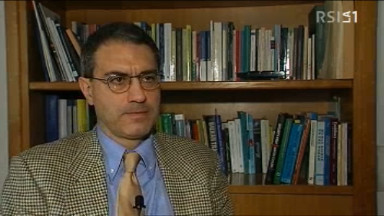Non è soltanto una questione di «carenza di leadership» e di «eccezionale debolezza». Certo: già da sole queste due gravi pecche bastano e avanzano per capire quali sono i problemi che rendono l’Italia «un sorvegliato speciale» sul palcoscenico internazionale. Ma di allarmante c’è ben altro nell’autorevole documento che contiene queste scoraggianti definizioni. Il Rapporto 2012 sulla politica estera italiana è redatto congiuntamente da due dei più importanti e ascoltati think tank tricolori: lo IAI, l’istituto affari internazionali con sede a Roma, e l’ISPI, l’istituto per gli studi di politica internazionale il cui quartier generale è a Milano. Dalla lettura del voluminosotesto che, giunto alla tredicesima edizione, è ormai diventato un fondamentale appuntamento annuale per capire come siamo messi nel mondo, emerge un quadro desolante. Con probabilmente una sola consolazione: non siamo gli unici in sofferenza. In crisi – sappiamo – è l’intero sistema occidentale. Mal comune mezzo gaudio, insomma? Sì. Ma non solo. In comune vanno unite anche le forze. Perché, forse, in fondo al tunnel che stiamo tutti attraversando si intravede una luce. Ma la si potrà raggiungere a condizione che il difficile percorso lo si compia insieme: consapevoli che, nell’era della globalizzazione, i tradizionali confini si sono allargati e vaporizzati. I singoli paesi – europei e non solo – non possono più ragionare e pianificare le proprie strategie con un’ottica miopemente nazionale. E questo, per la verità, è una cosa che i governi italiani hanno quasi sempre avuto ben chiaro. Per usare un’altra frase presa dal rapporto: «anche nell’ultimo anno l’Italia ha cercato rifugio nella consueta pluralità di ancoraggi esterni». Da qui, probabilmente, il titolo del rapporto di quest’anno che dopo le pesanti critiche lascia alla fine un barlume di speranza: Le sfide della politica estera italiana: tra declino e rilancio. Già, ma come rilanciarsi? Lo abbiamo chiesto a Ettore Greco direttore della IAI. Assieme al collega Alessandro Colombo dell’ISPI è il curatore della ricerca che in queste settimane stanno illustrando in giro per l’Italia: dopo la presentazione al Senato a Roma, ce ne sarà una a Milano e poi a Torino.
Gli ancoraggi esterni ai quali l’Italia deve fare riferimento per non affondare, ruotano ancora una volta attorno ai tre perni tradizionali: Unione Europea, Alleanza Atlantica e Stati Uniti. Ma reggono ancora?
«Sì. Ma a differenza di un tempo, anche questi perni stanno attraversando una profonda crisi di efficienza e identità. Rendendo così ogni possibile ancoraggio fragile o quantomeno problematico. Per quanto riguarda l’atlantismo, si registra una travagliata ricerca da parte della Nato di una nuova propria missione. Alla fine si dovrà arrivare a una ridefinizione tra gli alleati, cioè in pratica tra americani ed europei, su quali debbano essere i compiti dell’Alleanza. Sarà il prossimo vertice di Chicago a tentare di affrontare la questione. Ma è indubbio che l’intera rete che finora ha retto l’Occidente che conosciamo stia attraversando una fase a dir poco magmatica. La vicenda dell’impegno in Afghanistan lascia capire quali siano le difficoltà a proseguire la partecipazione europea alla missione così come la vorrebbero gli americani. Del resto con gli stessi Stati Uniti che stanno lasciando questi “teatri” non è davvero chiaro quale potrà essere il ruolo della Nato. Insomma: il vincolo transatlantico si sta sicuramente allentando».
È in crisi anche il ruolo e il rapporto europeo?
«In crisi profonda. Sia perché c’è la generale crisi economica per la quale l’Europa fatica a trovare la ricetta giusta sia perché, come per la Nato, si avverte la necessità di una trasformazione dell’Unione Europea. In parte questa sta già avvenendo, ma soltanto sul piano del coordinamento delle politiche economiche e soprattutto fiscali. Mentre, invece, servirebbe un vero salto di qualità verso una unione politica. Quindi, anche a livello europeo, ci troviamo in una sorta di limbo con grandi incognite sul futuro di questo secondo ancoraggio”. Ma ci sono anche altri ancoraggi in discussione. Da quello del sistema delle Nazioni Unite a quello di Bretton Woods che, dall’ormai lontano 1944, regola le relazioni finanziarie e commerciali dei principali paesi industrializzati del mondo. Si tratta di capire come cedere potere ai nuovi paesi emergenti, dando vita a una nuova global governance efficace. In crisi, in definitiva, è tutto il multilateralismo su cui finora ci siamo retti. Perciò al multilateralismo dedichiamo tutta una lunga parte iniziale del rapporto».
Parlare di Europa, di questi tempi, significa parlare di leadership franco-tedesca, che piaccia o no. In particolare le politiche fiscali sono – o vorrebbero essere – dettate dalla Cancelliera Angela Merkel e dal suo progetto di fiscal compact, il trattato sulle stabilità economica e monetaria firmato agli inizi di marzo. L’Italia come reagisce?
«Si avverte un cambio di passo. Lo abbiamo registrato anche nel nostro rapporto, che pure prende in considerazione gli avvenimenti dell’anno scorso. Con il governo Monti c’è un orientamento diverso. Quello precedente, di Silvio Berlusconi, ha reagito tentando – sì – di opporsi alla leadership Parigi-Berlino. Ma non ha accompagnato il tentativo con un’efficiente azione diplomatica cercando di inserirsi nel binomio franco-tedesco dominante oppure tentando di stringere rapporti con altri paesi, come era stato fatto in passato. Ecco perché, nel nostro rapporto, siamo particolarmente critici nei confronti della diplomazia europea di Roma, che è stata a dir poco molto disattenta: non ha fatto un’efficace politica di alleanze, quella che in gergo si chiama la coalition building. Noi siamo convinti che il rapporto franco-tedesco continuerà sullo stesso binario, anche se all’Eliseo ci dovesse essere un cambio di persone e di partiti. O quando ciò avverrà in Germania. Ma la nostra critica all’Italia muove dal ricordo di errori passati, quando avremmo dovuto contrastare alcuni errori fatti dai franco-tedeschi e non lo abbiamo fatto. Per esempio, quando nel 2003 Parigi e Berlino imposero l’allentamento delle politiche di Maastricht anche con l’assenso italiano. E fu un errore. Anche nel 2011 i “due” hanno fatto delle cose sbagliate che hanno indebolito il contesto multilaterale e comunitario. Ma l’asse resta e resterà. E noi dobbiamo cercare di inserirci. Il governo Monti è andato subito in questa direzione. Appena insediato, il nuovo Presidente del Consiglio ha partecipato, sotto le telecamere di mezzo mondo, a incontri trilaterali Francia-Germania- Italia che non avvenivano più da tempo. Ma, non illudiamoci: ci troviamo sempre in una posizione di debolezza strutturale».
Insomma in questo “nuovo mondo”, l’Italia….
«Sta perdendo posizioni nelle gerarchie internazionali. Cerca di reagire con una ricerca spasmodica di riconoscimento: sia attraverso la partecipazione alle missioni come quella in Afghanistan sia attraverso l’ottenimento di cariche di primo piano negli organismi internazionali come è successo con la nomina di Mario Draghi al vertice della BCE, la Banca centrale europea. E pure attraverso la ricerca di approvazione da parte dei maggiori partner europei o transatlantici. Ma quello che veramente conta al momento, per l’Italia, è che la crisi del multilateralismo indebolisce proprio quella che, finora, era stata la soluzione più fortunata alle tradizionali debolezze della sua politica estera: gli ancoraggi esterni, appunto».
Questo, però, vale un po’ per tutti gli altri paesi occidentali.
«Certamente. Ma a rendere particolarmente debole la situazione italiana è anche il suo assetto politico e istituzionale che fa acqua da tutte le parti. Come si è visto anche nell’ultima crisi di governo. Ecco perché è necessario, ripeto, tentare di inserirsi nel dialogo franco-tedesco. L’Italia, per quanto riguarda per esempio le politiche fiscali, sembra in maggiore sintonia con la Francia sia quella attuale di Sarkozy sia l’eventuale prossima del socialista Hollande: sì al fiscal compact, ma accompagnandolo con politiche tese allo sviluppo e che diano un po’ più di respiro. Siamo invece, secondo noi, più in linea con la Germania sulla possibilità di fare progressi lungo la strada dell’unione politica. E lo si è visto nelle dichiarazioni di questi ultimi tempi della Merkel L’obiettivo è una ulteriore cessione di potere nei confronti di Bruxelles, con la nomina per esempio di un vero ministro europeo dell’Economia che porti a una governance economica comune».
Unione anche militare? Nascerà mai un esercito comune europeo?
«Per questo occorrerebbe fare, intanto, una cosa che non si sta facendo: applicare gli accordi del Trattato di Lisbona che prevedono una serie di meccanismi come la cooperazione strutturata permanente. Questa è una strada ancora da percorrere, progressiva. Prima, probabilmente, ci sarebbe da ridefinire il ruolo della Commissione: alcuni vorrebbero che diventasse un vero governo comunitario, unificando – per dirne una – il ruolo del Presidente del Consiglio europeo con quello del Presidente della Commissione. Cosa che tra l’altro non è esclusa dagli accordi vigenti e potrebbe quindi essere teoricamente fatta senza ricorrere a referendum o a altre iniziative legislative».
Il governo italiano attuale sarebbe favorevole?
«Mario Monti è favorevolissimo ad andare nella direzione di un rafforzamento delle capacità decisionali dell’Unione. Per capirci: è sempre stato contrario alla teoria della unanimità dei vari membri comunitari in politica estera. Ma, prima di tutto, c’è da risolvere la questione del fiscal compact che il socialista Hollande, se andrà a guidare il governo transalpino, vorrà sicuramente rinegoziare. E non sarà cosa facile. Penso che per l’Italia sarà più facile dialogare su questo punto, soprattutto sulla questione della cessione di sovranità, con la Germania perché in Francia l’argomento registra una maggiore chiusura. Ma il governo Monti sembra intenzionato anche ad aprire canali di dialogo con altre potenze europee. Come la Gran Bretagna, con cui una sintonia si può trovare nella necessità di completare il mercato unico, argomento che Monti ha affrontato proprio nei giorni scorsi. Ottenendo l’assenso di Londra il cui governo attuale è liberista e quindi in linea con Monti. Al momento, però, ancora non si è riusciti ad avviare un dialogo in tal senso».
L’Italia, comunque, rimane una “sorvegliata speciale”…
«Bè, all’ultima riunione del Fondo monetario internazionale, il vice ministro italiano dell’economia, Vittorio Grilli, ha dichiarato che “ora è un po’ meno sorvegliata speciale”. Personalmente ritengo che sia un’affermazione prematura. Diciamo che, con Monti, c’è stata un’apertura di credito ed è cresciuta la fiducia dei partner nella possibilità che l’Italia ce la faccia a riprendersi. Però continuiamo a essere osservati con attenzione. Si sa che siamo un anello debole della catena. Per via, per esempio, del macigno del nostro indebitamento pubblico che fa sì che, ogni volta che c’è uno scossone anche originante non al nostro interno questo grava sull’Italia in misura maggiore, perché abbiamo un volume di debito da rifinanziare superiore a tutti gli altri. E poi va detto che non riusciamo ad avviare un serio percorso di crescita.
E poi c’è il terzo ancoraggio italiano che scricchiola, quello con gli Stati Uniti. Al di là delle difficoltà internazionali e interne di Washington, in qualche misura simili a quelle degli altri paesi occidentali, qualcosa sembra essere cambiato anche nel dialogo diretto tra i due Paesi.
«L’epoca del rapporto stretto tra Bush e Berlusconi non c’è più. Con Obama le cose sono cambiate. La Casa Bianca vuole, giustamente, avere rapporti privilegiati con paesi che contano in Europa e a Washington è stata percepita la debolezza italiana e il nostro diminuito ruolo all’interno dell’Unione. Ma, detto questo, continua il riconoscimento americano per i nostri impegni internazionali. In Afghanistan, innanzitutto. E poi in Libano, dove l’Italia è nuovamente a capo della missione. E alla fine, anche se con un certo ritardo, ci è stato dato il riconoscimento anche nell’evolversi della situazione in Libia. Ciò rientra nella strategia americana del leading from behind, del controllo da dietro le quinte: Roma ha comunque avuto un ruolo nella vicenda libica e ciò è stato apprezzato. Il successo della visita di Mario Monti a Washington non è certamente casuale. L’apertura di credito da parte di un giornale come il Wall Street Journal rientra in questo giudizio, anche se poi il quotidiano ha fatto qualche passo indietro quando ha visto le difficoltà del nuovo governo italiano a far passare alcune riforme del mercato del lavoro. Insomma: apertura di credito sì, ma condizionata. Per riconquistare reputazione dobbiamo continuare a “fare i compiti a casa”. Monti è apprezzato, ma Washington non si illude: sa che l’Italia resta fragile. Ci sono però delle sfere di interesse comune su cui bisognerà puntare. Innanzitutto: il rapporto con l’Europa. È vero che gli USA ora guardano di più all’Asia, ma le relazioni con l’Europa restano importanti. E poi c’è il Mediterraneo, dove l’Italia è strategicamente posizionata».
Ma nel Mediterraneo l’Italia si sa davvero muovere? Nella vicenda libica, nonostante gli storici anche se sofferti rapporti tra Roma e Tripoli, i primi ad intervenire e a prendersi dei meriti sono stati francesi e inglesi. E sulla “primavera araba” abbiamo tentennato.
«Abbiamo avuto dei ritardi, è vero. Ma anche gli altri paesi non hanno reagito tempestivamente. Altri paesi, sì, ci hanno preceduto. Ma ora stiamo recuperando e ci stiamo inserendo nei processi avviati da altri. Per questo riteniamo che, dal punto di vista degli Stati Uniti, il ruolo dell’Italia in Nord Africa e in Medio Oriente non possa essere trascurato. Ma ripeto, è tutta l’Europa che ha capito in ritardo. La politica europea è debole: l’Unione per il Mediterraneo, lanciata da Sarkozy, non è mai decollata, soprattutto per ragioni che hanno a che vedere con il conflitto israelo-palestinese. Per rilanciare una qualche forma di cooperazione regionale nell’area, l’Italia potrebbe e dovrebbe avere qualcosa da dire».