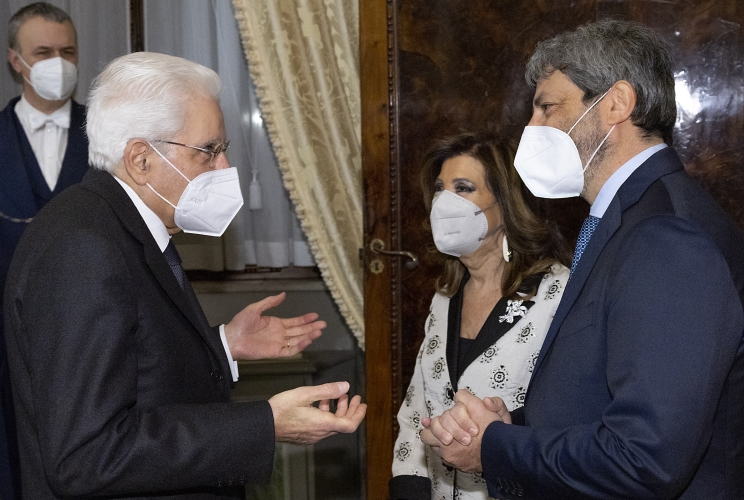La rielezione di Sergio Mattarella ripropone il paradosso che accompagna le esperienze di valore. Sono rinnovabili in condizioni diverse e con altri protagonisti? Si può immaginare che possano essere superate, e dar corpo a nuove prospettive? Dobbiamo rinunciare a farlo, per timore dei cambiamenti, del non visto, del non sicuro?
L’esito delle elezioni presidenziali 2022, accolto da uno scrosciante applauso per grazia ricevuta, offre già risposta, pesantemente negativa. Pare una conquista perché poteva andare male; e sotto altra luce, riaccende le speranze che languivano, fa guardare al futuro con più fiducia. La rielezione di Mattarella è riconoscimento alto del valore della persona e del lavoro svolto. La soluzione adottata però è rassicurante (nell’immediato) e deludente (per il futuro). Forse il sistema non era maturo per altre scelte, per osare, e allora, rispetto al pericolo, meglio accontentarsi. Aver evitato il baratro è già tanto in questo frangente.
I commenti di questi giorni racchiudono esattamente la contraddizione insita in questa scelta, ed oscillano tra la valorizzazione degli elementi positivi (che non mancano) e le critiche anche accese. Lo sguardo però non può fare a meno di volgersi in tutte le direzioni. Sarebbe illusorio chiudere gli occhi sulle crepe del sistema. Non si devono trascurare le positività, ma i problemi sollevati sono di grandezza allarmante, perché l’inadeguatezza della classe politica è evidente.
Si possono fare mille distinguo, compilare pagelle e magari qualcuno può spuntare anche la sufficienza, ma l’immagine complessiva è quella. Il Financial Times ha riassunto: «Una classe politica egoista evita il disastro all’ultimo minuto». Difficile stavolta dargli torto. I rischi connessi ad una fase delicatissima della vita pubblica hanno pesato più di qualsiasi altra motivazione, penalizzando ogni passo nuovo se non audace. È mancato il coraggio di cercare strade inesplorate, di sperimentare altro.
Il paese ha vinto, la politica ha perso; si dice a tempesta esaurita, per chiudere la riflessione. Questo il risultato, espresso in termini brutali ma non troppo distanti dalla realtà. La vittoria del Paese, passata come affermazione del parlamento (dunque invocazione dal basso) rispetto alle incertezze della politica “alta”, in primo luogo è frutto dell’ampio consenso di cui ha goduto la figura di Mattarella, amato ed apprezzato da tutti, poi sollecitato a gran voce a rimanere al suo posto, nonostante l’orientamento personale.
Però oltre l’affetto, l’esigenza di non cambiare l’inquilino del Colle ha la sua radice più profonda nella percezione, che ha fatto breccia nel palazzo recalcitrante, della necessità di garantire la stabilità all’azione governativa per non disperderne i risultati positivi. Per una volta intesa in senso ampio, come iniziativa non solo di questo particolare governo, in genere dell’azione pubblica. Altrimenti, con la crisi politica inevitabile, sarebbe stato deleterio incrementare la sfiducia collettiva ora che siamo al dunque nella lotta alla pandemia e nella realizzazione delle misure del Pnrr.
Ma non può sfuggire che la mossa è stata anche conseguenza della disperazione e dell’inettitudine a confezionare soluzioni differenti. Anche solo immaginarle. Come era doveroso. Allora Mattarella, nella vacuità delle giornate di voto, non è proprio una seconda scelta. Non c’erano competitori reali, né è stata cercata una strada per costruire proposte che fossero una prosecuzione del lavoro svolto. Piuttosto la conferma di Mattarella è stata una soluzione di alto significato simbolico, con implicazioni umane, non solo politiche: ciambella di salvataggio per le sorti personali di tanti, àncora di salvezza per le istituzioni.
L’appello dei naufraghi, a piedi in mesta processione verso il Colle per implorare che accettasse, è sembrato invocazione disperata, richiesta di soccorso nella nube tossica del viaggio. Chi si interrogava sulle decisioni del Presidente, dopo che in tutte le lingue aveva espresso il pensiero contrario (non per stanchezza personale, per consapevolezza del valore dei limiti propri dell’impegno pubblico), non è rimasto sorpreso dalla risposta. Perché formulata in termini di etica pubblica: «si accolgono i doveri ai quali si è chiamati».
Superato il pericolo della paralisi, dello stravolgimento delle regole, dell’incertezza sul destino del governo e della legislatura, il rischio che già si intravede è ora la banalizzazione dell’insuccesso della politica nonostante tanti propositi bellicosi. C’è alta tensione nei partiti (quasi tutti) dopo il voto, si scatena il tiro al bersaglio contro i perdenti. Molte le accuse: qualcuno (Salvini) ha osato di più senza esserne capace, qualcun altro (Conte) non ha saputo muoversi con decisione e soprattutto coerenza nel campo progressista in preda a nostalgie populiste, altri ancora (il centrodestra) ha preso batoste o (Casellati) si è autobastonato da solo.
Difficile non vedere macerie ovunque. All’apparenza è il momento della resa dei conti, del regolamento di questioni personali sulla gestione del potere, sul controllo delle forze politiche: aspetti però surreali rispetto allo scollamento prodottosi tra i partiti (per lo più) ridotti a comitati elettorali a conduzione personale e l’opinione pubblica, disaffezionata, delusa, critica. È il risultato dello sradicamento delle organizzazioni politiche dal tessuto sociale, della crisi di identità, della perdita dell’orizzonte di senso morale.
Il pericolo è che ci sia tanto rumore per nulla, che tutto il tramestio serva solo a cambiare qualche casella lasciando le cose come prima. Sarebbe fuorviante ridurre il tema della rifondazione dei partiti agli obiettivi di vendetta personale contro chi non si è mostrato all’altezza o ha commesso errori (nella Lega o nel movimento 5 Stelle) e troppo assolutorio lasciarsi stordire dalla facile euforia (nel Pd o in Fratelli d’Italia) per qualche performance (ciascuno dal suo punto di vista, è chiaro).
Servirebbe chiarire seriamente i motivi della crisi della classe politica, il difetto di qualità e di consapevolezza, prima che arrivi il momento delle nuove prove, come le elezioni politiche del 2023. Non sarà facile, ma è indispensabile discuterne e la prima mossa è rinunciare a farlo nelle segrete stanze o nei cerchi magici autoreferenziali. La conclusione raggiunta è riconducibile ad un principio che offre sicurezza ma è privo di prospettive: meglio stare fermi che muoversi, quando la paura è tanta e non si sa come gestirla, soprattutto se non si hanno idee né coraggio sufficiente.
È questo “blocco” mentale e politico che ha distorto il corso degli eventi, autorizzando manovre spericolate per intestarsi la nomina del nuovo presidente a costo di bruciare alleanze, nomi, prospettive, per vantare effimeri successi su avversari esterni e interni. Il resto è venuto di conseguenza: il “tritacarne” dei nomi (da Pera a Moratti a tanti altri) gettati in campo e subito ritratti, quella sensazione sgradevole – a proposito delle tante auspicate scelte al femminile – di assistere al lancio sprezzante di bambole rotte, infine la strumentalizzazione di proposte (Belloni) in sé ragguardevoli.
Accontentarsi dell’accaduto in nome dello scampato pericolo è comprensibile e può anche bastare al momento. Rimane però il compito di decifrare la trama di tanti avvenimenti confusi e incomprensibili, recuperare il coraggio e la progettualità. La chiave del fallimento della politica nell’occasione non è troppo lontana da questa constatazione: l’elezione del Presidente ha estremizzato e portato alla luce il limite di una politica che non sa pensare e agire oltre il tornaconto particolare, facendosi invece carico dell’obiettivo di valore che soltanto la legittima: il bene comune.