Dal 1992 ad oggi i quattro maggiori paesi europei oltre l’Italia sono sempre stati governati dai rispettivi partiti “storici”: i Tory (John Major, James Cameron, Theresa May e Boris Johnson) e il Labour Party (Tony Blair e Gordon Brown) nel Regno Unito, la CDU (Angela Merkel) e SPD (Gerard Schröder) in Germania, il PP (José María Aznar e Mariano Rajoy) e PSOE (José Luis Zapatero e Pedro Sánchez) in Spagna, e Repubblicani (Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy) e PS (François Mitterrand e François Hollande) – con l’ultima eccezione di En Marche! di Emmanuel Macron – in Francia.
L’Italia, invece, nel frattempo, dal 1992 ad oggi, ha cambiato 18 governi e 11 premier: ha preso leader, li ha portati alle stelle e poi li ha gettati alle stalle nel giro di poco tempo, come in una giostra impazzita. Non esiste più un solo partito che partecipò alle elezioni del 1992 (se si eccettua la Lega, che allora era Lega Nord). Ad ogni elezione cambia la metà delle sigle.
Perché questa schizofrenia? Questo “frullatore”? Oltre all’instabilità del sistema Italia, all’incapacità di autoriformarsi e anche all’etica politica, qui entra in scena una variabile tutta italiana: la ricerca del “Salvatore della Patria”. È come se l’italiano in cuor suo sapesse che l’Italia è un paese difficilmente riformabile e si affida, ogni volta dal 1994 in avanti a chi gli promette o chi pensa possa risolvere la situazione: Silvio Berlusconi nel 1994, 1998 e 2008, Romano Prodi nel 1996 e 2006, Matteo Renzi nel 2013 (ed exploit alle europee 2015), Beppe Grillo ed il Movimento 5 Stelle nel 2018. In tutti i casi un boom di consensi, forse perché come diceva Ennio Flaiano “gli italiani corrono sempre in aiuto del vincitore”.
Una personalizzazione sconosciuta in Italia fino ai primi anni Novanta dove era la “partitocrazia” che comandava. Una personalizzazione che ha una doppia matrice: da una parte la fine delle ideologie con il crollo del comunismo e, di conseguenza, dell’anticomunismo e dall’altra il potere sempre più straripante della TV, della spettacolarizzazione. Basti pensare che fino almeno all’elezione di Bill Clinton negli Stati Uniti nel 1992 le convention dei democratici e dei repubblicani, con le bandierine ed i cartelli con i nomi dei politici, erano visti dagli italiani come un “varietà” eccentrico.
Mi viene in mente il botta e risposta tra Doc e Marty nel famoso film “Ritorno al futuro”:
“Dimmi, ragazzo del futuro, chi sarà il Presidente degli Stati Uniti nel 1985?”
“Ronald Reagan”
“Ronald Reagan? L’ attore? E il vicepresidente chi è, Jerry Lewis? Suppongo che Marilyn Monroe sia la First Lady e John Wayne il Ministro della Guerra!”
Questo era più o meno quello che pensava degli Stati Uniti ogni italiano fino ai primi anni Novanta: un presidente ex attore? Solo gli “americani” (inteso come statunitense) possono fare una cosa, perché da noi “la politica è una cosa seria”.
La TV: lungi da me il fare una polemica sulle televisioni di Silvio Berlusconi e sul presunto imbarbarimento della cultura italiana rispetto ad una supposta aurea aetas anteriore, è abbastanza evidente come chi sappia interpretare la comunicazione, “bucare il video”, essere diretto e conciso ha una carta potentissima in mano.
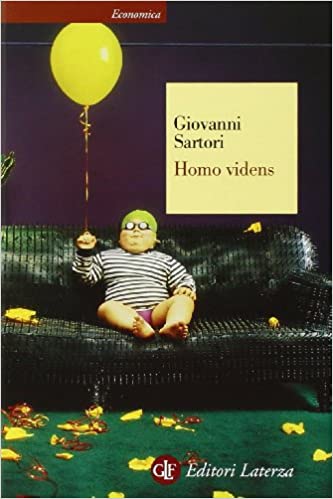
Ebbene, dal 1994 in poi, i leader politici che hanno governato si sono imposti prima in televisione e poi sono scesi nell’arena politica: Silvio Berlusconi “Sua Emittenza” come era chiamato divenne popolare per le tv private e per le vittorie del Milan, anche se le sua apparizioni tv erano abbastanza limitate; Matteo Renzi da Sindaco di Firenze iniziò a fare la spola fissa tra Firenze e Roma ospite di un’infinità di trasmissioni tv; infine Beppe Grillo in tv fin dai primi anni ’80, comico popolarissimo ha sfruttato la sua immagine per lanciare il Movimento 5Stelle; certamente il suo blog ha influito nella creazione di consenso, ma i leader del M5S – Luigi Di Maio in primis – hanno iniziato a vincere quando hanno iniziato ad andare – dopo che Beppe Grillo tolse il veto – costantemente in tv. Solo Romano Prodi, esponente di quella cultura “democratico-social-cattolica” della Prima Repubblica, si beneficiò della forza di quel che restava dei partiti storici che non avevano ancora metabolizzato la “politica show”.
Il politologo Giovanni Sartori coniò il concetto di “homo videns”: causa della televisione per la prima volta nella storia l’immagine predomina e prevale sulla parola. Da una quindicina d’anni è un pullulare di talk show politici o presunti tali: prima furono “Porta a Porta” fino ad oggi che ne contano almeno una ventina ad ogni ora, un circo tra politici, giornalisti “ospiti di professione”, opinionisti e chi più ne ha più ne metta. Nella creazione del consenso niente è più forte della televisione, ancora oggi nel 2021. Puoi essere forte sui social, ma l’immagine – vera o presunta – si costruisce in tv, con l’immagine (e quanto più presente, meglio..).

Ogni tot di anni, però, arriva qualcosa di diverso, da fuori, ad interrompere questa kermesse: nel 1992 la crisi valutaria che portò l’Italia – c’era ancora la lira – fuori dall’allora Sistema Monetario Europeo (SME), nel biennio 2010-11 la crisi dei debiti sovrani nell’area euro e nel 2020 la tremenda crisi economica – ancora in corso – provocata dalla pandemia da Covid19. Un cortocircuito. I partiti e i loro leader, allora, attoniti come pugili al bordo del KO si guardano attorno come a dire: “che è successo?”. Impauriti fanno un passo indietro, capiscono il momento, ed invocano all’unisono “quello serio”, quello che viene a rimettere le cose a posto. E così nel 1993 dopo l’ex Governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi e nel 2011 l’ex Presidente della Bocconi e Commissario europeo Mario Monti tocca adesso – a meno di sorprese clamorose dell’ultima ora – a Mario Draghi, ex Presidente della BCE, tentare di salvare l’Italia.
È come se per i partiti ci fosse la necessità di uno stacco, di un’interruzione, e allora all’unisono o quasi la scelta cade su un economista di prestigio che rimetta le cose in ordine, in modo da prendere tempo, fermarsi e riprendere fiato. Per almeno un anno, in modo da riorganizzarsi….per poi tornare in gioco, magari con altra alleanza o un’altra sigla. “Se le cose vanno bene è anche merito mio, se vanno male è colpa sua” è il leitmotiv del non detto. Scusateci dell’interruzione, le trasmissioni riprenderanno il prima possibile.











