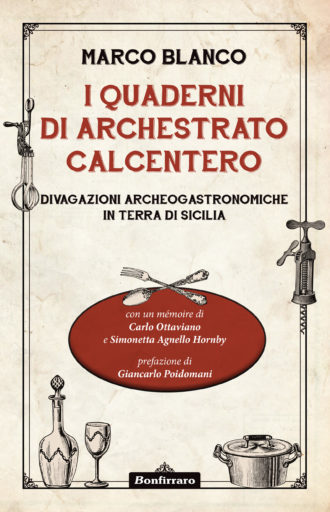
Ricettari antichi, archivi di stato e privati, libri di spese, appunti, note, repertori specialistici sfogliati con cura e pazienza. E poi la passione per il cibo, quello siciliano, e l’archeologia. Tutto questo e di certo molto altro, ha portato alla pubblicazione de I Quaderni di Archestrato Calcentero (Bonfirraro 2016), il saggio scritto dal siciliano Marco Blanco che unisce il rigore scientifico del metodo della ricerca con il racconto accattivante fatto di aneddoti e note che intrattengono il lettore.
L’autore, libraio per professione e ricercatore per vocazione, le chiama “divagazioni archeogastronomiche in terra di Sicilia” e ci consegnano un pezzo di storia della cucina siciliana, quella aristocratica e conventuale, ormai entrata negli annali storico-culinari. Marco Blanco, è nato a Modica, in provincia di Ragusa, in quella che è stata ribattezzata la “food valley” siciliana.
Una laurea in lettere classiche all’Università di Catania e una grande passione per l’archeologia. Libraio di professione e ricercatore per vocazione, Marco nutre un profondo amore per i libri e per l’arte di raccontare. A noi de La Voce di New York ci parla del suo saggio che contiene anche un mèmoire di Carlo Ottaviano e di Simonetta Agnello Hornby.
“Quaderni” perché volevo ricordare i quaderni dove cuochi e monsù del passato scrivevano le loro ricette; Archestrato perché citare uno dei padri della letteratura gastronomica siciliana mi è sembrato più che doveroso; Calcentero perché “Χαλκέντερος” in greco antico vuol dire “stomaco di bronzo”, aggettivo che rispecchia pienamente la mia passione per la gastronomia!”
Come è nata l’idea di un saggio sulle ricette aristocratiche e conventuali?
“L’idea di questo saggio è nata quasi per scherzo. Quasi dieci anni fa lavoravo alla ricostruzione di alcuni alberi genealogici e per questo motivo avevo cominciato a frequentare attivamente il mondo degli archivi. Poiché a volte negli archivi possono trascorrere anche parecchi giorni prima che il documento cercato sia effettivamente rinvenuto tra le centinaia di volumi a disposizione cominciai a curiosare anche tra i libri di spese dei conventi e dei monasteri scoprendo un mondo del quale ignoravo l’esistenza. Cominciai così a condividere le informazioni trovate con alcuni cari amici, tra cui Franco e Pierpaolo Ruta dell’Antica Dolceria Bonajuto, una delle dolcerie più antiche d’Italia ancora in attività. Dalle semplici curiosità che andavo mano a mano raccogliendo nacque così l’intuizione: cosa conosciamo delle abitudini alimentari del passato in Sicilia? Quanto c’è di vero nelle storie che si raccontano e quanto invece solo folclore? Perché allora, partendo dai dati che stavo raccogliendo, non scrivere un saggio che però non fosse rivolto soltanto al mondo della ricerca ma a tutti gli appassionati di storia della cucina? Ecco come è nato “I quaderni di Archestrato Calcentero”. “Quaderni” perché volevo ricordare i quaderni dove cuochi e monsù del passato scrivevano le loro ricette; Archestrato perché citare uno dei padri della letteratura gastronomica siciliana mi è sembrato più che doveroso; Calcentero perché “Χαλκέντερος” in greco antico vuol dire “stomaco di bronzo”, aggettivo che rispecchia pienamente la mia passione per la gastronomia!”.
Tra il racconto, il saggio e la ricerca scientifica. Che approccio di ricerca e narrativo hai utilizzato per la stesura del libro?
“Il mio è stato un approccio ambivalente. Da una parte ho usato un criterio scientifico, metodico e rigoroso attenendomi ai documenti e alle fonti, limitando al minimo le congetture personali e separando sempre le opinioni dai fatti storici. Dall’altro, temendo che un linguaggio eccessivamente tecnico potesse rendere il testo arido e di poco appeal per i non “addetti ai lavori” ho deciso di usare un linguaggio più accattivante, vicino più al racconto che alla lezione accademica. E a me raccontare piace parecchio”.
Quali sono state le fonti?
“Le fonti sono state molteplici e abbracciano circa quattrocento anni, dal XV secolo ai primi del Novecento. In primo ho usato documenti d’archivio: archivi di conventi e monasteri e nello specifico libri di conti, di spese, ricevute di pagamento e libri di vivande (libri su cui si annotavano i “menù del giorno” dei monasteri n.d.a.); libri di conti e di spese di famiglie aristocratiche e borghesi; ricettari d’epoca, stranieri, italiani e siciliani; saggi storici e studi specializzati”.

Quale scoperta, ricetta, aneddoto divertente, fra i tanti?
“Dal punto di vista della ricerca credo che una delle scoperte più interessanti sia stata in un libro di conti del Monastero dei Benedettini di Catania nel quale si citava chiaramente l’uso del pomodoro già nella prima metà del Settecento, quando “communis opinio” voleva il pomodoro sconosciuto alla cucina siciliana fino alla metà dell’Ottocento. Interessanti anche alcuni episodi della “piccola” storia, la storia di donne e uomini comuni che si intreccia con la “grande” storia, quella degli eventi epocali in grado di cambiare la vita a milioni di persone. Personalmente mi ha divertito conoscere la qualità, la varietà e soprattutto la quantità impressionante di cibo che era consumata nei conventi e nei monasteri del passato dove i periodi di digiuno e penitenza si alternavano a pranzi e cene ricchissime e sontuose”.
Se volessimo spiegare l’origine della cucina siciliana agli americani, cosa potremmo dire?
“Di solito mi piace descrivere la cucina siciliana paragonandola alla caponata ma poiché non sono certo che questo piatto sia noto anche al di fuori dell’Italia ripiegherò su una ricetta più nota anche all’estero… Ecco, immaginate la cucina siciliana come se fosse una lasagna: se mangiati da soli i singoli ingredienti hanno un gusto proprio e una propria personalità. La consistenza degli strati, la carnosità della pasta, il gusto deciso del ragù, la sapidità del formaggio, i colori accesi, il profumo denso e inebriante dell’insieme e quella tentazione subito repressa di svuotare avidamente il piatto…
La cucina siciliana è questo: singoli elementi provenienti da tutte le culture che hanno lasciato una traccia sulla nostra isola la quale, stratificandosi con gli elementi già presenti hanno dato vita ad un fenomeno complesso e unico nel suo genere. Forse l’esempio più immediato di come la mescolanza, lo scambio e il melting pot creano vitalità, rigenerano la vita”.
Quale la ricetta più simbolica che rappresenta la cucina siciliana all’estero?
“In tutta onestà non sono certo di riuscire a dare una opinione meditata perché in viaggio mi immergo così tanto nella cucina del luogo che di solito non parlo della cucina siciliana ma chiedo informazioni sulla cucina locale! Penso comunque che un piatto dello street food come l’arancino o dolci come la cassata e il cannolo siano ormai un simbolo internazionale della cucina siciliana”.
Come vedi la cucina siciliana di oggi rispetto a quella passata? Si parla sempre di tradizione e innovazione…
“Personalmente penso che la tradizione in cucina sia soltanto un piatto riuscito bene! Ovviamente è una provocazione, perché io per primo sono piuttosto restio ad esperimenti gastronomici troppo “estremi” ma è pur vero che nessuna ricetta di successo, e questo vale per la cucina in generale, è rimasta inalterata nei secoli. Perché il successo di un piatto dipende dal gusto del periodo storico che ci si trova a vivere e per questa ragione diventa una variabile soggetta cambiamenti anche drastici, pur conservando il nucleo iniziale da cui era partito. Da questo punto di vista trovo che tanti chef siciliani, giovani e meno giovani, e tanti operatori nel settore enogastronomico stiano lavorando bene svecchiando da certi preconcetti e facendo “dialogare” una cucina complessa e stratificata come la cucina siciliana con la realtà mediterranea e con altre realtà anche lontane nel tempo e nello spazio senza per questo perdere farle perdere il quid iniziale, la territorialità e la stagionalità degli ingredienti”.

Il tuo piatto siculo preferito?
“Forse facciamo prima ad elencare i piatti della tradizione culinaria siciliana che non mi piacciono! Scherzi a parte, non credo di preferire una sola ricetta ma una serie di piatti, soprattutto salati, che rientrano tra quelli particolarmente graditi. Forse l’unica cosa che li accomuna è che si tratta di piatti della festa, che ricordo sin da quando ero bambino e per questo evocano ricordi che vanno al di là, forse, dell’effettiva bontà. No, no, sono anche buoni! Mi piace sottolineare che essendo nato e vivendo nella parte meridionale della Sicilia, quella dei Monti Iblei, tendo a citare piatti della tradizione iblea tralasciandone altri, seppur più noti all’immaginario collettivo, ma legati all’area etnea o palermitana (pasta con le sarde, sarde a beccafico, falsomagro ecc.) Oltre a quello che può essere assimilato allo street food dove ovviamente arancini, pasticci di broccoli e topinambur, nonché “scacce” (focacce realizzate con sottile pasta arrotolata più volte su se stessa e farcita con vari ingredienti n.d.a.) la fanno da padrone, mi piacciono i ravioli di ricotta e maggiorana al sugo di maiale e i “lolli” con le fave (grossi maccheroni cotti in un purè di fave, olio e finocchietto selvatico n.d.a.), il baccalà fritto, che si ricollega casualmente ad un’altra cucina che io adoro come quella portoghese, la parmigiana di melanzane, la caponata, i cannoli di ricotta e piatti da osteria di un tempo quali il “bollito”, il pane fritto con le uova. E poi “appetizer” per accompagnare il vino come caciocavallo, olive, salsiccia secca, lupini salati… Devo continuare?”.
Cibo e scrittura: dalla ricerca ai food blogger passando per i giornalisti gastronomici. Pensi che oggi il modo in cui si parla e scrive di cibo sia spesso abusato e poco legittimato in alcuni casi, o non è così?
“Credo che mai come ora si parli tanto di cibo: dai blog alle testate specialistiche, dai contest ai reality televisivi, dall’informazione seria e documentata passando per le mode alimentari, il food porn dei social network fino alla disinformazione vera e propria. In un mondo iperconnesso come il nostro tutti parlano di tutto, tutti recensiscono ogni cosa senza talora avere le competenze giuste per farlo. Questo a mio parere, se da un lato questo chiacchiericcio continuo rischia di abbassare l’attenzione per la sostanza del discorso (un mio amico ama dire che ormai si va al ristorante non per rilassarsi ma per attaccare lo chef), dall’altro, parlare di cibo e di alimentazione nella maniera giusta genera un circolo virtuoso nei confronti di un fenomeno che non è più solo e mero nutrimento e sostentamento ma educazione alla qualità, estro e cultura. Che si parli di cibo allora, ma con cognizione di causa!”.

Tre libri sulla cucina siciliana da non perdere.
“Sia da libraio, sia da ricercatore, sia da lettore potrei consigliare decine di libri quindi citerò i primi tre che mi vengono in mente, senza alcun ordine o classifica, ovviamente. “La cucina del buon gusto” di Simonetta Agnello Hornby, un libro che è un inno al piacere della cucina e al “buon gusto” inteso nel senso più ampio del termine; “Siciliani a tavola – Itinerario gastronomico da Messina a Porto Empedocle” di Alberto Denti Di Pirajno, un un affascinante e divertito viaggio nella Sicilia dei sapori e dei suoi tic gastronomici, e infine “Per le scale di Sicilia” di Pino Cuttaia, un bel volume in cui lo chef di Licata racconta la cucina e si racconta ai suoi lettori”.
Lavori come libraio e ti occupi di ricerca. Cosa ti affascina di questa professione e del mondo dei libri?
“Io amo il mio lavoro. Non ci sono altre parole per definire quello che faccio. Un amore puro, totale e disinteressato, un senso di vertigine che ti assale quando ti rendi conto che da povero miserabile lettore e libraio quale sei, stai condividendo uno spazio fisico con l’assoluto, con quanto di più grande hanno prodotto l’intelligenza e il genio anche nei periodi più bui del genere umano. E pensi alla libreria come ad un tempio e ai libri come tante fiammelle nella notte dello spirito, e pensi al grandissimo privilegio che hai ricevuto, e alla profonda responsabilità nei confronti dei lettori che frequentano la libreria. Un libro ti può cambiare davvero la vita, e sapere di aver cambiato la vita di qualcuno con il proprio lavoro quotidiano, nell’umiltà socratica di chi, sapendo di non sapere, cerca la verità insieme al proprio interlocutore è una sensazione impagabile”.












