È ancora acceso, sui social network italiani, il dibattito sulla declinazione al femminile della professione del direttore d’orchestra, suscitata dall’apparizione all’ultima edizione del Festival di Sanremo di Beatrice Venezi, che ha tenuto a precisare di voler essere definita “direttore”.
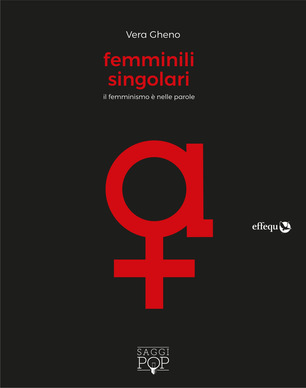
A gettare acqua sul fuoco delle polemiche è la nota sociolinguista Vera Gheno, autrice del volume Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole”, edito da Effequ, che sostiene, sulla sua pagina Facebook, di apprezzare la libertà di ognuna di definirsi come meglio crede, pur dissentendo dall’affermazione della Venezi che la professione del direttore d’orchestra abbia un nome preciso e, come tale, non declinabile per genere. Ciò equivarrebbe a negare l’esistenza stessa delle donne sul podio. La linguista ricorda infatti, citando la filosofa Claudia Bianchi in “Hate speech: il lato oscuro del linguaggio”, edito da Laterza, “che il linguaggio è un potente strumento di creazione e cambiamento di oggetti sociali, di costruzione, rinforzo o revoca di classificazioni e distinzioni”. Le parole hanno dunque lo straordinario potere di dare vita e legittimità a gruppi e categorie sociali che reclamino di essere rappresentati nella loro diversità.
Ciò che nominiamo riceve una patente di esistenza?
“Il linguaggio è lo strumento principale di mediazione fra le differenze. In una prospettiva intersezionale, che miri alla convivenza pacifica di diverse identità sociali, è necessario che il lessico si rinnovi per poter rappresentare tutti i tipi di diversità: etiche, religiose, di genere, di età, di orientamento sessuale, di disabilità o di neuroatipicità. È un momento in cui diverse società stanno compiendo la transizione da un modello normocentrico verso una prospettiva che vada persino oltre l’inclusività, prendendo atto del fatto che ogni individuo è unico, dotato di proprie specificità e diverso da ogni altro, e che bisogna imparare a convivere con ogni tipo di diversità. Ebbene, la categoria sociale la cui sottorappresentazione linguistica è più evidente è quella femminile, nonostante le donne rappresentino più della metà della popolazione”.

Il sottotitolo del suo libro è “Il femminismo è nelle parole”. Il linguaggio di genere è una questione di ideologia femminista?
“Ho scelto, insieme ai miei editori, un sottotitolo militante, affinché fosse chiara la collocazione del libro all’interno del dibattito sulla parità di genere. L’intento è quello di dimostrare che le parole che usiamo non sono indifferenti. E fra le cose che possono contribuire all’emersione della presenza femminile in ambito lavorativo c’è senza dubbio la questione dei nomina agentis al femminile. Tuttavia, una delle direttrici di lavoro che sto seguendo da un po’ di tempo a questa parte, è la de-ideologizzazione del linguaggio di genere. Il nostro sistema di concettualizzazione della realtà consiste nel dare dei nomi alle cose, quindi usando i femminili ‘ministra’ o ‘assessora’ si fa un’operazione storicamente e grammaticalmente corretta, visto che i femminili professionali sono sempre esistiti e semplicemente venivano usati, al di là di ogni ideologia, quando compariva una donna in una determinata carica. Chiediamoci perché Eleonora d’Arborea fosse appellata ‘giudicessa’ e non ‘giudice’ nel suo giudicato in Sardegna. E perché Plautilla Bricci era architettrice e non architettore, come si diceva all’epoca?”.
Perché tanta resistenza ai mutamenti linguistici?
“All’interno di una società di stampo ancora marcatamente patriarcale, non si è mai ritenuto necessario mettere in luce linguisticamente la presenza femminile. Questa impostazione sta cambiando all’unisono con i cambiamenti sociali, che vedono l’incremento dalla presenza femminile in contesti lavorativi e ruoli apicali nella sfera politica in cui in passato la donna non era rappresentata o compariva solo sporadicamente. In conseguenza di questi mutamenti sociali, la lingua italiana è sottoposta a un cambiamento piuttosto rapido, costringendoci a un continuo adattamento cognitivo”.
Perché molte persone si rifiutano di utilizzare i “femminili professionali”?
“Se da una parte l’evoluzione linguistica è una conseguenza naturale di un mutamento della realtà sociale, da molti è vissuta come una discontinuità rispetto allo status quo. E poiché la lingua è un atto fortemente identitario, in quanto ognuno di noi è le parole che usa, le persone eccessivamente abitudinarie e refrattarie al cambiamento tendono ad arroccarsi sulle proprie posizioni, rifiutandosi per esempio di usare termini fino a poco tempo fa inusitati come ‘assessora’ o ‘ministra’ perché questo rappresenta per loro un trauma allo stesso tempo linguistico e identitario”.

Eppure, l’uso dei “femminili singolari” è previsto dal dizionario…
“Esatto, basterebbe usarlo un po’ di più. Ogni sostantivo possiede un genere grammaticale, maschile o femminile, e rientra in una delle quattro categorie di sostantivi di genere fisso, promiscuo, comune e mobile. Conoscere la quadripartizione dei sostantivi aiuterebbe a rispondere a gran parte delle domande che normalmente vengono sollevate riguardo alla questione dei femminili professionali. È vero però che per motivi storici non è sempre esattamente prevedibile quale sia la forma femminile. In tal caso, basta armarsi di vocabolario. Ricordo che gli italiani conoscono circa un decimo del lessico della nostra lingua madre, più o meno 30mila parole, mentre l’italiano ne vanta oltre 300mila”.
Qual è il valore della lingua madre in un’epoca di globalizzazione linguistica?
“Sgomberiamo il campo da un equivoco. Nel nostro cervello possono convivere pacificamente diverse lingue. Una situazione di grande felicità esistenziale per un essere umano è quella di avere più lingue a disposizione per potersi esprimere, perché ogni lingua è portatrice di una visione diversa della realtà, e questo non può che arricchirci. Tuttavia, la lingua madre ha una valenza totalmente diversa da ogni altra lingua che venga appresa in seguito, in quanto lingua della socializzazione primaria, e spesso la lingua in cui si pensa, si sogna, si ama. Può esserci il caso in cui si cresce con due lingue madri in contemporanea, com’è accaduto a me, ma ciò non toglie che le lingue che si imparano prima del cosiddetto “periodo finestra”, precedente all’adolescenza, hanno sul nostro cervello un impatto più profondo rispetto a quelle imparate successivamente”.

Perché la lingua madre è un valore da preservare?
“Perché è un modo per conservare la relazione con le proprie radici. Avere delle radici salde significa aprirsi con più fiducia agli altri. Uno dei problemi di alcuni popoli che si mostrano intrinsecamente xenofobi sta proprio nella mancanza di radici. Quando ci si sente incerti rispetto alla propria provenienza e alla propria struttura identitaria, si ha paura di mescolarsi con gli altri, vedendo lo scambio non come un arricchimento culturale, ma come una forma di corruzione. Come ripeteva Tullio De Mauro, un italiano con un’esistenza felice è uno che conserva il dialetto, che richiama le sue radici, conosce bene l’italiano, che è la lingua dello studio e del lavoro, e parla almeno una lingua straniera, che gli offre una prospettiva internazionale”.
Esiste un rischio di estinzione della lingua madre?
“Una lingua muore solo quando si estinguono i parlanti. Nel corso del tempo abbiamo perso tante lingue, ma l’italiano al momento non corre questo rischio: è parlato da 60 milioni di persone in patria, da tutti i nostri connazionali all’estero e tenuto vivo dalle persone che lo studiano come seconda lingua. Per questo molti degli alti lai di chi si preoccupa che l’italiano stia svanendo, ritengo siano privi di fondamento”.
La pressione culturale dell’inglese, può mettere a rischio l’integrità della nostra lingua?
“Direi di no, anche perché la grande maggioranza degli influssi anglofoni si ferma al livello lessicale, e non va ad intaccare né le strutture sintattiche, né la morfologia dell’italiano”.
Qual è la specificità culturale veicolata dalla lingua italiana? Perché all’estero dovrebbero studiarla?
“Ogni lingua ha le sue specificità. Tuttavia, l’italiano ha dalla sua una tradizione letteraria imponente, ma ciò che la rende appetibile per chi la voglia studiare è che conoscendo l’italiano del presente è possibile leggere molte opere del passato. È una lingua che ha avuto la fortuna di rimanere uguale a se stessa fino agli anni ’60 del ‘900, per il fatto di non esser stata parlata fino ad allora in maniera generalizzata, riuscendo a preservarsi come una sorta di fossile per poi iniziare a cambiare molto rapidamente. Ma soprattutto l’italiano è una lingua carica di risonanze storiche. Ciò che affascina in particolare gli abitanti delle Terre Nuove, è che la nostra lingua dà accesso al nostro ricco patrimonio storico e artistico, e a una cultura che ha radici molto profonde, che noi italiani ci portiamo addosso con una certa casualness”.












