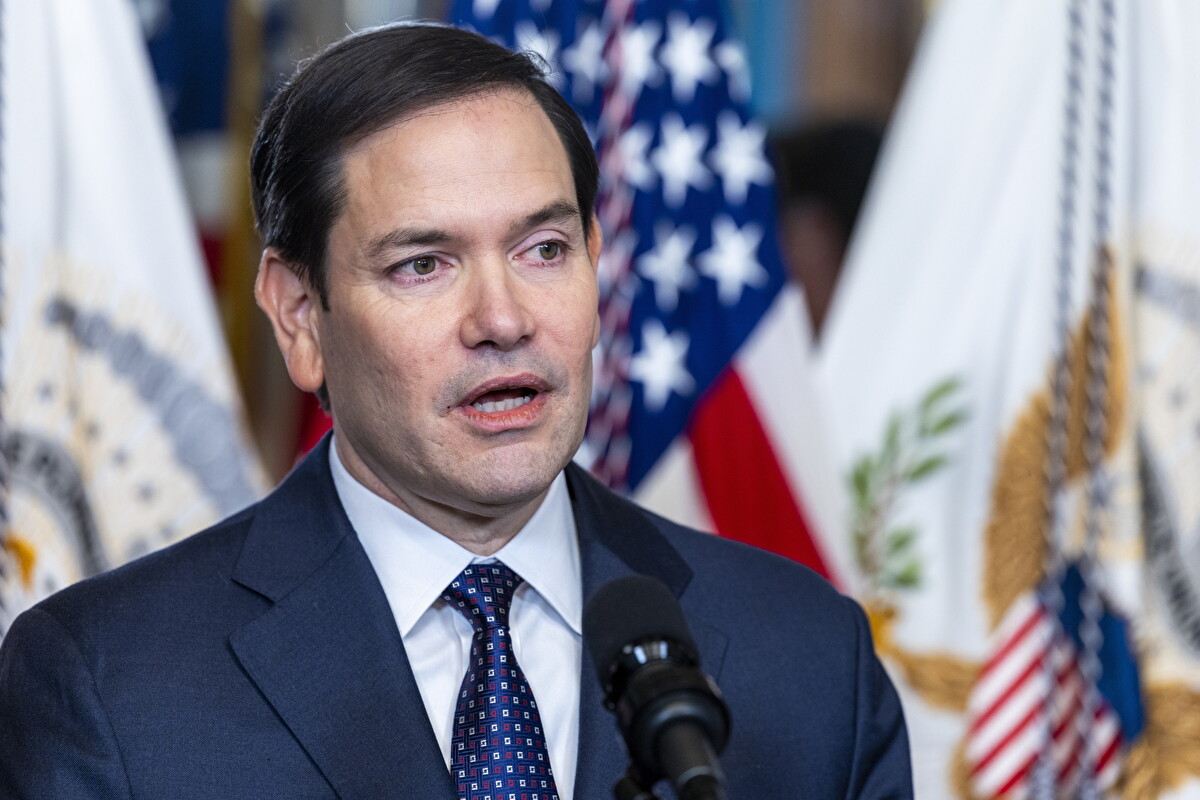Su richiesta dei lettori in questa rubrica, oggi spiego nei dettagli l'uso della particella "ci", un elemento grammaticale molto importante nella lingua italiana ma problematico per gli stranieri che studiano l'italiano e per questo degna di attenzione.
La particella "ci" si comporta in modo diverso, a seconda del verbo con cui coesiste. Generalmente conosciuta con il valore di avverbio di luogo, ha invece un uso larghissimo in unione con essere, avere, e altri verbi, ma è anche usata in espressioni idiomatiche come "Ci vediamo!" e "Ci sentiamo"; due situazioni verbali diventate una vera e propria formula di saluto, e abbinati a "ciao": "Ciao, ci sentiamo!" o "Ciao, ci vediamo!" sostituiscono il tradizionale arrivederci. Comunque la "ci" è anche comune nelle espressioni idiomatiche con i verbi contare, mettere, sentire, vedere e volere, come in questi esempi: "Posso contare sul tuo aiuto domani?", "Certo, contaci!" (conta sul mio aiuto); "Da Milano a Roma ci vogliono solo tre ore (servono, sono necessarie)"; "Senza i miei occhiali non ci vedo bene" (il ci in questo caso serve soltanto a rafforzare l’azione di vedere).
L’uso di "ci" colloquiale con il verbo avere è una caratteristica del parlato e non dello scritto formale. Il "ci" colloquiale è diffuso tra parlanti, anche colti, e in tutte le regioni d’Italia. La funzione di "ci" è diversa a seconda degli specifici verbi in cui la particella è incorporata, e, quindi, a volte ha un valore avverbiale e significa “in questo/quel luogo.” Usiamo la "ci" per non ripetere un luogo di cui abbiamo già parlato, e si usa per sostituire un luogo con verbi di movimento andare, stare, restare, rimanere, ritornare, tornare e con il verbo essere. Per esempio: "Ieri sono arrivata a scuola alle 8:30 e ci sono rimasta sino alle 15:00" (ci = a scuola); oppure, "Conosco bene Manhattan e ci sono molte cose interessanti" (ci = Manhattan); "Conosciamo Napoli e ci andiamo spesso" (ci = Napoli). Due esempi, invece, di moto a luogo: "Mi piace andare in montagna, e ci vado spesso" (ci = montagna); "Oggi non posso andare a scuola, ma domani ci vado di sicuro" (ci = scuola). Ancora, "ci" può sostituire il locativo: "Sono stata a Siena e ci voglio ritornare" (ci = in questo/quel luogo).
La "ci" si usa seguita dalle preposizioni a, su, e in: "Credi a quello che ho detto?", "Sì, ci credo".
Tuttavia la "ci" può essere anche una particella riflessiva, cioè riflettere un’azione abituale che “noi” facciamo con noi stessi, come: "Ci metto un’ora per andare a scuola" (è necessaria un’ora per andare a scuola). Da non confondete con il pronome riflessivo prima persona plurale "ci": "Ci alziamo tutte le mattine alle sei, poi ci vestiamo e ci prepariamo per iniziare la giornata". La "ci", per spiegarlo in modo semplice, è pure una particella pronominale e si usa con i verbi seguiti dalle preposizioni "a", "su", e "in"; significa "a ciò", "in ciò", "su ciò", come in questi esempi: "Non devi fare caso alle sue parole!", "No, non ci faccio caso" (a ciò/quello); "Matteo vincerà la gara, ci scommetto la testa!" (su questo fatto); "Era solo uno scherzo ma Anna ci è caduta subito" (caduta nello scherzo: espressione idiomatica).
Come accennato sopra, la "ci" è anche pronome e può essere usata in modo diretto: "Paolo ci incontra ogni giorno a scuola" (Chi incontra Paolo? Paolo incontra noi); oppure come pronome indiretto: "Maria ci telefona per invitarci" (a chi telefona Maria? Lei telefona a noi).
La lista è lunga, e a volte per gli studenti stranieri imparare a usare la "ci" correttamente diventa una vera sfida, anche perché la particella è spesso un pronome dimostrativo che indica “a ciò /a questa cosa", o "a quello/a”, esempio: "Credi a quello che ha detto il direttore?", "Sì, ci credo" (credo a quello che lui ha detto). Poi, "ci" si usa con i verbi modali, con “volere” e come locuzione fissa: "Ci vuole molto tempo per costruire una casa, e ci vogliono molti soldi". Altri esempi con gli altri due verbi modali, dovere e potere: "Ci devi andare subito. . .", "No, non posso andarci" (avverbio di luogo). Nell’ultimo esempio "ci" è unito all’infinito: se c’è un verbo modale (dovere, potere, volere) o un altro verbo che regge un infinito "ci" si unisce alla desinenza dell’infinito.
Ancora, "ci" può trovarsi con il verbo provare: "Hai mai sciato? Provaci!", "Ci provo subito". Con il verbo lavorare la "ci" si usa per sostituire un complemento di compagnia: "Conosco bene il dott. Bianchi, ci lavoro da tre anni" (lavoro con lui).
Il verbo riuscire (come il verbo pensare e il verbo credere) è spesso costruito con la particella pronominale "ci": "Vai al mare?", "Non so se ci riuscirò"; "Voterai per un partito di sinistra?", "Mah, ci sto pensando"; "Sono stanco perché ho lavorato troppo", "Sì, ci credo!".
Con il verbo pensare, per sostituire un oggetto indiretto: "a questa cosa", "a questo fatto", "a ciò". Ecco degli esempi: "Non preoccuparti della cena, ci penso io" (penso io a questo, alla cena); "Questo è un problema ma non voglio pensarci troppo" (pensare al problema). In italiano, il verbo pensare ha spesso un significato idiomatico e unito con la particella "ci" significa pensare a qualcosa, a un fatto a un evento, o prendersi cura di qualcosa, preoccuparsi di fare qualcosa, o riflettere su qualcosa. Altri esempi: "Chi prepara l'insalata?", "Ci penso io" (Me ne occupo io, la faccio io); "Ricordi quando venivamo in questo parco da bambini?", "Sì, ci penso spesso" (a questa cosa, a questo fatto).
"Ci" si usa anche con il verbo credere, per sostituire la cosa in cui si crede: "Non mi piace leggere sugli UFO", "Non ci credo"; "Maria mi ha raccontato molte cose del suo ragazzo, ma io non ci ho creduto". Nei tempi composti, il participio passato non si accorda in genere e numero con l’oggetto al quale "ci" si riferisce, come: "Ho ascoltato le sue parole e ci ho ripensato molte volte (a quello che ha detto)".
 Filomena Fuduli Sorrentino, insegna alla South Middle School, ECSD, Newburgh, NY. Nata e cresciuta in Italia, calabrese, vive a New York dal 1983. Diplomata alla scuola Magistrale in Italia, dopo aver studiato alla SUNY, si è laureata alla NYU- Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, con un BS e MA in Teaching Foreign Languages & Cultures. Dal 2003 insegna lingua e cultura italiana nelle scuole pubbliche a tempo pieno e nelle università come Adjunct Professor. È abilitata dallo Stato di New York all’insegnamento nelle scuole pubbliche delle lingue italiana 1-6 & 7-12, ESL K-12 e spagnola 1-6 & 7-12.
Filomena Fuduli Sorrentino, insegna alla South Middle School, ECSD, Newburgh, NY. Nata e cresciuta in Italia, calabrese, vive a New York dal 1983. Diplomata alla scuola Magistrale in Italia, dopo aver studiato alla SUNY, si è laureata alla NYU- Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, con un BS e MA in Teaching Foreign Languages & Cultures. Dal 2003 insegna lingua e cultura italiana nelle scuole pubbliche a tempo pieno e nelle università come Adjunct Professor. È abilitata dallo Stato di New York all’insegnamento nelle scuole pubbliche delle lingue italiana 1-6 & 7-12, ESL K-12 e spagnola 1-6 & 7-12.