Ilda Boccassini ha scritto un libro: La stanza numero 30. Cronache di una vita Feltrinelli. Omettiamo i suoi titoli, a tutti noti, ed anche perché, così, scandendone solo nome e cognome, il tratto essenzialmente personale di molte pagine, ne risulta subito fissato.
 Essenzialmente, ma non esclusivamente, però. E non per la ovvia considerazione che i ricordi, i fatti, le persone che vi si affollano, sono connessi alla dimensione pubblica dell’autrice. Sarebbe rilievo troppo generico e, perciò, superfluo.
Essenzialmente, ma non esclusivamente, però. E non per la ovvia considerazione che i ricordi, i fatti, le persone che vi si affollano, sono connessi alla dimensione pubblica dell’autrice. Sarebbe rilievo troppo generico e, perciò, superfluo.
Ma perché, se la memoria, quale riflesso narrativo di un tempo passato, che si è chiuso dopo oltre quarant’anni all’incalzare della cronaca, può oggi ragionevolmente riguardare tutti i capitoli della sua vita pubblica/privata, non può però abbracciarne uno. Uno in particolare. Lì la narrazione, se pure vi ambisse, non potrebbe in nessun modo presentarsi come personale, cioè, protetta dal legittimo perimetro della sensibilità e del giudizio intimo e privato. Lì il personale cessa, e invece perdura, incalza, comincia e ricomincia la dimensione collettiva, comunitaria dei fatti. Per questo scrivevo che il tratto di questo libro è essenzialmente personale, ma non del tutto.
Il capitolo (inteso come materia, argomento, non in termini rigidamente editoriali), che rimane aperto, di primario, attuale, pubblico interesse e che, perciò, non può cingersi della corona protettiva della memoria individuale, è quello del “maggiore depistaggio della storia repubblicana”. Quello sulla strage Borsellino, quello di un definito gruppo di magistrati, delle loro protezioni istituzionali, dei loro atti giudiziari ed extragiudiziari, delle loro scelte, delle loro motivazioni, fra i quali e attraverso i quali, quel depistaggio potè essere ideato e consumato.
Tutte le altre vicende: la svolta “anticonservatrice” di Francesco Saverio Borrelli, nel corso dei suoi primi anni in magistratura (quelli della “Stanza numero 30”); il suo molteplice rapporto con Falcone; il Processo-Squillante; i Processi alle cellule della ‘Ndrangheta in Lombardia; i Processi cd Ruby; le polemiche e l’immagine esteriore (“una virago”, “Ilda la Rossa”), descrivono altrettante tappe di piccola e grande storia repubblicana: e certo costituiscono oggetto della varietà dei giudizi, dei pregiudizi, delle passioni, che spesso la storia sa suscitare, specie se ancora recente. Ma sono storia: fatti che, bene o male, hanno trovato una loro posizione di quiete.
Ma il “depistaggio”, no. Quello è ancora un inciampo per la coscienza nazionale, se una ce n’è: autenticamente, uno”scandalo”.
Del resto, Boccassini ce lo dice subito, ad apertura di libro, che da quelle parti non c’è quiete. Prendendo le mosse dal ricordo di un biglietto di auguri per il “Nuovo Anno 1992”, scrive: “nessuno avrebbe potuto immaginare che proprio quell’anno avrebbe cambiato radicalmente la mia vita privata e professionale”. E si capisce.

Ucciso Falcone, la moglie e la sua scorta, si fa applicare alla Procura di Caltanissetta: anni duri, mesi duri, giorni e ore dure, dolorose, tumultuose: per il cuore di una giovane donna, come per l’intelligenza della verità di un abile e capace magistrato.
A partire da quell’anno, cruciale per una, come per tutti noi, nasce però, nella vita di Boccassini, una divaricazione: mentre la ricerca per la Strage di Capaci si traduce nella giusta “soddisfazione per essere riuscita, a nemmeno due anni dalla strage, a portare a giudizio le persone che avevano le mani lorde del sangue di Capaci”, sul fronte di Via D’Amelio, soffre “l’amarezza per il deterioramento del clima interno all’ufficio”. Non interno al Parlamento, o a qualche altro Palazzo della “politica”: ma interno ad una Procura della Repubblica.

Vincenzo Scarantino mentiva. E si vedeva, si sentiva, si capiva. A voler capire, s’intende. Gaspare Spatuzza spiegava, invece, cos’era realmente accaduto in quelle settimane, in quei luoghi. Lei non solo lo disse ma, insieme al dott. Roberto Saieva, leggiamo, volle fissare le ragioni della palese ciarlataneria di Scarantino: in due atti formali, due relazioni. Tutto questo è arcinoto, e oggetto di numerose sentenze: su tutte, la “Borsellino quater”, fresca di passaggio in giudicato (quattro giorni fa: ad ulteriore testimonianza del fatto che qui non ci può essere “personale”, né “passato”).
Contro Spatuzza si alza un muro di ostilità: gli si vuole negare l’ammissione al Programma di protezione: “Niente da fare. Antonio Ingroia aveva appena escluso che ci fossero le condizioni perché la Dda di Palermo possa chiedere un programma speciale di protezione*. Al che Di Matteo rese più esplicito il suo pensiero: *Sono contrario*, scandì l’enfant prodige della procura di Palermo, alla richiesta di un piano provvisorio di protezione*”. Né definitiva, né provvisoria, la protezione. Spatuzza doveva dissolversi. Non sfugga la potenza critico-ironica, e magari sarcastica, di quel “enfant prodige.”
Ma Boccassini non limita il suo durissimo giudizio a quelle iniziali settimane di quasi trent’anni fa, o solo a quei nominati “colleghi”: scrive della “discutibilissima gestione dei lunghissimi dibattimenti sulla strage di via D’Amelio, in cui i numerosi pubblici ministeri, avvocati di parte civile e la stessa Corte, non sono stai in grado di arginare le dichiarazioni contraddittorie di Scarantino, che alternava i suoi racconti con la volontà di ritrattarli”.
Dove i due superlativi assoluti, “discutibilissima gestione” e “lunghissimi dibattimenti”, cadono a definire l’ampiezza del guasto. Non si è potuto fare così male, e per un tempo tanto esteso, se non con il concorso di una molteplicità di fattori. E di attori: finora rimasti invisibili “nella qualità”, anche se li abbiamo visti ogni giorno. C’è mezza Italia, dietro questo “scandalo”.
Magistrati: ma non solo, infatti, come accennato: “Senza voler polemizzare, mi sarei aspettata più rispetto da parte dei famigliari di Borsellino”. Quali? Non essendo una che le manda a dire, aggiunge: “Ero attonita: il fratello di Paolo Borsellino, per bocca del suo legale, cercava di screditarmi, di attribuire anche a me –anzi, solo a me- la cattiva gestione delle prime ore di Vincenzo Scarantino”.
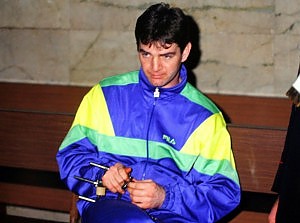
E tale è stata la ferita per un simile stato di cose, dove la menzogna non è più nemmeno una menzogna, ma si fa culto fanatico di sé, di un proprio tristissimo ruolo, interno ed esterno a certe istituzioni, e a talune cerchie, che nell’ultima occasione in cui, lei, pur donna coriacea e temprata quant’altre mai, dovette subire l’ennesima manifestazione di questo atteggiamento ostile (si trattava di un’audizione proprio a Caltanissetta), ha chiosato: “attesi il volo che mi avrebbe riportato a casa, felice di tornare alla civiltà”. La civiltà del diritto negato, di fronte alla barbarie del sopruso affermato, sostenuto, incoronato.
Nessuno può seriamente dubitare della sincerità di questi sentimenti. Come di altri, che pure si è ritenuto di rendere di pubblica ragione, con movenza non felicissima (non il suo amore per Giovanni Falcone, peraltro, non esattamente un mistero: ma taluni suoi momenti, così intimi, che forse li avremmo meglio intesi, se fossero rimasti fra la nostra umana intuizione e l’esclusivo riserbo di chi li ha vissuti).
Quando, tuttavia, la memoria non riesce ad essere memoria, perché non può ancora esserlo; quando la sofferenza non si placa (e il nome tormentoso di Scarantino, non a caso, tornerà fino alle ultime pagine), c’è solo un modo per trovare la pace intorno al proprio tempo: dire la verità, articolarla oltre la propria memoria. Ciò significa chiedere, chiedere, e ancora chiedere, coniugando la forza della donna e del magistrato, che l’Italia colpita da quelle menzogne, possa pubblicamente esigere conto e ragione da chi quelle menzogne ha voluto, imposto e protetto. E sia finalmente ascoltata.












