Giuseppe Catozzella è uno scrittore milanese che ha raggiunto il successo con un trittico di romanzi centrati sul tema delle migrazioni e dell’incontro con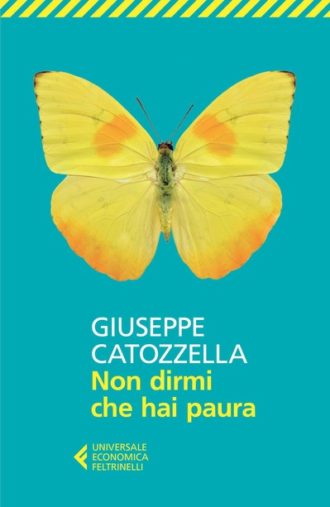 l’altro. Il primo è stato Non dirmi che hai paura, pubblicato nel 2014, vincitore del premio Strega giovani, un caso letterario che ha venduto 250.000 copie solo in Italia e quasi 500.000 copie nel mondo. Il romanzo è ispirato ad una storia reale, quella di un’atleta somala, Samia che, dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Pechino del 2008, consapevole del fatto che nel suo Paese non avrebbe mai avuto un futuro, come sportiva e forse come donna, tenta di raggiungere l’Italia su un barcone, come tanti altri rifugiati, e muore nel Mediterraneo. A questo lavoro sono seguiti Il grande futuro, romanzo di formazione ambientato nel Corno d’Africa devastato dai conflitti, ed E tu splendi, storia dell’incontro fra un bambino, figlio di immigrati lucani a Milano, che durante una vacanza estiva in un paesino sulle montagne della Basilicata incontra una famiglia di sette stranieri, che vive all’interno della Torre Normanna del paese.
l’altro. Il primo è stato Non dirmi che hai paura, pubblicato nel 2014, vincitore del premio Strega giovani, un caso letterario che ha venduto 250.000 copie solo in Italia e quasi 500.000 copie nel mondo. Il romanzo è ispirato ad una storia reale, quella di un’atleta somala, Samia che, dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Pechino del 2008, consapevole del fatto che nel suo Paese non avrebbe mai avuto un futuro, come sportiva e forse come donna, tenta di raggiungere l’Italia su un barcone, come tanti altri rifugiati, e muore nel Mediterraneo. A questo lavoro sono seguiti Il grande futuro, romanzo di formazione ambientato nel Corno d’Africa devastato dai conflitti, ed E tu splendi, storia dell’incontro fra un bambino, figlio di immigrati lucani a Milano, che durante una vacanza estiva in un paesino sulle montagne della Basilicata incontra una famiglia di sette stranieri, che vive all’interno della Torre Normanna del paese.
Al centro di queste opere (ma anche di alcune scritte in precedenza, come il romanzo-inchiesta Alveare, che indagava la penetrazione della Ndrangheta a Milano) vi è naturalmente il rapporto fra narrazione e realtà. Un rapporto molto delicato, che si risolve felicemente solo quando l’autore riesce a trovare una voce credibile con cui raccontare ciò che è “altro da sé”. Catozzella ci è riuscito seguendo la strada più difficile: mettendosi nei panni, nella testa e nella bocca dei suoi protagonisti, quindi scegliendo la narrazione in prima persona. Una sfida temeraria, “pazzesca”, ha ripetuto più volte nel corso della lezione che ha tenuto qualche giorno fa alla scuola Holden di Torino. Una sfida che lo ha portato non solo al successo letterario ma anche alla nomina di Ambasciatore per l’Agenzia ONU per i Rifugiati (Goodwill Ambassador UNHCR), per “aver fatto conoscere in tutto il mondo la storia di una migrante, e attraverso di lei di tutti i migranti”.
La lezione che Catozzella ci ha tenuto alla Holden – la scuola (ormai università a tutti gli effetti) creata a Torino da Alessandro Baricco, che come ho già raccontato su queste pagine sto frequentando dallo scorso autunno – si è conclusa con una visita ad un centro “di aggregazione” a Barriera di Milano, quartiere un tempo colonizzato dagli emigranti del Sud dell’Italia, che ospita ragazzi rifugiati arrivati da poco in Italia.

Ad accompagnarci, oltre a Catozzella, un funzionario dell’ONU. Una volta arrivati, ci siamo messi all’ascolto delle storie delle persone che ci sono state presentate, con l’obiettivo di scrivere eventualmente qualcosa, in maniera molto libera e quindi anche “non giornalistica”, ovvero non pienamente fedele alla realtà. Premesse indispensabili. Non c’è una realtà “unica”, perlomeno non nel mondo della narrazione. Ma la scrittura letteraria può essere, più o meno efficacemente, rappresentazione della realtà, mimesis. E soprattutto: non c’è alcuna realtà, là fuori (diciamo, non c’è alcuna realtà come esperienza condivisa, assieme culturale ed estetica) finché non viene raccontata. Dal che ne deriva, per il narratore, qualsiasi narratore, dai griot che nei villaggi africani tramandano le vicende della comunità, le genealogie, fino ai più noti esponenti della non-fiction novel, come Capote o Saviano, una enorme responsabilità.
Visto il mio amore per l’Africa, io ho scelto di dialogare con una giovane donna originaria del Congo Brazzaville. Ne è scaturito questo breve racconto, che propongo a La Voce di New York. Ritengo sia importante sottolineare di nuovo la premessa. Non è la semplice descrizione di un colloquio, è semmai un prodotto di quel colloquio. Quindi, una rielaborazione letteraria. Buona lettura.
Grace
Ci sono quelli che mi chiedono sempre del Congo e quelli che non gliene frega niente e non sanno neanche dov’è o lo confondono con l’altro Congo, quello che inizia sull’altra sponda del fiume e che fino a qualche anno fa si chiamava Zaire, mentre il “mio” Congo è il Congo Brazzaville, nessuno sa che prende il nome da un italiano, Brazzà, naturalizzato francese ma italiano, di sangue, Pietro Paolo Savorgnan Brazzà.
Insomma, oggi mi è toccato uno della prima specie, uno di quelli che mi chiedono com’è il Congo, e come si vive lì, e se c’è la guerra, e poi com’è la mia famiglia, com’era il posto in cui sono cresciuta, addirittura questo era uno che un po’ il mio paese lo conosceva e a un certo punto mi ha chiesto se ero mai stata sul lago Telè, che sarebbe come se io chiedessi a un italiano se è mai stato in cima al monte Bianco, tanto la difficoltà per arrivarci è la stessa.
Ma ho capito che era sincero, che voleva sentirsi “utile”, era uno di quelli che vogliono bene a noi “migranti”, o a noi “profughi”, quante virgolette ci vogliono attorno a queste parole, e allora cosa fare? Ho cercato di spiegargli.
Man mano che andavo avanti mi sono accorta che era un po’ deluso, ma lo mascherava bene, prendeva appunti col suo computer portatile e faceva sì sì con la testa. Il fatto è che avevo deciso di essere sincera, per quanto si può, e così gli ho detto che io in realtà sono venuta in Italia a 18 anni, per studiare medicina, insomma non ero una profuga, all’inizio, ero una studentessa. Lui avrebbe preferito parlare con una che era arrivata su un barcone, ma non è così, non è la mia storia, non è che le nostre storie sono tutte uguali, anzi, ognuna è diversa, la mia è questa, sono venuta in Italia, a Torino, e alla fine mi sono laureata in medicina. Ho fatto anche un figlio, in Italia: con un italiano? mi ha chiesto, speranzoso. No, gli ho risposto, con uno del Togo, ma non gli ho detto che non so neanche più dov’è, Marcel, l’ultima volta che mi ha scritto è stato da Parigi, sette anni fa, sono passati sette anni, mi aveva scritto da Parigi, dove vivono anche i miei fratelli, io non gliel’ho detto ai miei fratelli e neanche ad Ambrose, neanche a nostro figlio l’ho detto, tanto era troppo piccolo, non avrebbe capito comunque e adesso non se lo ricorderebbe neanche.
Ma allora, perché ha chiesto l’asilo politico? ha insistito. Lui voleva sapere, è giusto. Solo che non è sempre così facile spiegare. È come se io chiedessi a un italiano: perché ti sei sposato? Perché fai l’infermiere, o il giornalista? Perché hai messo tuo papà in un ospizio, non potevi tenertelo tu? Non è che non ci sono ragioni, non è che io perché sono congolese faccio le cose così tanto per fare, nessuno fa così, per fare, né italiano, né congolese, quasi nessuno, perlomeno, se no diciamo: quello è matto. Ma a volte ci sono più spiegazioni, facili, difficili, più difficili che facili, spesso. Ho provato a spiegargli che a un certo punto avevo deciso di tornare nel mio paese, intanto per fare conoscere mio figlio alla mia famiglia, e poi perché avevo iniziato a fare un sogno, il sogno di lavorare là, in Congo, come medico, pensavo di fare il medico militare, perché avevo uno zio che era colonnello dell’esercito, poi vedi come sono, ho il fisico adatto, ci sarei stata bene in divisa. Così a quel punto ho scoperto che mio zio non era più tanto benvoluto, che era, come si dice in Italia? Caduto… nella disgrazia? In disgrazia, sì, caduto in disgrazia con il governo e con il nostro presidente, e a un certo punto lo avevano anche messo in prigione. Mentre un altro mio zio, che stava dall’altra parte, con i ribelli, è proprio sparito, sparito del tutto, probabilmente i governativi lo hanno preso. Potevo io non sapere queste cose, quando avevo deciso di tornare a Brazzaville? Certo, perché noi congolesi non ci parliamo tanto, quando ci telefoniamo, abbiamo questa paura a farlo, che lo so, può sembrare esagerata, e infatti lui mi guardava con due occhi, prendeva appunti con il suo pc e mi guardava come se fossi… pazza, però non sono pazza, noi congolesi pensiamo sempre che qualcuno ci ascolti anche se è difficile che un piccolo stato come il Congo possa riuscire ad ascoltare tutte le telefonate e leggere tutte le mail e le lettere.
Dopo mi ha chiesto: e tuo papà, con chi stava tuo papà?
E io gli ho detto, mio padre stava un po’ di qua e un po’ di là, un po’ con i governanti e forse anche un po’ con i ribelli, di nascosto, fin che l’altro zio non è scomparso. In questo modo la nostra famiglia si sentiva abbastanza tranquilla. Ma ormai non più, e infatti mi hanno detto di tornare in Italia, che dovevo togliermi dalla testa questa pazza idea di fare l’ufficiale medico, visto che lo zio colonnello lo avevano messo in prigione, era meglio che tornassi a Torino, con Ambrose, a fare la specializzazione e poi chissà.
Così, sono tornata in Italia. Non ho deciso subito di chiedere lo status di rifugiata, non ero molto contenta di diventarlo perché mi sembrava che così avrei sempre dovuto giustificarmi, con quelli che dicono: tu prendi i 35 euro, tu prendi la casa e la porti via agli italiani, tutte queste cose.
Però alla fine ho ascoltato i consigli che mi hanno dato i miei amici dell’associazione e mi sono decisa. Adesso ho l’asilo politico e posso anche lavorare, faccio sostituzioni, dei medici di base, anche se vorrei specializzarmi in dermatologia, e poi sono diventata presidentessa dell’associazione, aiutiamo gli altri rifugiati, gli spieghiamo come funziona qui, come usare tutte le possibilità che ci sono.
Lui ancora non era contento, non riusciva a capire se aveva davanti una perseguitata o no, se io in Congo rischiavo la vita o no, e non lo so neanch’io, con certezza, oppure sì, ad un certo punto ho pensato che là rischiavo grosso e ho deciso di tornare in Italia più in fretta che potevo, per me e per mio figlio, ma se io rischiavo o non rischiavo veramente la vita non lo saprò mai, perché per saperlo al cento per cento sarei dovuta rimanere là, e però in quel caso forse adesso non sarei più neanche viva, per rispondere a questa domanda.
Alla fine si è rilassato, e ha smesso di scrivere, ci siamo messi a parlare di cucina, poi di musica, perfino di cinema, anche se io non ci vado spesso, e poi dopo un po’ il suo tempo era scaduto e ci siamo salutati.
Così anch’io sono tornata a casa. Ho chiuso l’associazione e sono andata a prendere il tram, sono solo 3 fermate per casa mia ma non avevo voglia di camminare.
E ho pensato: che cos’è che non ti chiedono mai, Grace? Di cos’è che non si parla, perché non c’è tempo o non viene in mente a nessuno? Ad esempio di com’è svegliarsi nel proprio letto, al mattino, il letto italiano, che è sempre una novità, dopo tanti anni, e andare al mercato di Porta Palazzo, e che impressione può fare una luce così e cosà, dopo la pioggia, una luce che passa, che… come si dice in italiano? Che filtra, ecco, che filtra attraverso le nuvole, e all’improvviso mi fa ricordare una luce identica, che ho visto a Brazzaville, tornando da scuola, un pomeriggio che avevo 16 anni, cioè 16 anni fa, mi dico: Grace, era così quella volta che si era allagata tutta la strada, e poi la mamma ti ha mandata a prendere il tuo fratellino più piccolo che si stava sporcando tutto dentro le pozze, le…pozzanghere, e c’era un doppio arcobaleno, sopra la città e le case, l’unica volta che ho visto il doppio arcobaleno, nella mia vita.
Ma forse di queste cose si può parlare solo con il proprio innamorato. E allora io non lo farò mai perché io, grazie a dio, non sono innamorata, fino a prova contraria, nossignore, e non ho intenzione di innamorami più, no grazie, almeno non adesso, ecco, mh, grazie, non adesso.












