Nel cantone svizzero del Vallese, dove si contano ben 680 ghiacciai, fra i quali l'Aletsch, il più grande d'Europa con 120 chilometri quadrati di superficie, il ghiacciaio dell'Allalin ha scarso rilievo con i suoi soli 10 chilometri. Ma per tanti, quel ghiacciaio si staglia, da mezzo secolo, enorme, mostruoso.
Era il pomeriggio del 30 agosto 1965, quando più di due milioni di metri cubi di ghiaccio si staccarono dall'Allalin intrappolando 88 operai che lavoravano alla costruzione della diga sul lago di Mattmark: 23 svizzeri di paesini confinanti, e soprattutto stranieri immigrati, in gran parte italiani, che in quel cantiere (come a Marcinelle e in altri luoghi di lavoro) avevano cercato un modo per sfuggire alla miseria. Lavoravano alla costruzione di una diga per quella che è oggi una delle più grandi centrali idroelettriche d'Europa. Operavano in condizioni massacranti, a 2.000 metri di altitudine, esposti a tormente di neve durante l'inverno: 59 ore a settimana di lavoro per contratto e la possibilità di prolungarle fino a 18 ore giornaliere. In tanti acconsentivano: erano lì per guadagnare denaro da inviare alle famiglie lontane.
La Svizzera negli anni Sessanta e Settanta accolse circa la metà dell'intero flusso migratorio italiano: per lo più operai impiegati nell'edilizia e nella costruzione delle grandi opere intraprese in quegli anni in tutta la Confederazione Elvetica. Erano imprese notevoli sotto il profilo ingegneristico. Si lavorava in un territorio difficile, fra grandi fiumi e aspre montagne. Quelle opere venivano esaltate con toni epici. E spesso però non si dava sufficiente attenzione alla sicurezza sul lavoro, specie quando si trattava di bassa manovalanza.
 A Mattmark tecnici e operai specializzati erano alloggiati a valle del cantiere. Le baracche dei manovali erano state situate esattamente sotto la lingua del ghiacciaio, per risparmiare tempo e denaro durante le attività. Nel distacco i materiali in caduta del ghiacciaio non danneggiarono quasi per nulla la diga e il cantiere, ma travolsero quelle baracche. Istintivamente gli operai vi avevano cercato rifugio nel momento in cui avevano avvertito gli scricchiolii del ghiacciaio che cedeva. Rimasero sepolti da un ammasso di oltre 50 metri: ci sarebbero voluti sei mesi per recuperare i corpi.
A Mattmark tecnici e operai specializzati erano alloggiati a valle del cantiere. Le baracche dei manovali erano state situate esattamente sotto la lingua del ghiacciaio, per risparmiare tempo e denaro durante le attività. Nel distacco i materiali in caduta del ghiacciaio non danneggiarono quasi per nulla la diga e il cantiere, ma travolsero quelle baracche. Istintivamente gli operai vi avevano cercato rifugio nel momento in cui avevano avvertito gli scricchiolii del ghiacciaio che cedeva. Rimasero sepolti da un ammasso di oltre 50 metri: ci sarebbero voluti sei mesi per recuperare i corpi.
La tragedia ebbe risalto mediatico in Svizzera e all'estero. Non mancarono solidarietà e vicinanza delle istituzioni confederali e del Canton Vallese per le famiglie delle vittime. Allo stesso tempo, però, la Svizzera si sentì attaccata dallo sdegno che si sollevò, non solo in Italia, a seguito della tragedia. Parte della stampa elvetica arrivò a tacciare gli italiani e le famiglie delle vittime di essere “agitatori comunisti”.
Era evidente il tentativo di difendere l'azienda committente del cantiere, l'Elektrowatt AG, insieme alle autorità cantonali che avevano concesso le autorizzazioni. Niente di più semplice, ma anche niente di più falso, che attribuire la disgrazia alle cause naturali. L'instabilità del ghiacciaio era risaputa: dal Cinquecento la valle aveva subito più di un'inondazione e, ancora dopo i luttuosi eventi del 1965, distacchi del ghiacciaio si sarebbero ripetuti fra il 1999 e il 2000.
Inoltre, per assicurarsi di realizzare la diga prima dell'inverno, il lavoro era stato accelerato, annullando la tradizionale sospensione di agosto, periodo a rischio perché più caldo e quindi favorevole allo scioglimento del ghiacciaio. Numerose erano state le avvisaglie, sempre più minacciose soprattutto nei giorni immediatamente precedenti quel 30 agosto: gli stessi operai avevano notato che sotto il ghiacciaio scorreva acqua che lo faceva lentamente scivolare a valle.
L’inchiesta richiese tempi assai lunghi. Al processo di primo grado gli imputati furono tutti assolti dall'accusa di omicidio colposo e in appello l'assoluzione fu confermata. Poi l’oblio, e fu come seppellire per la seconda volta le vittime di Mattmark.
Nel cinquantenario della tragedia, l’impegno è volto al recupero della memoria. Le commemorazioni non sono solamente simboliche; c'è la volontà di capire, di indagare in maniera accurata su quanto è avvenuto, analizzarlo dal punto di vista storico e sociale e renderlo noto non solamente agli addetti ai lavori, storici e sociologi. Il progetto è impegnativo e vede l’attivo coinvolgimento di istituzioni politiche e scientifiche, tanto sul versante italiano che su quello svizzero.
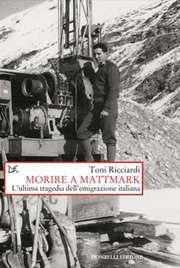 All'università di Ginevra, il dipartimento di Sociologia conduce il progetto di ricerca Mattmark, 50 ans après. Une analyse socio-historique, finanziato dal Fonds National Suisse, con il sostegno del Canton Vallese, della Croce rossa svizzera e dei sindacati svizzeri Unia e Syna, sotto la guida di Sandro Cattacin, Rémi Baudouï e Toni Ricciardi. E di Toni Ricciardi è il recente volume Morire a Mattmark, Donzelli editore, che ricostruisce in maniera attenta e documentata la storia della catastrofe dimenticata. Le nuove ricerche consentono la rilettura della storia economica svizzera fra Ottocento e Novecento. Assume giusta rilevanza il ruolo degli immigrati, autori della gran parte delle grandiose opere infrastrutturali elvetiche: tedeschi e francesi fino alla fine dell'Ottocento, poi soprattutto italiani. Le grandi linee ferroviarie, i principali trafori alpini fra Italia e Svizzera, sono nati grazie a loro, in condizioni di lavoro durissime, tra incidenti e infortuni che fecero numerose vittime.
All'università di Ginevra, il dipartimento di Sociologia conduce il progetto di ricerca Mattmark, 50 ans après. Une analyse socio-historique, finanziato dal Fonds National Suisse, con il sostegno del Canton Vallese, della Croce rossa svizzera e dei sindacati svizzeri Unia e Syna, sotto la guida di Sandro Cattacin, Rémi Baudouï e Toni Ricciardi. E di Toni Ricciardi è il recente volume Morire a Mattmark, Donzelli editore, che ricostruisce in maniera attenta e documentata la storia della catastrofe dimenticata. Le nuove ricerche consentono la rilettura della storia economica svizzera fra Ottocento e Novecento. Assume giusta rilevanza il ruolo degli immigrati, autori della gran parte delle grandiose opere infrastrutturali elvetiche: tedeschi e francesi fino alla fine dell'Ottocento, poi soprattutto italiani. Le grandi linee ferroviarie, i principali trafori alpini fra Italia e Svizzera, sono nati grazie a loro, in condizioni di lavoro durissime, tra incidenti e infortuni che fecero numerose vittime.
Per richiamare alla memoria collettiva quanto avvenne a Mattmark, nell’ambito delle celebrazioni per il 50° Anniversario della tragedia, promosse dal Comites Vallese e dall'Associazione ItaliaVallese, a cura del Comitato Mattmark 1965-2015 appositamente costituito, sono stati realizzati un documentario sotto la direzione di Nicolas Brun, e una mostra fotografica, curata da Stéphane Marti.
La mostra, intitolata Mattmark. Tragedia nella montagna, si apre con le immagini dell'inaugurazione del cantiere della diga dell'Allalin, con la prosopopea delle grandi opere ingegneristiche di una Svizzera in pieno sviluppo; fotografie del “prima”, con operai sui camion di trasporto pesante, nei pressi delle baracche, fra la neve; fotografie del “dopo”, con gli inutili tentativi di soccorso, l'enorme coltre di ghiaccio che copre il cantiere, il registro dei dispersi e le date del recupero delle salme, gli articoli dei giornali che raccontano la tragedia, le immagini dei funerali in Svizzera e del rientro delle salme degli immigrati nei loro paesi. Dopo l'inaugurazione presso la Biblioteca del Senato italiano, il 12 febbraio del 2015, la mostra sta toccando numerose città italiane, soprattutto quelle nel Bellunese dalle quali proveniva il maggior numero delle vittime, ma anche città del Canton Vallese. Viene ospitata in edifici scolastici e fatta conoscere con presentazioni e dibattiti soprattutto ai giovani, affinché sappiano e non dimentichino.









