“Aveva ragione Max Frish: la letteratura è sempre denudamento. Il mio mondo intellettuale è quello di Sartre, di Camus, di Heidegger. Io voglio sapere dove sono, perché sono io. Scrivere è anche leggere la mia vita, ma non certo una autobiografia. Scrivo per trovare un senso alla vita”. Così Joseph Zoderer in una recente intervista all'Alto Adige, il quotidiano (in lingua italiana) della sua terra, una terra di confine, all'estremo Nord dello Stivale, a lungo contesa e divisa. Il suo ultimo romanzo, I colori della crudeltà, scritto come gli altri in lingua tedesca e appena tradotto da Bompiani, è lungo, denso, descrittivo. C'è la vita in montagna di una famiglia di città, ci sono le stagioni che cambiano, ci sono i sentimenti che durano a dispetto del passare del tempo, che lacerano, travolgono, generando sofferenze difficili da curare, ma anche uno straordinario appetito per la vita. È anche un romanzo fuori dai trend, come gli autori che Zoderer cita nell'intervista, come la Mitteleuropa, come l'esistenzialismo nell'era Renzi, come il Muro di Berlino (il cui crollo fa da sfondo alla terza parte del libro), come leggere la descrizione di una nevicata nel pieno dell'estate più torrida degli ultimi 150 anni. Ma giù il cappello di fronte ad una concezione così alta e "totale" (non totalizzante, perché c'è anche la vita, oltre la pagina) della letteratura.
La vicenda umana di Zoderer è particolare, difficile da seguire per chi non conosce l'Alto Adige/Südtirol, una provincia alpina che era parte dell'Impero austroungarico, annessa all'Italia solo alla fine della Prima guerra mondiale e alla vigilia dell'avvento del fascismo, che proibì l'uso della lingua tedesca, che italianizzò persino i nomi e i cognomi degli abitanti. Nel 1939 Hitler e Mussolini si accordarono, con le cosiddette “Opzioni”, per chiudere la partita: ai sudtirolesi veniva proposto di conservare la loro identità tedesca, ma a a patto di trasferirsi nei territori del Terzo Reich, o di rimanere in Alto Adige italianizzandosi una volta per sempre. A dirla chiaramente, era pulizia etnica. Il dittatore nazista puntava a disporre di nuova “carne da cannone” per la guerra che stava iniziando, il dittatore fascista si apprestava a realizzare il suo sogno di trasformare l'Alto Adige in una terra al 100% italiana, con massicci trasferimenti di persone dalle altre regioni d'Italia. La famiglia Zoderer decise appunto di “optare”, cioè di trasferirsi oltre il confine del Brennero; così lo scrittore, che era nato a Merano, crebbe a Graz, in Austria, e fece ritorno in Alto Adige solo nel 1949. Dopo avere iniziato una carriera come giornalista, negli anni '50 iniziò a muovere i primi passi nel mondo letterario. Il successo arrivò più tardi con Die Walsche, ovvero L'Italiana, pubblicato in Italia da Mondadori. Forse il suo passato di espatriato gli aveva fatto dono di una visione più distaccata e insieme più penetrante delle vicende della sua Heimat, della sua patria: sta di fatto che il romanzo fece scalpore perché rileggeva in maniera critica la convivenza difficile fra italiani e tedeschi, anticipando temi, quali l'identità, il tradimento delle origini, il confronto-scontro fra culture diverse, divenuti poi di estrema attualità con i conflitti balcanici delle anni '90 e le migrazioni internazionali verso l'Europa. Il tutto narrando una "semplice" storia d'amore, fra una tirolese cresciuta in un paese di montagna, la Walsche, appunto (il termine viene usato dai tedeschi per definire gli italiani e ha assunto nel tempo anche connotati dispregiativi), e un italiano di città.
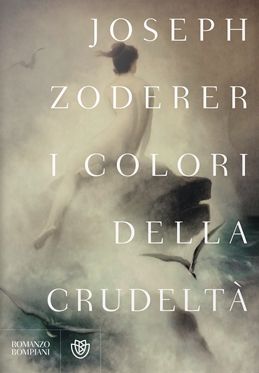 Zoderer si è conquistato con gli anni la stima e l'affetto anche dei lettori italiani, pur continuando a scrivere nella sua madrelingua e pur facendo una vita piuttosto ritirata, in un maso in val Pusteria. In questo ultimo romanzo – uscito in Austria nel 2011 – tornano i temi che hanno contraddistinto la sua opera successivamente a Die Walsche: da un lato le radici, la ricerca di un ancoraggio, rappresentato dall'amore familiare e dalla montagna, dall'altro l'altrove, i viaggi, ma anche la passione che tutto travolge, e a cui non ci si può sottrarre, pur nella consapevolezza che ad essa si deve pagare un prezzo, e che qualcuno soffrirà.
Zoderer si è conquistato con gli anni la stima e l'affetto anche dei lettori italiani, pur continuando a scrivere nella sua madrelingua e pur facendo una vita piuttosto ritirata, in un maso in val Pusteria. In questo ultimo romanzo – uscito in Austria nel 2011 – tornano i temi che hanno contraddistinto la sua opera successivamente a Die Walsche: da un lato le radici, la ricerca di un ancoraggio, rappresentato dall'amore familiare e dalla montagna, dall'altro l'altrove, i viaggi, ma anche la passione che tutto travolge, e a cui non ci si può sottrarre, pur nella consapevolezza che ad essa si deve pagare un prezzo, e che qualcuno soffrirà.
Ne I colori della crudeltà c'è di nuovo un tradimento, ma stavolta non è quello di una ragazza di paese che si sceglie come compagno un uomo che parla un'altra lingua. Non è il tradimento della comunità di appartenenza, garanzia sicura di una collocazione nel mondo. È il più classico tradimento di un uomo sposato, Richard, che ha cercato di costruire un nido per sé e la famiglia in montagna, pur continuando a fare il giornalista e a lavorare in città, scatenato dall'amore per una ragazza più giovane. Ursula, carattere ribelle e ondivago, incarna la passione totale ed insieme l'incertezza e la caducità dell'amore. Richard sa che una vita assieme è impossibile: ma non riesce a staccarsi da lei. Ad un certo punto, tuttavia, la relazione si interrompe, per volontà di Ursula: Richard coltiva in silenzio il dolore causato dalla perdita dividendosi fra il lavoro e la sua casa in valle, che ha restaurato assieme alla moglie Selma. Ma la sua redazione decide di inviarlo a Berlino, dove il Muro sta per cadere. E qui, nella metropoli, improvvisamente Ursula ricompare.
Il romanzo affronta un tema classico, il contrasto fra amore coniugale ed extraconiugale, proiettandolo sullo sfondo di un evento storico di grande rilievo per l'Europa. Può presentare forse qualche difficoltà di lettura per l'escamotage dello scrittore di inframezzare la narrazione con dei brevi corsivi, che restituiscono i pensieri più intimi del protagonista. Ci sono anche il bosco, gli animali, il fiorire della vegetazione, i giochi dei bambini, la lenta ricostruzione del maso, rimasto a lungo abbandonato, e poi la città, con gli sconvolgimenti sociali e politici che la attraversano, con il suo tessuto culturale variegato, espatriati e apolidi compresi (c'è persino un intellettuale italiano condannato per terrorismo che fa pensare a Toni Negri).
Leggetelo se amate Handke, e se non avete bisogno di continui colpi di scena. Leggetelo se pensate che dolore e felicità vadano spesso a braccetto. Leggetelo, se necessario, per scoprire un autore di spessore, italiano per nazionalità, ma non per lingua, un cittadino del mondo con un piede ben piantato nella sua terra fra le montagne ed un altro sempre di là dal confine, qualunque confine.
Joseph Zoderer, I colori della crudeltà (trad. Giovanna Agabio), Bompiani, 2015.
Titolo originale: Die Farben der Grausamkeit, Haymon Verlag, 2011.












