Pubblicato originariamente sul The New Yorker nel 2013, il racconto di Zadie Smith L’ambasciata di Cambogia esce ora in Italia nella collana Libellule di Mondadori, per la traduzione di Silvia Pareschi. Sull’autrice, classe 1975, che si divide fra Londra, la sua città natale, e New York (il suo terzo romanzo On beauty è ambientato a Boston) non è necessario spendere molte parole, talmente “stellare” è il successo che ha raggiunto a soli 23 anni con il suo Denti bianchi.
Il racconto in questione è una storia di immigrazione, una ordinaria storia londinese, verrebbe da dire, o forse, una ordinaria storia del mondo globale. Un paio di settimane fa abbiamo recensito un libro sul tema, Exodus, di Paul Collier, non un’opera di fantasia, ma un saggio. In quel libro una delle “regole auree” che secondo l’autore i paesi di accoglienza dovrebbero rispettare è quella di impedire la nascita di comunità di immigrati “chiuse”, impermeabili alla cultura locale. Zadie Smith racconta la storia di una ragazza che si trova in una condizione specularmente opposta rispetto a quella che teme Collier: una migrante di origini africane che non ha una comunità di riferimento, nella città, o meglio nel quartiere londinese che l’ha accolta, Willesden, non ha nemmeno una famiglia anche se è arrivata lì con l’aiuto del padre, passando per la Libia e l’Italia. In questa storia, in verità, ognuno è solo, ognuno deve fare da sé, al massimo con l’aiuto di qualcuno del quale si ha l’impressione di potersi fidare.
Fatou (che non è l’io narrante, l’io narrante è collettivo, sono gli abitanti di Willesden), è approdata a Londra dal Ghana, pur essendo originaria della Costa d’Avorio. Una volta lasciato il villaggio di origine, assieme al padre, ha lavorato per un po’ in un albergo per turisti sulla costa della capitale ghanese, Accra, dove è stata anche violentata da un russo. A Londra lavora come sguattera-schiava per una famiglia (presumibilmente asiatica, visto il cognome). Non percepisce uno stipendio, il suo lavoro serve a pagare il vitto e l’alloggio. Il passaporto le è stato sequestrato il giorno del suo arrivo. Tuttavia Fatou non si sente davvero una schiava perché, a differenza di altri immigrati di cui ha letto le storie sui giornali, lei ogni tanto può uscire. Soprattutto, grazie a un piccolo sotterfugio (un abbonamento gratuito dei suoi “padroni”, che ha trovato in fondo ad un cassetto), può frequentare la piscina locale, il suo appuntamento fisso del lunedì. Non ha un costume da bagno, però le luci dentro sono sufficientemente basse da permetterle di nascondere il fatto che indossa solo un reggiseno e delle mutande nere. E poi, Fatou può vedere un ragazzo, anche lui africano, della Nigeria, Andrew, che studia, lavora, è come lei molto religioso e la rispetta. Con Andrew, Fatou a volte si impegna in lunghe discussioni, che spaziano dalla ragione del dolore nell’esistenza umana alle responsabilità del diavolo, dall’Olocausto degli ebrei al genocidio in Ruanda. Non è attratta da lui, lo trova grasso e poco elegante, ma percepisce la sua bontà, e in certi frangenti della vita la bontà è già moltissimo.
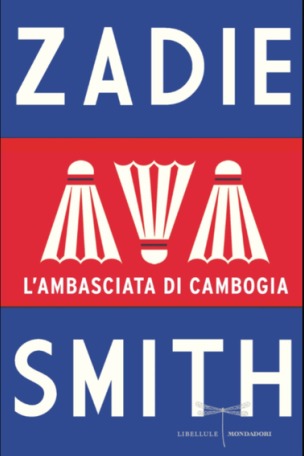 Dicevamo che ognuno è solo, o quasi, in questa storia. Al massimo, si può contare sulle amicizie più prossime. Anche se Fatou avverte confusamente che bisognerebbe essere uniti, che assieme alla capacità di fare da soli è l’unità come popolo, come gruppo, la chiave di sopravvivenza in un ambiente ostile. “Per esempio, quando i cinesi erano arrivati al villaggio di Fatou per impadronirsi della miniera, era sorto un interrogativo assillante: cosa mangiavano e dove mangiavano? Di certo non compravano il cibo al mercato o dai commercianti libanesi lungo la strada principale. Si arrangiavano da soli. (Al suo paese, oppure qui, la chiave per sopravvivere come popolo, secondo Fatou, era sempre arrangiarsi da soli)”.
Dicevamo che ognuno è solo, o quasi, in questa storia. Al massimo, si può contare sulle amicizie più prossime. Anche se Fatou avverte confusamente che bisognerebbe essere uniti, che assieme alla capacità di fare da soli è l’unità come popolo, come gruppo, la chiave di sopravvivenza in un ambiente ostile. “Per esempio, quando i cinesi erano arrivati al villaggio di Fatou per impadronirsi della miniera, era sorto un interrogativo assillante: cosa mangiavano e dove mangiavano? Di certo non compravano il cibo al mercato o dai commercianti libanesi lungo la strada principale. Si arrangiavano da soli. (Al suo paese, oppure qui, la chiave per sopravvivere come popolo, secondo Fatou, era sempre arrangiarsi da soli)”.
Il mondo di Zadie Smith è un mondo atomizzato, è il mondo del XXI secolo, dove le persone si fanno strada con alzate di spalle e robuste dosi di cinismo. Un mondo prosaico e pratico, che va di fretta, e che non lascia molti margini di approfondimento. Un mondo dove si può forse essere liberi, anche dalle catene dell’appartenenza ad una famiglia, una terra di origine, una cultura, ma al tempo stesso spaventosamente isolati e anonimi. “Il fatto è – recita l’io narrante collettivo, l’anima collettiva di Willesden – che se seguissimo la storia di ogni staterello del mondo, nei suoi momenti drammatici come in quelli di calma, non avremmo più spazio per vivere la nostra vita o per dedicarci ai compiti essenziali, né tanto meno per concederci piaceri occasionali come andare a nuotare”.
E l’ambasciata di Cambogia? Beh, l’ambasciata di Cambogia è un altro di questi mondi a parte, impermeabili e sconosciuti, piovuto in fondo alla via. La reminiscenza di un paese lontano, dove è stato perpetrato un altro genocidio. Un luogo chiuso da alte mura di mattoni rossi, anche se non tanto più alte di certe ville lì accanto, del quale si sa solo che nel cortile interno si gioca a badminton. Fatou, prima di entrare in piscina, si ferma a guardare il volano, andare avanti e indietro sopra l’alto muro, colpito dalle racchette di due giocatori invisibili. Poc, smash. Poc, smash.
E per il resto, ciò che conta davvero è trovare un nuovo posto dove andare, quando i padroni la butteranno fuori di casa.
Zadie Smith, L’ambasciata di Cambogia, Mondadori, 2015, trad. Silvia Pareschi (10 euro per 70 pagine, e questo è l’unico appunto negativo che mi sento di fare alla pubblicazione).
Titolo originale: The embassy of Cambodia, prima pubblicazione in The New Yorker, 2013.











