Una grande donna che aveva la ventura di chiamarsi Goliarda Sapienza. Sapienza, cognome ereditato dal padre Giuseppe, antifascista, avvocato “dei poveri”, libertino. E Goliarda, nome di battesimo mutuato dal fratello, morto tre anni prima della sua nascita, forse ucciso dalla mafia, quindi un nome pesante da portare, che però ha in sé il concetto della levità, dell’allegria generata dallo sberleffo.
Venuta al mondo a Catania il 10 maggio 1924, figlia di tante contraddizioni e tanti scandali – del padre abbiamo detto, la madre, Maria Giudice, una nota sindacalista lombarda, già vedova con 7 figli quando conobbe Giuseppe, soffrì nell’ultima parte della sua vita di disturbi mentali – Goliarda, o “Iuzza”, ha percorso strade diverse, spesso avare di riconoscimenti.
Da qualche tempo Einaudi sta ripubblicando i suoi libri, già in parte usciti con altri editori, fra cui Stampa Alternativa, che nel 1998 fece uscire postumo, per la prima volta in edizione integrale, quello che viene considerato il suo capolavoro, L'arte della gioia, romanzo "scandaloso" che aveva terminato di scrivere nel 1976 (tradotto in inglese da Anne Milano Appel per l'editore Farrar, Straus and Giroux).
Recentemente è approdato nelle librerie italiane l'ultimo titolo, La mia parte di gioia. Taccuini 1989-1992, seconda selezione di scritti "privati", dopo Il vizio di parlare a me stessa, del 2011. Un libro che vale per lo sguardo, anzi, gli sguardi, che lancia sul mondo, e per ciò che mostra dell'animo di chi lo ha scritto, un libro-diario come quelli di una volta, pre-internet, pre-blog e Facebook, fatto di appunti presi su agende e foglietti di carta, mai autoreferenziali, capaci di raccontare qualcosa anche al lettore che ignora il background da cui sono scaturiti.
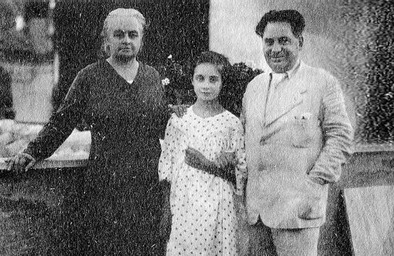
Goliarda con i genitori nella Sicilia degli anni 30
Goliarda Sapienza, dicevamo, è stata tante cose e forse nessuna compiutamente: attrice, prima ancora che scrittrice e poetessa. Nel 1943 era entrata all’Accademia d’Arte drammatica di Roma, frequentandola senza però diplomarsi, anzi, facendo il gesto che hanno fatto tanti idealisti, rifiutare il "pezzo di carta", per creare qualcosa con le proprie mani, in questo caso una compagnia di avanguardia devota al metodo Stanislavskj. Poi gli amori, le relazioni "aperte", la frequentazione del mondo del cinema – in particolare quello del Neorealismo, però senza ottenere parti da protagonista – e quindi l'approdo alla pagina scritta. Ed ancora: due tentati suicidi, la psicanalisi, la povertà, un arresto per furto, la reclusione a Rebibbia, che le permise di condividere un pezzo di vita con persone che sentiva vicine, come dichiarò in una famosa intervista a Enzo Biagi. Ce ne sarebbe abbastanza per farne una sorta di Frances Farmer italiana, e speriamo che Sapienza il paragone non l'avrebbe trovato inadeguato o irriverente.
In La mia parte di gioia il lettore di oggi ritrova il filo della scrittura autobiografica a cui Goliarda Sapienza ha iniziato a dedicarsi fin dagli anni 60. Sono le riflessioni di una autrice a suo modo "aristocratica", che non si è mai piegata al giogo di un lavoro purchessia, e tuttavia difficilmente classificabile come "snob", un'autrice che ha continuato a leggere, a studiare ad analizzare il mondo, rifiutando scuole e dogmi, compresi quelli del socialismo, respirato in famiglia negli anni della giovinezza. Nel periodo coperto da questa selezione, Sapienza è ormai vicina ai 70 anni (morirà di infarto nel 1996, nella sua casa di Gaeta): delusa dai rifiuti delle case editrici (mentre era in vita L'arte della gioia venne sempre ignorato quando non ferocemente respinto dai critici), è tornata sul palcoscenico per un lavoro teatrale di poco valore e pensa anche al cinema. Non si tratta di una lettura decadente o nostalgica, comunque: al fondo vi è la chiara consapevolezza che, a dispetto di ogni amarezza, "ho fatto bene a rubare, sempre, la mia parte di gioia a tutto e tutti".
Queste pagine racchiudono molte cose. Citiamone alcune in ordine sparso.
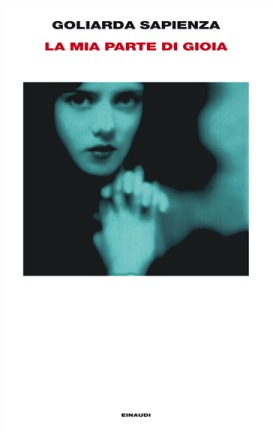
Goliarda Sapienza, La mia parte di gioia. Taccuini 1989-1992, a cura di Gaia Rispoli, prefazione di Angelo Pellegrino, Einaudi, 2013
Alcune splendide descrizioni della marina di Gaeta. Ritratti di persone, come Nastassja Kinski, a cui diede lezioni di dizione (lo aveva fatto molti anni prima con Maria Schell sul set de Le notti bianche di Visconti), ma come anche sconosciuti visti per strada, un tabaccaio gobbo, un presunto manager, una cassiera, un gruppetto di ragazzi che combatte la noia su un lungomare ("non ce la fanno a godersi la pace senza l'assillo della guerra"). Le città viste nel corso di una tournée o un viaggio, descritte con rapide pennellate, straordinariamente vivide. Le epifanie improvvise, che cambiano il volto della giornata, una manifestazione di studenti universitari contro le privatizzazioni, il sorriso di un'amica ritrovata. C'è la fatica quotidiana del vivere, pur con un compagno molto amato che le sta vicino, la minaccia dello sfratto, la paura di avere perso un assegno di 250mila lire, l'alto e il basso della vita, Proust e le bollette, Melville e la spesa. C'è la fame, il continuo richiamo al cibo, tipico di chi conosce l'indigenza.
Ci sono, in queste pagine, anche le miserie dell'industria culturale: soldi (di nuovo) che mancano, piaceri chiesti e mai restituiti, tempi morti, impegni che saltano, capricci, amorazzi, gelosie dietro le quinte. Ci sono i teatri semivuoti, 18 persone paganti. Ci sono le avanguardie che dopo 20 anni diventano retroguardie. Ci sono deliziose "schegge" di quel periodo alla fine degli anni 80 – ad esempio una stroncatura del film Notturno indiano, tratto dall'omonimo romanzo breve di Tabucchi – altrimenti destinate a "perdersi nel tempo come lacrime nella pioggia", direbbe il replicante di Blade Runner.
Ed ancora, la depressione, forse in parte un lascito materno. I ricordi (Mastroianni, Bergman, Morante, Moravia, Garboli…). Il senso della fine che si sposa con l'attenzione così spesso rivolta ai giovani: "In due parole cerco di appuntare lo scandalo che dentro di me suscita sempre questa visione di branchi di ragazzi che da veri e propri sbandati non sanno dove radunarsi la sera (non parlo del cinema perché sia a Formia che a Gaeta ne è rimasto uno solo, carissimo) e come possono sfogano il bisogno di vita chiacchierando fra loro. Per colmo, l'unico ente – chiamiamolo così! – che se ne occupi è l'industria della moda: plagiandoli all'idea che ci si 'realizza' nel look, giù a fare affari con gli stilisti, questi acuti indecenti inventori del falso modo 'artistico' con cui sfogare il bisogno di crescere che quasi tutti i ragazzi hanno a quell'età. Anche sul piano etico-estetico siamo in mano al profitto (…)".
Il libro si apre con una breve prefazione scritta da Angelo Pellegrino, che è protagonista di molti dei "quadretti" dipinti da Sapienza nei suoi taccuini. Pellegrino ricorda come "Iuzza" fosse anche una scrittrice di ampie stesure, cosa dimostrata soprattutto ne L'arte della gioia (ripubblicato da Einaudi nel 2008) nel raccontare la vita di Modesta, sua sorta di alter-ego "vincente", donna siciliana alle prese con le convenzioni del suo tempo e della sua epoca, attraverso amori, incesti, e le ideologie che hanno segnato il XX secolo. La scrittura, sottolinea Pellegrino, "non è un fatto di ispirazione, il vero narratore ignora questa parola, e un po' lo fa sorridere (…). Significa lavorare il più possibile giorno per giorno con una costanza che solo la capacità di far ordine intorno a sé può permettere, ordine nel caos di un mondo, il nostro, dominato dalla prassi di un tempo assai lontano dal lento lavoro artigianale che richiede un lungo romanzo".
Parole che andrebbero scolpite sulla parete dello studio, o della cameretta, di ogni scrittore o aspirante tale.
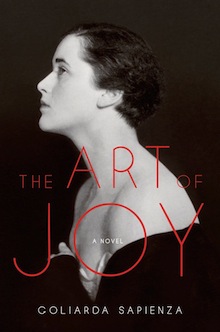
Nota dell'autore:
In inglese il lettore può trovare oggi in libreria il romanzo più famoso di Goliarda Sapienza, The art of joy, Farrar, Straus and Giroux, 2013. Un critico ha scritto che questo romanzo, scoperto prima in Francia e in Spagna che nei paesi anglosassoni e in parte nella stessa Italia, "colonizes your attention like some rollicking, manic mashup of Lampedusa, Laurence Sterne, Dante, David Foster Wallace and Margaret Atwood".












