Tre generazioni a confronto. Tre generazioni legate fra loro dal filo – in questo caso davvero rosso – della dissidenza. La prima, quella rappresentata da Rose Zimmer, ebrea e comunista, la Regina Rossa di Sunnyside Gardens, quartiere “utopico” del Queens progettato negli anni ’20 sotto la supervisione di Lewis Mumford, e dal marito Albert, fuggito con la famiglia dalla natia Lubecca dopo l’inizio delle persecuzioni naziste e rimandato dal partito in Germania a fare la spia alla vigilia dello scoppio della Seconda guerra mondiale. La seconda, quella di Miriam, figlia di Rose e Albert, che nel tentativo di sottrarsi alla schiacciante personalità della madre si getta anima e corpo, assieme al marito Tommy Gogan, aspirante folksinger irlandese, nelle braccia della controcultura del Greenwich Village, e successivamente nel Nicaragua sandinista. La terza, quella di Cicero Lookins, “fratellastro” di Miriam, figlio di un poliziotto nero con il quale la Regina Rossa aveva avuto una lunga relazione dopo la partenza del marito per l’Europa, intellettuale obeso e gay con una passione frustrata per gli scacchi, e di Sergius, quarantenne irrisolto, figlio di Miriam e Tommy, affidato ad una comunità di Quaccheri prima della loro partenza per il Centroamerica.
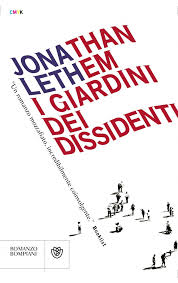 Questi, in breve, i protagonisti dell'ultimo romanzo di Jonathan Lethem, Dissident Gardens (I giardini dei dissidenti), appena uscito in Italia per Bompiani nella traduzione di Andrea Silvestri. Un libro di ambientazione tutta newyorchese, che non è passato inosservato e che ha fatto persino parlare di “rinascita del romanzo politico”, dimenticando che nella narrativa americana contemporanea la politica c’è spesso e volentieri, pensiamo già solo al Franzen di Libertà. Politica, peraltro, in senso lato: il tutto, anche qui, ritorna sempre al tema dei temi, la famiglia e le sue diramazioni, con i traumi prodotti dall’educazione, le aspettative prima coltivate e poi deluse, i fantasmi che i figli tentano faticosamente di esorcizzare, se necessario anche con l’ideologia.
Questi, in breve, i protagonisti dell'ultimo romanzo di Jonathan Lethem, Dissident Gardens (I giardini dei dissidenti), appena uscito in Italia per Bompiani nella traduzione di Andrea Silvestri. Un libro di ambientazione tutta newyorchese, che non è passato inosservato e che ha fatto persino parlare di “rinascita del romanzo politico”, dimenticando che nella narrativa americana contemporanea la politica c’è spesso e volentieri, pensiamo già solo al Franzen di Libertà. Politica, peraltro, in senso lato: il tutto, anche qui, ritorna sempre al tema dei temi, la famiglia e le sue diramazioni, con i traumi prodotti dall’educazione, le aspettative prima coltivate e poi deluse, i fantasmi che i figli tentano faticosamente di esorcizzare, se necessario anche con l’ideologia.
L’affresco tracciato da Lethem copre un arco di tempo che va dagli anni ’30 a Occupy Wall Street, passando per la stagione del Maccartismo, il ’68, gli hippies, il Chelsea hotel, Dave van Ronk & Bob Dylan e così via. Ma queste informazioni le potete trovare anche sull’aletta di copertina e dunque, utilizziamo lo spazio che ci rimane per dire qualcosa su ciò che conta veramente, ovvero: la perfetta macchina narrativa che gli scrittori americani sono capaci di mettere in moto quanto scrivono romanzi-fiume come questo. Sì, perché anche stavolta, come in innumerevoli altre occasioni, quando il lettore comincia, è preso al laccio, e non può fare altro che risalire felicemente la china delle 500 e rotte pagine di cui consta il volume.
 E dire che un recensore italiano ha parlato di opera “farraginosa, difficile”. C’è da chiedersi: che cosa ha letto recentemente, a parte le Cinquanta sfumature? E come giudicherebbe allora Javier Marìas, per non dire di un Bernhard o di un Gombrowicz? No, signori: questo non è un romanzo "difficile"; ci sono un po’ di salti temporali nella narrazione (nulla in confronto a quelli che ci ha proposto De Lillo in Underworld). Per il resto, ci troviamo di fronte ad un altro di quei libri americani che non solo scorrono via come la più appassionante delle serie televisive (ed è una bella sfida oggigiorno, ammettiamolo), ma che contiene passaggi che sembrano fatti apposta per il cinema. Come dimenticare ad esempio la spedizione notturna a Brooklyn di Miriam e dei suoi amici, alla ricerca di una presunta festa di Norman Mailer, che si conclude in maniera tragicomica con Rose che cerca di ficcare la testa della figlia nel forno a gas, dopo averla sorpresa nella sua cameretta con uno studente di college? Come non trovare perfettamente cinematografica la “scena” (chiamiamola pure così) in cui Miriam convince Tommy – nuova incarnazione letteraria dell’aspirante artista, sincero e senza talento – a lasciar perdere con tutte quelle canzoni di protesta sul Sud Africa o su Haiti perché “abbiamo anche noi i nostri negri, devi solo scendere le scale”, e lo trascina nella Bowery innevata a far conoscenza con i senzatetto?
E dire che un recensore italiano ha parlato di opera “farraginosa, difficile”. C’è da chiedersi: che cosa ha letto recentemente, a parte le Cinquanta sfumature? E come giudicherebbe allora Javier Marìas, per non dire di un Bernhard o di un Gombrowicz? No, signori: questo non è un romanzo "difficile"; ci sono un po’ di salti temporali nella narrazione (nulla in confronto a quelli che ci ha proposto De Lillo in Underworld). Per il resto, ci troviamo di fronte ad un altro di quei libri americani che non solo scorrono via come la più appassionante delle serie televisive (ed è una bella sfida oggigiorno, ammettiamolo), ma che contiene passaggi che sembrano fatti apposta per il cinema. Come dimenticare ad esempio la spedizione notturna a Brooklyn di Miriam e dei suoi amici, alla ricerca di una presunta festa di Norman Mailer, che si conclude in maniera tragicomica con Rose che cerca di ficcare la testa della figlia nel forno a gas, dopo averla sorpresa nella sua cameretta con uno studente di college? Come non trovare perfettamente cinematografica la “scena” (chiamiamola pure così) in cui Miriam convince Tommy – nuova incarnazione letteraria dell’aspirante artista, sincero e senza talento – a lasciar perdere con tutte quelle canzoni di protesta sul Sud Africa o su Haiti perché “abbiamo anche noi i nostri negri, devi solo scendere le scale”, e lo trascina nella Bowery innevata a far conoscenza con i senzatetto?
Da segnalare infine un’ultima critica, quella riguardante alcune situazioni giudicate poco verosimili, come il “processo domestico” con cui si apre il romanzo, che culmina nella cacciata di Rose dal Partito comunista americano a causa della sua relazione con il poliziotto di colore del quartiere (ironia della sorte, siamo alla vigilia della morte di Stalin e degli sconquassi che ne deriveranno in tutta la galassia della sinistra mondiale in seguito alla pubblicazione del rapporto-Kruscev). Ora, io credo che Lethem, figlio di attivisti, cresciuto in una specie di comune a Brooklyn, una lontana parente che davvero abitò nei Sunnyside Gardens, sappia di cosa sta parlando. Come l’autore ha dichiarato in una bella intervista rilasciata a Livia Manera: “In fondo non sono mai stato un grande animale politico. Eppure è come se dentro di me scorresse sempre una corrente critica rispetto alla cultura americana”.
Jonathan Lethem, I giardini dei dissidenti, Bompiani, 2014.
Edizione originale: Dissident Gardens, Doubleday-Random House, 2013.












