Ottanta anni fa, nella notte tra il 9 e il 10 luglio 1943, ebbe inizio l’operazione Husky, lo sbarco anglo-americano in Sicilia durante la seconda guerra mondiale. L’attacco diretto degli Alleati all’Italia, “il ventre molle dell’Asse” nazi-fascista, secondo la definizione del premier britannico Winston Churchill, fu un successo. Questa azione militare ha da tempo dato adito a ipotesi di intese segrete tra l’intelligence statunitense e la mafia per spiegare il rapido sfaldamento di due delle quattro divisioni delle forze armate italiane dislocate in Sicilia, l’Aosta e l’Asietta, i cui fanti sarebbero in larga misura quasi scomparsi nel nulla. Secondo la tesi elaborata nel 1962 dal giornalista e saggista Michele Pantaleone (Mafia e politica, 1943-1962, Torino, Einaudi), anticipata in articoli pubblicati sul quotidiano L’Ora di Palermo alcuni anni prima, i soldati siciliani di tali divisioni, pari a oltre i due terzi dei loro effettivi, avrebbero abbandonato la linea del fronte, lasciando il campo libero all’avanzata delle truppe anglo-statunitensi, perché avrebbero capitolato alle minacce di mafiosi agli ordini del boss Calogero Vizzini in applicazione di un presunto accordo tra il boss newyorkese Salvatore Lucania, più noto come Charles “Lucky” Luciano, e i servizi segreti di Washington.
L’ipotesi di Pantaleone ha goduto di una vasta diffusione e ha trovato un’eco perfino nella cultura popolare con il film In guerra per amore (2016), diretto da Pif (Pierfrancesco Diliberto). Tuttavia, non tiene conto della strenua resistenza offerta dalle altre due divisioni di stanza in Sicilia, la Livorno e la Napoli, quest’ultima composta per oltre metà da soldati siciliani, insensibili alle intimidazioni che avrebbero invece condizionato il comportamento dei commilitoni dell’Aosta e dell’Asietta. Né prende in considerazione la possibilità che i militari si fossero più semplicemente dati alla macchia per aver maturato la convinzione dell’inutilità di proseguire un conflitto impari in nome di un regime ormai largamente screditato che sarebbe crollato di là a poche settimane.
Lo storico Salvatore Lupo, autorevole esperto della mafia italiana e delle sue ramificazioni transatlantiche, approfitta dell’ottantesimo anniversario dell’invasione della Sicilia per ripercorrere queste vicende e per sostenere che l’idea di una collaborazione tra la mafia e l’intelligence statunitense per consegnare l’isola alle forze anglo-americane sarebbe nient’altro che una leggenda. Il volume che ha appena dato alle stampe, Il mito del grande complotto. Gli americani, la mafia e lo sbarco in Sicilia del 1943, Roma, Donzelli, pp. 102, reitera in maniera più circostanziata quanto lo stesso Lupo aveva sostenuto in lavori precedenti sulla criminalità organizzata isolana e sulle sue diramazioni statunitensi, contraddistinti da una prospettiva di più ampio respiro e da una periodizzazione maggiormente estesa (Quando la mafia trovò l’America. Storia di un intreccio intercontinentale, 1888-2008, Torino, Einaudi, 2009, pp. 124-131, 138-154; La mafia. Centosessant’anni di storia, Roma, Donzelli, 2018, pp. 181-199).
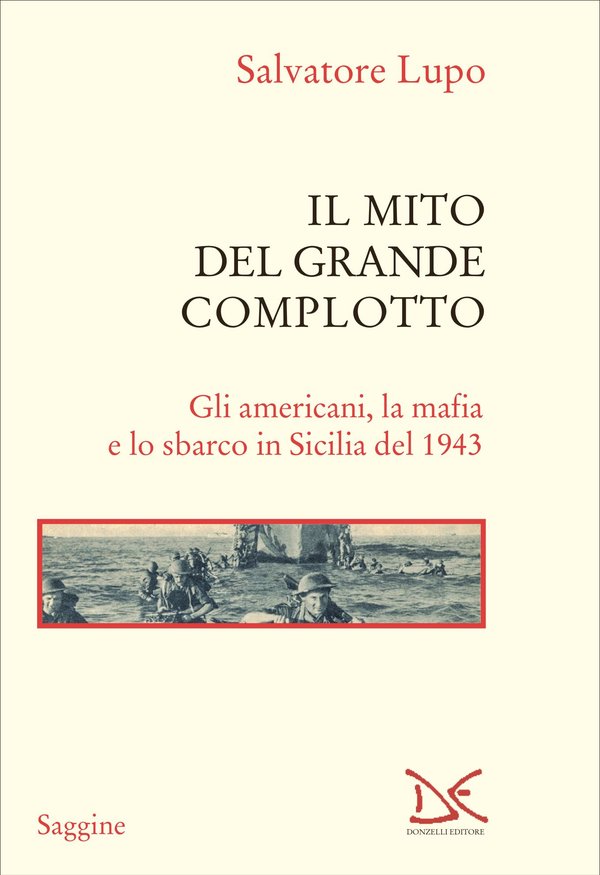 Lupo non si limita a ribadire che non esistono prove documentarie dell’ipotetico accordo che, pertanto, rimarrebbe basato su mere illazioni non verificabili. Attingendo soprattutto a fonti archivistiche italiane e statunitensi, nonché a un’analisi critica della memorialistica esistente e delle relazioni di commissioni d’inchiesta di entrambi i Paesi, confuta anche in modo sistematico i capisaldi di questa tesi. In particolare, sebbene colpita dalle iniziative repressive del prefetto Cesare Mori tra il 1924 e il 1929, la mafia – come risulta da rapporto redatto dalle autorità di polizia nel 1938 – non era certo stata messa all’angolo dal fascismo. Verrebbe, pertanto, meno la premessa che avrebbe spinto Vizzini a prestarsi agli obiettivi dei servizi statunitensi, cioè la necessità di rilanciare la presenza mafiosa sull’isola sfruttando gli invasori. Inoltre, il lavoro di intelligence per l’operazione Husky fu gestito soprattutto dai britannici e non da Washington né avrebbe potuto verificarsi un abboccamento tra l’esponente politico italo-americano Charles Poletti – futuro governatore militare dell’isola dopo l’occupazione alleata – e i mafiosi siciliani nel 1942. Da un lato, in quell’anno, Poletti era vicegovernatore dello Stato di New York e non avrebbe certo potuto compiere un viaggio segreto in Sicilia per imbastire una trattativa. Dall’altro, nel 1942, gli Alleati non avevano ancora programmato uno sbarco in Italia perché la sua pianificazione risale alla Conferenza di Casablanca, svoltasi tra il 14 e il 24 gennaio 1943.
Lupo non si limita a ribadire che non esistono prove documentarie dell’ipotetico accordo che, pertanto, rimarrebbe basato su mere illazioni non verificabili. Attingendo soprattutto a fonti archivistiche italiane e statunitensi, nonché a un’analisi critica della memorialistica esistente e delle relazioni di commissioni d’inchiesta di entrambi i Paesi, confuta anche in modo sistematico i capisaldi di questa tesi. In particolare, sebbene colpita dalle iniziative repressive del prefetto Cesare Mori tra il 1924 e il 1929, la mafia – come risulta da rapporto redatto dalle autorità di polizia nel 1938 – non era certo stata messa all’angolo dal fascismo. Verrebbe, pertanto, meno la premessa che avrebbe spinto Vizzini a prestarsi agli obiettivi dei servizi statunitensi, cioè la necessità di rilanciare la presenza mafiosa sull’isola sfruttando gli invasori. Inoltre, il lavoro di intelligence per l’operazione Husky fu gestito soprattutto dai britannici e non da Washington né avrebbe potuto verificarsi un abboccamento tra l’esponente politico italo-americano Charles Poletti – futuro governatore militare dell’isola dopo l’occupazione alleata – e i mafiosi siciliani nel 1942. Da un lato, in quell’anno, Poletti era vicegovernatore dello Stato di New York e non avrebbe certo potuto compiere un viaggio segreto in Sicilia per imbastire una trattativa. Dall’altro, nel 1942, gli Alleati non avevano ancora programmato uno sbarco in Italia perché la sua pianificazione risale alla Conferenza di Casablanca, svoltasi tra il 14 e il 24 gennaio 1943.
Lupo derubrica gli accordi tra mafia e autorità statunitensi a un patto informale dell’intelligence della marina con Luciano nel 1942 riguardante esclusivamente il fronte interno, come già asserito da Rodney Campbell (The Luciano Project. The Secret Wartime Collaboration of the Mafia and the U.S. Navy, New York, McGraw-Hill, 1977). Il boss, in carcere dal 1936 per sfruttamento della prostituzione, mobilitò gli scaricatori di porto newyorkesi, controllati dalla criminalità organizzata locale, per prevenire sabotaggi tedeschi ai danni delle navi da guerra ormeggiate nel porto della città. Tale timore era emerso dopo l’incendio scoppiato sulla Normandie il 9 febbraio 1942, sebbene fosse stato probabilmente appiccato dagli stessi uomini di Luciano per spingere l’intelligence a rivolgersi al capomafia. In cambio, nel 1946, Luciano ottenne una commutazione della pena che gli permise la scarcerazione, ancorché bilanciata con la deportazione in Italia poiché non aveva conseguito la cittadinanza statunitense dopo essere immigrato negli Stati Uniti.

Lupo riconosce l’esistenza di rapporti tra l’amministrazione militare alleata della Sicilia e la mafia, per esempio nell’ambito del mercato nero, e richiama connivenze tra gli occupanti e il movimento indipendentista infiltrato dalle cosche. Ma ridimensiona questi fenomeni come un inevitabile intreccio tra qualunque governo dell’isola e la malavita che ha caratterizzato la storia siciliana. Inoltre, colloca le collusioni tra Washington e la mafia nel periodo successivo – e non precedente – allo sbarco anglo-americano.
Il mito del grande complotto è un libro d’occasione, con un titolo a effetto, e non aggiunge molto ai precedenti contributi, soprattutto dello stesso Lupo, per confutare la teoria di un’alleanza tra la mafia e l’intelligence statunitense allo scopo di preparare l’operazione Husky. Tuttavia, la scrittura agile, l’estensione contenuta della trattazione e il tono divulgativo, nonostante il rigore scientifico, serviranno ad arginare il sensazionalismo delle letture complottistiche dell’invasione della Sicilia presso un pubblico di lettori ben più ampio di quello degli specialisti, già a conoscenza di tali questioni e dei loro risvolti.











