La cinepresa imbracciata da antropologi ed etnografi non è cosa recente: per documentare le loro osservazioni sul campo, sin dalla nascita della pellicola cinematografica, decine di studiosi se ne servirono per arricchire le proprie ricerche senza però possedere conoscenze tecniche. Col trascorrere degli anni poi, la cosiddetta cinematografia etnografica si è sviluppata coniugando da una parte la ricerca e dall’altra le modalità espressive del documentario, potenziatesi a loro volta col progresso della tecnologia audiovisiva. Nel 2015, la nascita in Italia della prima (e unica) Scuola di Cinema Documentario Etnografico a Monselice, in provincia di Padova, ha rappresentato un avvenimento importante e necessario per gli studi dell’antropologia visuale nel nostro paese. Questa realtà eccezionale nel panorama italiano, ideata dall’antropologo e documentarista Fabio Gemo, ha preso vita dopo più di vent’anni di passione, ricerca e lavoro svolti da Gemo e dal Centro Studi sull’Etnodramma (da lui fondato nel 1995) in collaborazione con diverse università italiane e straniere nell’ambito della ricerca antropologica.
“Negli anni ‘80 ho scoperto l’antropologia visuale – racconta Fabio Gemo – grazie a una straordinaria congiuntura di docenti che si trovavano allora all’Università di Padova: Antonio Marazzi, Paolo Palmeri e Gualtiero Harrison. Poco dopo, sempre Padova ospitò il primo incontro internazionale di Antropologia visiva in Italia, era l’estate del 1988 e io a quei tempi ero ancora uno studente. Nonostante la mia giovane età, fu una rivelazione per me scoprire il mondo della documentaristica etnografica e da quel momento non ho più smesso di occuparmene. Negli anni a seguire cercai una scuola di cinema che potesse darmi gli strumenti per dedicarmi a questa settore dell’antropologia ma in Italia non c’era nulla. Ho deciso allora di frequentare Ipotesi Cinema, la scuola di Ermanno Olmi, una scuola di cinema con un taglio molto vicino, per interessi, all’antropologia, e successivamente mi sono diplomato anche all’Accademia Regionale di Teatro. Ho iniziato poi a fare ricerca all’estero, soprattutto in Messico, dove ho lavorato per quasi quindici anni e, sempre in Messico ho fondato l’ ALER Asociacion Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Quest’associazione organizza da molti anni il Congreso Latinoamericano de Religion y Etnicidad. Nel 1998 mi trovavo a Buenos Aires per il Congresso e si stava decidendo la prossima località nella quale organizzare l’edizione del 2000. Proposi, assieme al prof. Paolo Giuriati, di portare il congresso a Padova, e l’idea fu accolta: finalmente un congresso così importante giungeva in Europa! In quella occasione il comune di Monselice ospitò due sezioni particolari, una dedicata al rapporto tra Teatro e Antropologia e una sull’ Antropologia Visuale. Passato il congresso decisi di rendere permanenti queste due sezioni”.
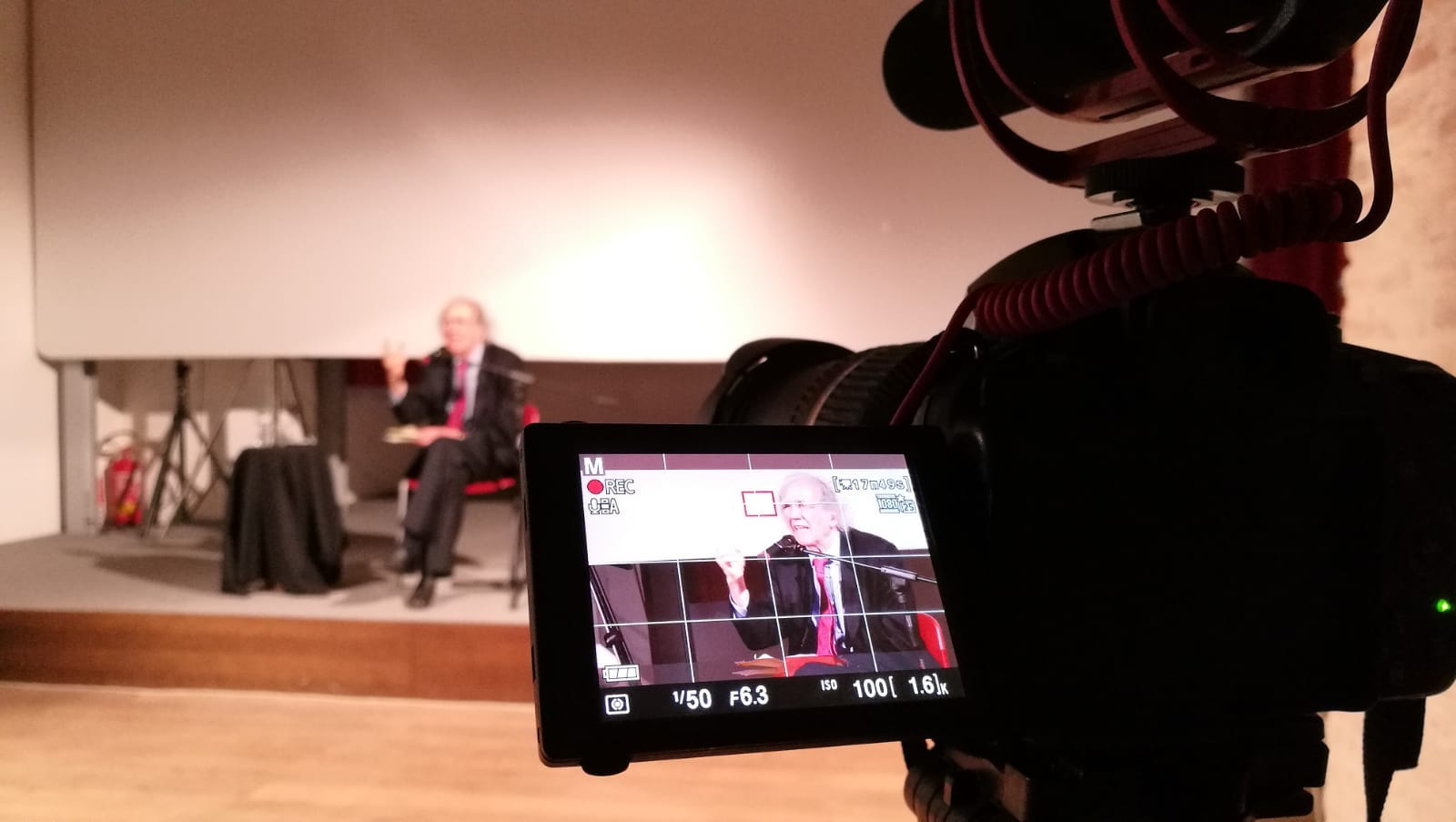
Dopo anni di intenso lavoro all’estero, Fabio Gemo era ormai pronto a porre le basi in Italia per tutta una serie di progetti sull’antropologia visuale, ancora assenti nel nostro paese . I tempi erano maturi e Gemo desiderava colmare una lacuna oramai pesante per l’Italia, nella didattica del documentario etnografico. Una doppia sfida se si pensa che Fabio ha deciso di realizzare concretamente i suoi progetti in un comune di poco più di 15.000 abitanti. Proprio a Monselice infatti, a distanza di qualche anno, sono nati l’ ETNOFILMfest, mostra del cinema documentario etnografico e, qualche tempo dopo, la Scuola ETNOFILM.
“Per ciò che riguarda l’ETNOFILMfest – spiega Fabio Gemo – siamo giunti ormai alla dodicesima edizione. Il nostro è un festival unico nel panorama nazionale, poiché nato con l’obiettivo di dare spazio e voce a chi produce documentaristica di interesse antropologico in Italia. Un’impresa di certo non facile ma che, con l’aiuto di figure quali Luigi Di Gianni (deceduto purtroppo da pochi mesi) siamo riusciti a far crescere nel corso degli anni. La scelta di localizzare sia il Festival che la Scuola a Monselice è stata una grande sfida. Monselice è il luogo dove sono nato e ho sempre ritenuto che non necessariamente si debbano organizzare eventi di valore e di prestigio nelle grandi città. Il contenitore del Festival cerca di creare un incrocio tra antropologia e cinema, attraverso diversi apporti culturali di diverse discipline in un dialogo virtuoso, poiché credo che come non si fa cinema con il cinema, o letteratura con la letteratura così non si fa documentario solo con il documentario”.

In occasione del Festival , Monselice ha ospitato in questi anni personalità molto importanti legate al mondo del documentario e della cultura come Vittorino Andreoli, Cecilia Mangini, Alejandro Jodorowski, solo per citarne alcuni; purtroppo quest’anno, a causa di consistenti tagli ai contributi economici, l’ETNOFILMfest è in cerca di una nuova collocazione territoriale; non c’è ancora nulla di ufficiale, vista la situazione attuale, ma le due località papabili sarebbero Roma o Venezia. Quel che è certo è che il Festival non si fermerà. La Scuola di Cinema Documentario Etnografico, nata invece cinque anni fa per formare chi desidera apprendere le tecniche e il linguaggio del documentario antropologico, è una realtà altrettanto eccezionale che dal 2015 ha diplomato già più di cinquanta allievi, giunti a Monselice da ogni regione italiana: si tratta di studenti con formazione universitaria per la maggiore proveniente dagli ambiti sociologico e antropologico.
“La scuola è strutturata in formula “week end” – prosegue Fabio Gemo- per rendere più agevole la frequenza anche per chi lavora o vive in una regione diversa dal Veneto. L’obiettivo è quello di offrire agli studenti gli strumenti necessari per poter produrre un documentario etnografico, dalla progettazione al suo confezionamento finale. Oltre alle lezioni programmate, organizziamo di frequente incontri e seminari con antropologi e documentaristi che hanno contribuito e contribuiscono in modo significativo alla produzione di documentari, Gianfranco Pannone, Renato Morelli, Paul Hockings, Francesco De Melis, Antonio Marazzi e molti altri. Oggi nelle diverse università italiane iniziano a esserci cattedre di antropologia visuale, ma quello che manca è il momento pratico, la conoscenza profonda della strumentazione e delle procedure per essere in grado di produrre un documentario. Dal 2018 è abbiamo stipulato una convenzione con l’INAH, il braccio operativo del Ministero della Cultura del Messico e questa convenzione ci permetterà nei prossimi anni di attivare un Master in collaborazione con le università di Città del Messico e di Merida nello Yucatan. Purtroppo l’ antropologia visuale in Italia non vive una situazione brillante, nonostante la crescente attenzione e diffusione di una tecnologia sofisticata che oggi è alla portata di tutti. Il fatto è che tutta la disciplina dell’antropologia in Italia, con le dovute eccezioni, risente di una situazione anomala, nella quale spesso l’antropologo arriva dagli ambiti di studio più diversi, senza possedere una reale e profonda competenza della disciplina. L’anomalia per il settore antropologico, anche questa con le dovute eccezioni, nel nostro paese riguarda anche la sfera della ricerca ed è un vero peccato. “
L’emergenza Covid-19 ha condizionato purtroppo l’anno di studi 2019/2020 che comunque sarà completato come di consueto in giugno; per l’anno 2020/2021 il termine per le iscrizioni scadrà ai primi di settembre, mentre dal 2021 la scuola ETNOFILM darà la possibilità agli interessati di seguire anche solo alcuni moduli del corso. Le attività del comparto culturale (non solo italiano) in questo momento soffrono in maniera particolare, e continuare a progettare risulta probabilmente l’unica maniera per non rendere vani anni di lavoro, di ricerca, di creatività, di partecipazione attiva.
“Per il futuro abbiamo in mente di creare TAR – conclude Fabio Gemo – il Teatro ad Alto Rischio, un gruppo di produzione tra teatro e antropologia che non sia solo momento di spettacolo ma occasione necessaria, vista dalla prospettiva dello spettatore partecipante. Del resto ho sempre ritenuto il teatro una forma di antropologia applicata. Stiamo inoltre lavorando a un festival dedicato all’universo sonoro, dimensione che ci avvolge e ci forma fin dalla nascita. Il sonoro poi, nell’ambito della documentaristica è da sempre ritenuto funzionale all’immagine. Ci sembra una sfida intrigante , vogliamo ridare centralità al sonoro e trovare nuove formule che lo rendano fruibile e interessante anche per il grande pubblico”.












