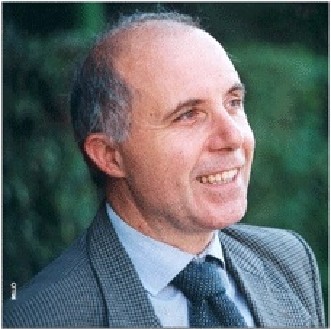Mezzo secolo fa, il 27 settembre 1962, Hailé Selassié dichiara che l’Eritrea, 121.300 km2 di Corno d’Africa affacciati sul mar Rosso, è parte dell’Etiopia e l’annette al suo impero, violando l’autonomia di cui Asmara gode, per decisione Onu, nella federazione con Addis Abeba.
Dal Cairo, dove sono esiliati i suoi capi, il Fronte di liberazione eritreo, Fle, chiama all’indipendenza, iniziando la lotta con il Negus armato dagli Stati Uniti. Negli anni ’70 gli indipendentisti si sarebbero divisi su base ideologica ed etnica, lasciando prevalere la nuova organizzazione Fple di orientamento marxista. Il colpo di stato del 1974 contro l’imperatore e il passaggio di Addis Abeba nel campo sovietico, avrebbero tolto al Fronte popolare di liberazione eritreo l’appoggio di Mosca, favorendo la ripresa del controllo etiope su gran parte del territorio eritreo, specie nelle zone di pianura. La svolta delle operazioni si registra alla metà degli anni ’80, con l’alleanza di Fple e Tplf, Fronte popolare di liberazione del Tigray. Nel 1991 termina la sanguinaria ditta dittatura del Derg e di Menghistu. Il referendum degli eritrei, sotto sorveglianza Onu, dà più del 99% dei consensi all’indipendenza, dichiarata nel maggio 1993. Ad Addis Abeba comanderà, sino alla prematura scomparsa lo scorso agosto, il leader del fronte del Tigray, Meles Zenawi. All’Asmara si installa Isaias Afewerki, che è ancora là. Quei due compagni d’arme, che ebbi modo di conoscere personalmente, all’interno del programma di cooperazione internazionale di cui fu protagonista l’Italia e la società torinese Soges, sarebbero tornati a combattere nel 1998, stavolta uno contro l’altro, per una banale questione di confine.
Tra i più miserandi al mondo, i loro paesi, nel frattempo sottomessi a misure repressive delle libertà personali e di opinione, sarebbero stati trascinati in un conflitto senza senso, costato la vita a decine di migliaia di povera gente. E dire che, durante quel soggiorno italiano, a Zenawi e Afewerki, nel clima di informalità e cameratismo che da bravi militari si piccavano di garantire, avevo posto la questione della degenerazione autoritaria e guerrafondaia di ogni vicenda di liberazione nazionale in terra d’Africa, auspicando che almeno loro ne fossero esenti. Mano nella mano i due leader avevano deliziato i presenti raccontando di quando venivano a Napoli a comprare le divise “Milano” per le loro armate e di quanto tenessero allo sviluppo dei loro popoli nel segno dell’amicizia bilaterale e della cooperazione internazionale.
L’Italia ha particolari responsabilità verso l’Eritrea, la cui vicenda nazionale inizia, nella modernità, con la costituzione nel 1890 della Colonia d’Eritrea, così chiamata dal capo del governo Francesco Crispi perché il nome evocasse il mare sul quale affacciano le sue coste: “erythros”, in greco, significa rosso.
Nel paese hanno tuttora un buon ricordo di noi. Ti dicono che gli abbiamo lasciato tutto al contrario degli inglesi che hanno portato via il poco che avevano installato.
C’è ancora la ferrovia italiana, e il centro di Asmara appare una città italiana trapiantata in Africa, dove fanno bella mostra ville coloniali e monumenti architettonici come la stazione di servizio, in stile futurista, “Fiat Tagliero” del 1938. Sopravvive il ricordo degli Ascari, volontari aggregati alle nostre forze armate. Ad Adua, nel 1896, ne morirono quattromila e chi fu fatto prigioniero patì torture e menomazioni indescrivibili. Mussolini li inquadrò tra i regolari, contro l’Etiopia nel 1935.