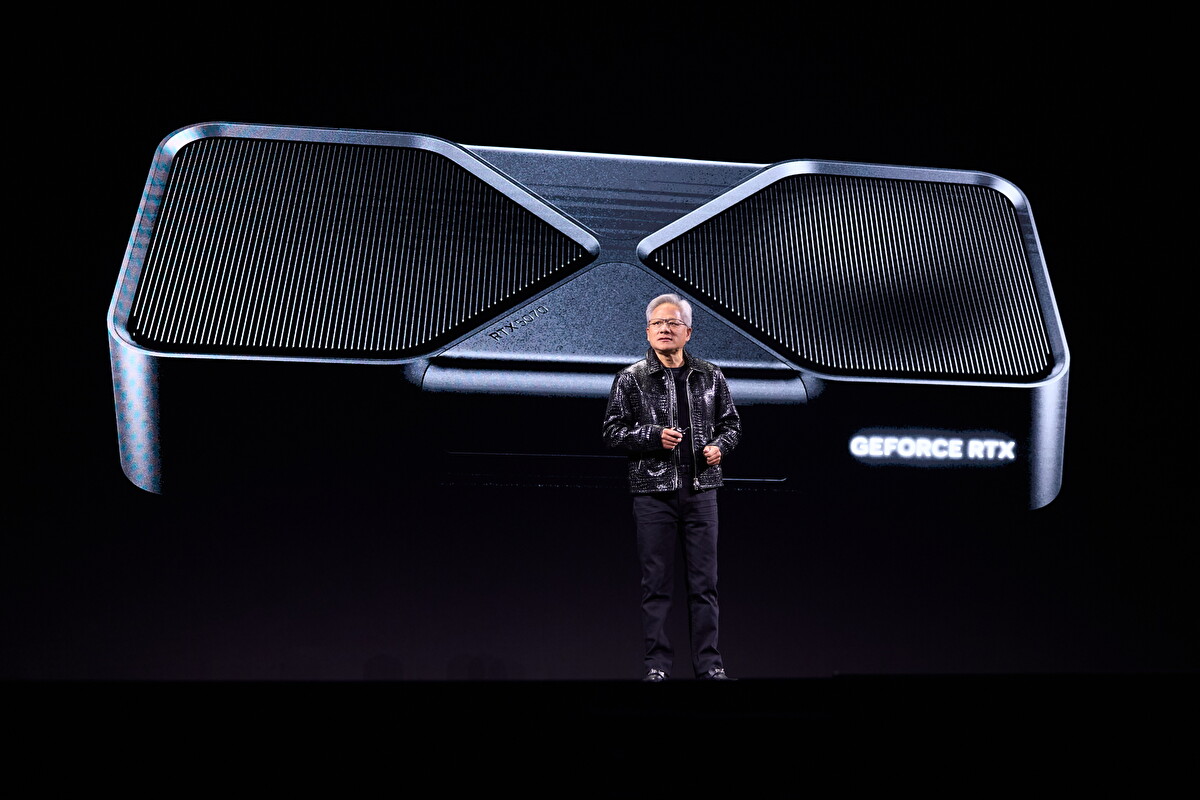Claudio Magris (in foto) è una delle glorie della cultura italiana contemporanea. Attraverso la sua ventina di libri prodotti ha investigato
il mondo mittleuropeo e il rapporto dell’Italia con esso. Ha tradotto Ibsen, Kleist, Schnitzler ed ha scandagliato a fondo le loro opere dedicate alla conoscenza dell’uomo europeo. E’ titolare della cattedra di lingua e letteratura tedesca all’Università di Torino ed è professore alla Facoltà di Filosofia e Lettere all’Università di Trieste.
Un curriculum del genere lo colloca nel novero degli uomini di cui l’Italia può essere fiera e fra i cultori degli studi "alti". Ma il suo ultimo libro, dal titolo "Ambiguità italiane. Note civili", è decisamente insolito, come se sia stato "strappato" alla sua attività consueta e spinto a fissare il suo sguardo su ciò che è diventata questa povera, triste, ridicola Italia, ormai etichettata come "lo zimbello del mondo".
La sua avventura è quella di esaminare ciò che è accaduto nel povero Stivale e perché sia scomparso il rapporto fra la trasgressione e lo scandalo, che un tempo erano uno la causa e l’altro l’effetto, mentre ora sembra che abbiano smarito la loro collocazione nella logica. "Improvvisamente – spiega in un’intervista del giornale La Stampa – è accaduto qualcosa di indecente. Ormai può succedere che il capo del governo dica tranquillamente che si possono non pagare le tasse (che come se un questore dicesse che si può rubare). E il fatto che certe cose siano possibili spiazza le regole e crea un pendent nella crisi della logica: nessuno quasi più ragiona con una logica che una volta sembrava elementare. E non possiamo ignorare il problema di cosa sia accaduto nella testa delle persone, perché poi ogni ragionameno logico elementare non funziona, non fa presa, non ha alcun potere di convinzione".
L’intervistatore sembra molto impressionato da queta specie di scomparsa della logica che rischia di far saltare perfino la possibilità di capirsi l’un l’altro e decide di scaricare il suo timore senza giri di parole.
Non è spaventato dalla crisi della logica?
"Certamente", risponde Magris. "Mi spaventa moltisimo perché in questo modo tutto diventa possibile. Il problema della sintassi, del rispetto nominativo e dell’accusativo, non è soltanto un problema di filologia riservato agli esteti della lingua. Il problema è che se uno uccide un altro è indispensabile sapere chi è il soggetto e chi è l’oggetto per capire che è l’assassino, altrimenti finiamo per metere in galera la vittima".
Claudio Magris è un "signore" e non vuole fare esempi terra terra. Ma è evidente che lo stravolgimento della logica è dovuto proprio alle cose "indecenti" che escono e hanno continuato per anni a uscire – dalla bocca di Silvio Berlusconi. Lui, naturalmente, se ne infischia della salvaguardia della logica, un po’ per il proprio, bassissimo livello culturale che sfoggia quando racconta le sue barzellette da caserma e un po’ perché il suo bisogno essenziale è che lui e i magistrati vengano percepiti come duellanti sullo stesso piano. Il massimo, per lui, è che lo sforzo della giustizia contro i reati da lui commessi venga ridotto al livello di "Guardie e ladri", un antico gioco da bambini e anche un famoso film in cui Totò e Aldo Fabrizi si ritrovano a "interagire", tanto che finiscono per non capire più chi è da quale parte.
Ad aiutarlo in questa confusione c’è il controllo che Berlusconi ha dei mezzi di comunicazione (per dire: il Telegiornale di Augusto Minzolini, a proposito di indecenza) e il devastante alfabetismo di ritorno che ha investito come un vento di pestilenza una buona parte della popolazione italiana, finita fra le risate idiote delle barzellette e e cerimonie in omaggio al "Dio Po". A vederle, il fatto di esserne geograficamente lontani, e quindi "fuoriusciti", è sempre una bella consolazione.