Giovanna Miceli Jeffries è nata a Ribera (AG), in Sicilia, dove è cresciuta e ha terminato la scuola superiore prima di emigrare negli USA. È professore emerito dell’Università del Wisconsin-Madison e negli ultimi 25 anni è stata la direttrice del programma italiano presso l’Italian Workmen’s Club of Madison. Giovanna ha scritto e presentato varie relazioni in sede accademica per lo studio e la riflessione che esplorano l’esperienza italo-americana, la migrazione mediterranea e le diaspore italiane. È l’autrice di numerosi libri, articoli, capitoli di libri sulla letteratura, sulla cultura, e di pedagogia italiana contemporanea. È anche la co-traduttrice di Casalinghitudine dal titolo “Keeping House”.
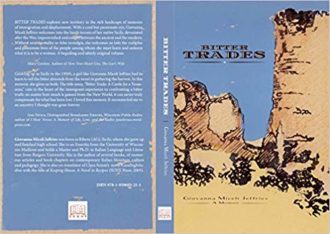 Il libro “Bitter Trades” è strutturato in 13 storie/capitoli, ognuno con un titolo e un tema distinto da leggere singolarmente come storie che raccontano l’esperienza di crescita ed emigrazione. Sono storie piene di passione, onestà, ed umorismo. Un libro che narra cosa significa crescere in Sicilia in una comunità agricola poco scolarizzata, paralizzata dalla guerra e nella povertà del dopoguerra. Una Sicilia abbandonata dal flusso emigratorio nell’America del Sud, nel Canada e negli USA. E nonostante l’isola sia stata sempre una terra ricca di storia, di bellezza, e circondata da un paesaggio mediterraneo da sogno, l’autrice mette in rilievo la cultura siciliana patriarcale, dove si cresceva nella sottomissione, nella paura, e sotto l’autorità paterna, descrivendo anche la lealtà e la devozione del cammino di una donna che si vuole migliorare anche attraverso l’immigrazione, il dislocamento e l’istruzione oltre i confini culturali della Sicilia e dell’Italia.
Il libro “Bitter Trades” è strutturato in 13 storie/capitoli, ognuno con un titolo e un tema distinto da leggere singolarmente come storie che raccontano l’esperienza di crescita ed emigrazione. Sono storie piene di passione, onestà, ed umorismo. Un libro che narra cosa significa crescere in Sicilia in una comunità agricola poco scolarizzata, paralizzata dalla guerra e nella povertà del dopoguerra. Una Sicilia abbandonata dal flusso emigratorio nell’America del Sud, nel Canada e negli USA. E nonostante l’isola sia stata sempre una terra ricca di storia, di bellezza, e circondata da un paesaggio mediterraneo da sogno, l’autrice mette in rilievo la cultura siciliana patriarcale, dove si cresceva nella sottomissione, nella paura, e sotto l’autorità paterna, descrivendo anche la lealtà e la devozione del cammino di una donna che si vuole migliorare anche attraverso l’immigrazione, il dislocamento e l’istruzione oltre i confini culturali della Sicilia e dell’Italia.
Professoressa, nel suo libro racconta la sua infanzia e la sua adolescenza, perché ha scelto “Bitter Trades” come titolo del suo libro? Qual è il significato?
“Quando si sceglie e ci si decide a narrare la propria vita non è perché, nel mio caso, la consideri straordinaria o la voglia far valorizzare da altri. È perché, dando forma narrativa al contesto delle circostanze, si profila dinnanzi una tela non episodica, aneddotica o melodrammatica. Per me, ricercare e riordinare i contesti di vario ordine (socio-economico, geografico, storico, epocale, antropologico, familiare, e così via), che sottendono le esperienze determinanti che hanno condizionato la mia crescita e maturazione nei tempi e luoghi in cui sono avvenuti, ha rivelato una costante di “trades,” di commerci, di cui avevo, sento, una certa consapevolezza sin da piccola. Scrivendo, ho potuto cogliere e capire le ragioni della loro necessità, sopraffazione, inevitabilità, arbitrarietà, condizionamento. Li sento amari perché hanno generato il senso precoce di subire un’ingiustizia, una sopraffazione, un abuso, una svolta esistenziale, emigrare per esempio. L’aggettivazione è pregna di livelli metaforico-materiali nel senso dello scambio di beni e di possessi veri, gli effetti collaterali di carattere esistenziale, identitario, progettuale, la persistenza della consapevolezza della perdita prodotta da una conoscenza e la valorizzazione di un possesso in qualche caso ignorato, il richiamo alla reificazione saporifica della mandorla, per esempio: tutti questi fili cerco di raccogliere nel mito greco di Phillis a conclusione del capitolo che dà il titolo al libro. La realizzazione della problematicità del baratto non è sopraffatta dall’amaro, perché non tutto si perde senza contraccambi e si nutre di piccole e grandi conquiste”.
Metà dei 13 racconti sono ancorati in Sicilia e l’altra metà narra l’esperienza di procurarsi il pane e crearsi un futuro migliore con lo studio e l’ambizione in Canada e negli USA. Possiamo definire il suo libro una riflessione sulla vita degli immigrati italiani nei diversi ambienti americani e canadesi e sulla vita siciliana del passato?
“Indubbiamente. L’esperienza migratoria è alla base del memoir, per essere stata una realtà di prima e di poi. Mio padre visse dieci anni in Venezuela, come decine di migliaia di uomini che partirono soli, durante la mia infanzia e adolescenza, e negli anni della guerra fredda e dei giochi opportunistici perpetrati dalla DC e dal PCI nel mio paese con case ancora squarciate dai bombardamenti americani, una comunità agricola pochissimo scolarizzata, oppressa dall’emigrazione e paralizzata dall’ansia di un’altra guerra. Nel memoir cerco di riappropriarmi e dare voce alla bambina, all’adolescente e alla donna che esamina ed elabora la memoria e, come ho detto, contestualizza sia il fenomeno migratorio locale con le sue pratiche di vita e i cambiamenti generatisi nell’esistenza e vita sociale soprattutto delle case “senza uomo”– gestite da “vedove bianche”, quasi una cultura a se stante – sia la cultura materiale, i rituali di crescita nella Sicilia fra gli anni Cinquanta e Sessanta. Come si cresce, appunto, sotto l’angoscia della guerra fredda; come spiegarsi e gestire l’apprensione generata da un’epidemia di apparizioni della Vergine a ragazze adolescenti locali; come interpretare il lascito inquietante e suggestivo di un bisnonno che si fa appena in tempo a conoscere, le cui gesta di coraggio, generosità e saggezza vengono annoverate dalle innumerevoli narrative dei familiari e imparate a memoria–“l’uomo d’onore”– a cui non venne mai accostata la parola mafia? La mia esperienza migratoria personale in Nord America nell’arco di tempo che narro, in particolare dal 1965 agli anni Ottanta, mi permette di vivere ed osservare realtà ambientali che non potevo prevedere: il lavoro in fabbrica e l’incontro con la geografia umana dell’Italia meridionale – io non ero mai uscita dalla Sicilia – nella sua diversità, e soprattutto il relazionarsi a un lavoro manuale, la discriminazione e arbitrarietà dei capireparto, la vulnerabilità e vergogna, l’ossessiva ansietà di perdere il lavoro, la realtà contrastante delle comunità italiane, che da una parte, danno ossigeno, saldano e generano solidarietà e un senso di identità, e contemporaneamente congelano costumi, abitudini, valori nell’iperidentificazione con la lealtà familiare, che, per forza maggiore, non vanno a passo con la cultura d’origine e perciò diventano acque stagnanti, sorgenti di conflitti e amarezze nei rapporti intergenerazionali (soggetti della stessa migrazione)”.
Le 13 storie/capitoli aiutano il lettore a capire i sacrifici fatti dagli immigrati italiani?
“Senza dubbio. L’abnegazione, il lavoro, le delusioni e i rimpianti, soprattutto la tenacia nutrita di speranza”.
Capire il passato degli immigrati americani e leggere le opere scritte da studiosi italoamericani potrebbe essere utile all’Italia che ora si trova a dover fronteggiare problemi politici legati all’immigrazione?
“Non c’è costante più universale nella storia umana e animale della migrazione; anche se non se ne fa esperienza individuale, è difficile non essere completamente immuni dalle sue ripercussioni, fosse solo la semplice conoscenza e coscienza degli “altri” che, l’esperienza, la subiscono. Ricordo perfettamente quando si è cominciata a usare l’espressione “l’Italia da paese di emigranti a paese di immigrati.” Un riflusso vichiano, ma per la vastità dell’emigrazione italiana che arriva eventualmente anche a casa via cinema, TV, canzoni popolari, prodotti, valuta straniera, ecc., mai assente nell’ultimo secolo in particolare dalla consapevolezza collettiva. La politicizzazione del fenomeno migratorio che investe l’Italia da un pezzo può avere l’effetto di distanziare e oggettivare la realtà, ma non di poterla negare, rifiutare facilmente. Per ogni migrante che s’incontra per le strade italiane, ci sarà almeno un emigrante nella storia personale, familiare, sociale di chi ne registra la presenza. I paralleli fra le turbe di emigranti italiani che si riversavano nei porti della costa orientale dell’America e quelle clandestine che, quando ce la fanno, si trascinano per le spiagge dell’Italia del sud sono storia, non cronaca”.

Professoressa Miceli-Jeffries, quale avversità personale e percezione identitaria affrontava nel nuovo mondo l’emigrazione della sua generazione?
“La mia generazione, in particolare quella femminile non ancora emancipata e cosciente del femminismo sia italiano che internazionale, subiva principalmente il trauma dello sradicamento a un’età, la meno desiderabile fra le possibili indesiderabili ma con potenziale di più facile adattamento, tipo bambini o adulti maturi con potere decisionale. Bisogna considerare un’adolescente o tardo-adolescente, o anche una giovane ventenne, parzialmente e in buona parte scolarizzata, perfettamente o in gran parte integrata, funzionale e contenta nel proprio ambiente, con qualche sogno e ambizione, articolata nella propria lingua e catapultarla, senza proprio concorso decisionale, in un ambiente estraneo, straniero, negli anni Sessanta per esempio, dove, tranne che nell’ambito familiare ed etnico, si troverà a balbettare invece di parlare, a non capire quello che le stanno dicendo, a non poter condividere con amici sin dai tempi dell’infanzia turbamenti, paure e ansietà, che viene a perdere, tranne la propria famiglia che, nella maggioranza dei casi non può se non seguire, i punti di referenza della propria identità come percepita e filtrata dalla comunità in cui è vissuta e valorizzata, per meriti, singolarità, doti, ecc. Non sentivo niente di avventuroso nella prospettiva di emigrare; anzi, ne avevo vergogna perché significava marginalità, proiettava povertà e relegava nelle schiere dell’esodo erodendo anche quel fragile senso di sé che si è coltivato nel proprio ambiente. Ecco, questi sentimenti precisi di vergogna non mi sembra vengano esaminati sufficientemente in altri memoir che centrano sull’esperienza migratoria. La sequela celebratoria del successo e la retorica dell’American Dream, quando si verificano, che risarciscono non possono minimizzare o alleggerire quell’esperienza di perdita e isolamento”.
Sul fenomeno dello scrittore che scrive in italiano mentre vive fuori d’Italia quali differenze si notano in un’opera scritta da un saggista che vive negli Stati Uniti e una da un letterato che vive e scrive in Italia?
“Apprezzo la domanda, che richiederebbe una discussione approfondita ed estesa. Cercherò di sintetizzare. Da tenere conto che gli italianisti in Nord America sono di tre tipi: i laureati italiani, e in alcuni casi con pratica di ricerca e scrittura critica pre-migratoria, un buon numero di loro anglisti come formazione; italianisti della mia generazione, anche loro di madrelingua scolarizzati fino ad un certo punto; italianisti non di madrelingua, molti di origine italo-americana, ma con notevole padronanza della lingua. Ognuno di questi, e sto generalizzando, si relaziona al testo e alla lingua in maniera diversa e diversamente assorbe e ricicla la pratica critica teorica e retorica del mainstream americano e di lingue e letterature occidentali. Le differenze anche superficiali si avvertono nella lingua, articolazione, enfasi sulla teoria nordamericana e francese. La lingua è un organismo vivente esposto a temporalità e spazialità, pratica e tradizioni. La saggistica di studiosi italiani che scrivono in Italia, siano anche scrittori narratori di professione, si articola e dipana in una lingua e perspicacia critica con agile ed elegante naturalezza e insieme una certa domestica ricercatezza.Per la controparte che vive, opera e scrive in italiano all’estero ci saranno sempre fattori che localizzano e ibridizzano la scrittura e la lingua che, se non sempre o consistentemente agili ed eleganti, hanno una certa carica di freschezza e potenziale energia”.
Professoressa Miceli-Jeffries quale è stata la sua iniziale avventura letteraria? E quali sono stati per Lei gli ostacoli o le sfide maggiori da superare nel mondo accademico?
“Scrivere un libro su Italo Svevo, che ho pubblicato in Italia tre decadi fa, per l’immensa attrazione che questo scrittore esercitava su di me per una tematica che non era stata affrontata sul rapporto letteratura e lavoro e la dialettica inerente. Svevo affronta e letteraturizza, come dice lui, la vita, che, nel suo caso, è fortemente contrassegnata dal lavoro, e non lo evade, anzi produce una sua specifica e unica poetica. Le sfide maggiori, nel mio caso personale, credo siano state generate dalla mia esitazione a flettermi di fronte alle opportunità accademiche di spostarmi dalla sede e dall’ambiente in cui preferivo vivere e crescere le mie figlie e dove c’era comunque un buon dipartimento di italianistica. Ho dovuto adattarmi, mi sono resa conto che, nonostante la validità della meritocrazia, in cui credo fermamente, il mio output di studiosa con pubblicazioni regolari, il mio aggiornamento glottodidattico e pedagogico nell’insegnamento di una lingua seconda non sono visti d’entrata automatica se l’ingranaggio non gira dalla propria parte. Ogni tanto teorizzo che il mio accento siculo e l’inglese esitante abbiano avuto la loro parte”.
Come giustifica la grande mancanza di voci femminili nella critica letteraria italiana americana?
“Non direi “grande mancanza.” Spero di interpretare correttamente la sua domanda. Forse bisogna fare delle distinzioni. Innanzitutto, c’ è una presenza non insignificante di critica letteraria firmata da italiane americane, accademiche che insegnano in varie e prestigiose università americane, specialiste in letteratura inglese e americana, alcune delle quali hanno scritto e scrivono anche sull’esperienza generazionale italiana americana. Da Sandra Gilbert a Louise De Salvo, Edvidge Giunta, Donna Garbaccia, Marianna De Marchi Torgovnick, Helen Barolini, Mary Jo Bono, Rita Ciresi, Dorothy Bryant, per fare alcuni nomi. C’è anche un numero di italianiste di origine italo-americana ben affermate negli studi e nella critica della letteratura italiana, da Joann Cavallo, a Teodolinda Barolini, Carol Lazzaro-Weis, a Lucia Birnbaum, in numero minore sia rispetto al primo gruppo che alla controparte maschile. Una ragione abbastanza plausibile dello scompenso nella rappresentanza femminile e maschile fra autori italiani americani è da ricercarsi nella cultura patriarcale delle famiglie che storicamente subordinava l’istruzione delle figlie a quella dei figli maschi, così come dappertutto nel resto delle comunità etniche americane e nel resto del pianeta”.












