John Fante nasce nel 1909 nella fredda Denver, in Colorado, primo di quattro figli; suo padre, Nicola Fante, è un muratore di origine abruzzese, mentre la madre, casalinga cattolicissima, ha genitori lucani. Se la sua infanzia non è tra le più serene, altrettanto si può dire della sua vita adulta e della sua tormentata carriera di scrittore: trasferitosi in California poco più che ventenne, benché già conscio della propria vocazione letteraria, è costretto a lavorare come lavapiatti, fattorino d'albergo e operaio in una fabbrica di scatolame per pesce pur di riuscire a mantenersi. Negli anni '30 viene pubblicato il suo primo racconto The Altar Boy (in italiano Il Chierichetto) e in questo stesso periodo conosce la sua futura moglie, Joyce Smart, una tra le prime donne a essersi laureate alla Stanford University. I genitori di lei, ricchi proprietari terrieri anglosassoni, non vedono di buon occhio l'unione, ma i due decidono comunque di sposarsi, in segreto, a Reno, in Nevada.
L'esordio letterario di Fante avviene nel 1938 con la pubblicazione di Wait until Spring, Bandini, romanzo pervaso da una vitalità senza precedenti e, allo stesso tempo, da una rabbia travolgente. Questo sentimento accompagna inesorabilmente lo scrittore stesso per via del mancato riconoscimento delle sue opere, tanto che uno dei suoi quattro figli in un'intervista dichiara che l'umore del padre oscilla puntualmente tra due stati d'animo: “da leggermente incazzato a parecchio incazzato”.
 Lo stile degli scritti fanteschi viene definito dirty realism, quasi che vi fosse un modo più lindo e asettico per descrivere le brutture quotidiane della vita degli emigrati italiani. Fante di certo non ha paura di sporcarsi le mani, né di invischiare i suoi lettori nelle ragnatele della miseria in cui versano i suoi personaggi. La materia a cui attinge non è altro che la sua stessa esistenza, difficile e turbolenta, piena di insuccessi, rifiuti e amarezze. Ma combattuta sempre, fino alla fine.
Lo stile degli scritti fanteschi viene definito dirty realism, quasi che vi fosse un modo più lindo e asettico per descrivere le brutture quotidiane della vita degli emigrati italiani. Fante di certo non ha paura di sporcarsi le mani, né di invischiare i suoi lettori nelle ragnatele della miseria in cui versano i suoi personaggi. La materia a cui attinge non è altro che la sua stessa esistenza, difficile e turbolenta, piena di insuccessi, rifiuti e amarezze. Ma combattuta sempre, fino alla fine.
L'importanza delle sue opere è stata trascurata molto a lungo. Negli Stati Uniti Fante diviene noto al grande pubblico solo per intercessione di Charles Bukowski che di lui disse: “Era il mio Dio”, arrivando persino a minacciare il suo editore di non consegnare il manoscritto per il suo nuovo romanzo, pur di spingere per la ripubblicazione delle opere di Fante. In Italia poi, i suoi libri vengono quasi del tutto ignorati fino al 1992, quando si decide di rispolverarli sull'onda della riscoperta americana.
A livello storico l'opera di Fante costituisce un'importante testimonianza sulle condizioni degli emigrati italiani dei primi decenni del '900 e il suo testo di debutto Aspetta primavera, Bandini, tradotto da Elio Vittorini nel 1941, è particolarmente significativo poiché in esso compaiono tutti gli italianissimi personaggi della vita dello scrittore: tra le imprecazioni di un padre che lotta contro i fastidi della miseria e i tormenti di una madre devota.
Il primo nemico di Svevo Bandini, personaggio che nel libro è il ritratto di Nicola Fante, è la neve. Quel manto bianco che ricopre il Colorado, sin dalle prime pagine gli penetra nelle scarpe “rattoppate con dei pezzi di cartone di una scatola di pasta” e risulta tanto più odioso perché lo priva del sostentamento: “niente sole, niente lavoro”.

Una famiglia italiana a Ellis Island (Fonte: wikisource.org)
Il (co)protagonista però è un giovane Fante che “si chiamava Arturo, ma avrebbe preferito chiamarsi John. Di cognome faceva Bandini, ma avrebbe preferito chiamarsi Jones. Suo padre e sua madre erano italiani ma lui avrebbe preferito essere americano. Suo padre faceva il muratore ma lui avrebbe preferito diventare il battitore della squadra di baseball dei Chicago Cubs”. Ma i Bandini non sono solo degli italiani qualsiasi tra i tanti stabilitisi in America, loro rappresentano l'Italianità incarnata. Perché Fante non ha paura degli stereotipi ed attinge proprio ad essi per raccontare una realtà che non gli si discosta poi di molto: così, se Svevo Bandini è sanguigno, rumoroso, collerico, bestemmiatore provetto, rigorosamente baffuto e anche alquanto rozzo, Maria prega costantemente per la salvezza dei figli e del marito, appesa al rosario bianchissimo che è la sua unica ancora di salvezza per non annegare nella disperazione.
Le scene del libro si sviluppano tra le immense distese di un gelido paesaggio invernale e le mura di una casa ancora da pagare. Qui, se Bandini padre è alle prese con i debiti e i tanti guai di cui si vanta “proprio come dell'accumulo di un'immensa fortuna”, Arturo deve vedersela con i suoi problemi tipicamente adolescenziali a cui si aggiungono “le sue lentiggini, la necessità di un taglio di capelli e le origini italiane”.
La penna di Fante è schietta, sincera, ma al tempo stesso non teme le corde dell'emotività e anzi le lascia vibrare nel lirismo dei suoi personaggi; come quando il giovane Arturo si abbandona ad un pianto disperato “per le mani nodose di suo padre, per i muri costruiti da suo padre, per i gradini, i cornicioni, i cenerai e le cattedrali, tutti bellissimi, per quel che sentiva quando suo padre cantava dell'Italia, del cielo italiano, della baia di Napoli”.
Maria, la madre, è un personaggio delicato, di un candore così limpido che si riflette nella sua pelle talmente bianca che “a guardarla sembrava di vederla attraverso un velo d'olio d'oliva”. Mentre Svevo si considera un americano naturalizzato, lei parla delle “donne americane”: quelle delle riviste patinate, con i loro ferri da stiro elettrici, le lavatrici e le aspirapolvere, e le basta “guardarsi il palmo delle mani, tutte un callo per via dei mastelli di panni da lavare, per rendersi conto di non essere, tutto sommato, una donna americana”.
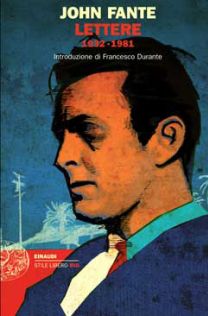 Le emozioni invece, regnano assolute: l'amore incondizionato di Maria per Svevo, quello totale di Arturo per la compagna di scuola Rosa; l'odio per i creditori e per quell'inverno che non vuole finire; la speranza inesauribile di una primavera gravida di promesse.
Le emozioni invece, regnano assolute: l'amore incondizionato di Maria per Svevo, quello totale di Arturo per la compagna di scuola Rosa; l'odio per i creditori e per quell'inverno che non vuole finire; la speranza inesauribile di una primavera gravida di promesse.
Emblematiche le pagine in cui Maria, con il marito lontano da casa da parecchi giorni, si vede costretta ad andare dal salumiere allungando un conto da saldare già chilometrico: il negoziante – che di solito si rivolge ad Arturo chiedendogli “come fate voi bastardi italiani a vivere senza un centesimo” – finge di non vederla, la ignora, spazza la bottega e non le rivolge la parola fino a renderla rossa di vergogna, esausta e profondamente umiliata.
Anche Svevo non viene risparmiato dalla crudeltà del classismo quando viene chiamato “contadino ignorante”, e ancora “animale”; ma l'italianità per lui non è motivo di vergogna e anzi, spesso il personaggio si abbandona a fantasticherie sulle sue origini abruzzesi, lui, italiano puro “di una stirpe contadina che si perdeva nella notte dei tempi”. Bandini padre, che a volte si culla parlando tra sé e sé con dolcezza nel suo idioma natio, è un uomo profondamente disgustato dalla povertà ed è questo sentimento, reso più amaro dall'inverno, che lo spinge ad intessere una relazione con una ricca vedova di Rocklin, affacciandosi ad uno splendore tutto precario.
Intanto il giovane Fante-Arturo Bandini è combattuto dal senso di colpa per le marachelle commesse, la tristezza per la situazione familiare e l'amore per l'italianissima Rosa. Tutto l'intreccio narrativo si dipana nel periodo natalizio e l'unica soluzione, come suggerisce il solo compagno di scuola che ami il baseball tanto quanto Arturo, è quella di aspettare: “Aspetta Primavera, Bandini”.
Insomma, gli italo-americani di Fante sono personaggi turbolenti, forestieri che se ne vanno in giro sempre sporchi, con le unghie nere. Stranieri non diversi dai loro cani, come tiene a sottolineare la ricca vedova Hildegarde. Ma a dispetto dell'inverno, dei piedi gelati, i conti da pagare, le ingiustizie e i peccati a cui rimediare, i Bandini sono attaccati alla vita con unghie e denti. Ed è per questo che non si stancano di aspettare primavera. Personaggi resi forti dalla durezza della fame e carichi di quella spinta a risalire che solo chi ha conosciuto i bassi fondi possiede; proprio come Fante stesso, che non si arrese nemmeno davanti alla cecità e all'amputazione di entrambe le gambe a cui lo portò una grave forma di diabete, e che continuò a dettare alla moglie la sua prosa stracolma di vita, fino alla morte.
Dopo la pubblicazione delle Lettere (Einaudi) del 2014, si ripresenta l'occasione di leggere e rileggere un autore che dovrebbe essere consigliato in tutte le scuole, e non solo, per non dimenticare una storia di emigrazione, che è la nostra. E per comprendere quella dei tanti forestieri che approdano in America così come in Italia, carichi di un'identica fame, ma anche della stessa speranza: quella che arrivi primavera.











