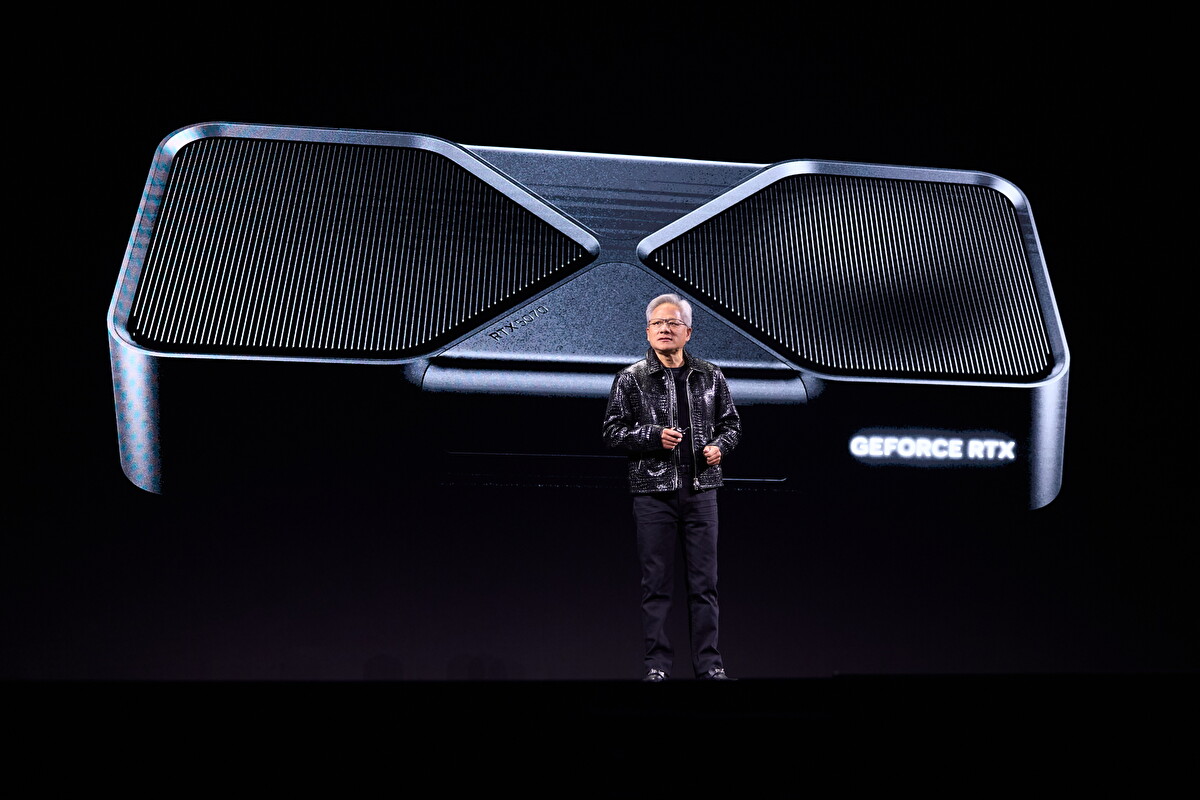La lettura dell’intervista di Liliana Rosano a Maria Laurino apparsa su La VOCE di New York, mi ha colpito, mi ha fatto un bell’effetto: mi ha assorbito per un’ora abbondante poiché il testo ho voluto leggerlo due volte e con la calma, la lentezza, la concentrazione che esso meritava, che merita.
L’articolo-intervista firmato dalla signora Liliana Rosano, e le risposte, le spiegazioni fornite dalla signora Laurino hanno toccato all’istante le corde del mio temperamento, che è temperamento assai italiano, e assai toscano; com’è del resto ‘assai milanese’ il temperamento d’un milanese; ‘assai siciliano’ il temperamento d’un siciliano e così via.
La discussione sull’opera di Maria Laurino, “The Italian-Americans”, mi ha riportato indietro di una trentina d’anni, ha risvegliato in me ricordi che s’erano appisolati, ne ha resi altri ancor più nitidi di quanto già non fossero.
Arrivai una prima volta negli Stati Uniti, a New York per l’esattezza, il 29 dicembre 1977, vi rimasi fino al 14 febbraio 1988: tornai definitivamente in patria il 4 agosto 1988 – e al mio rientro a Firenze nel cuore della notte, e nell’aria che pareva seta, esultai. Ero riapprodato in Italia! Ero riapprodato in Europa. Avevo rimesso piede nella mia città natale. Roma, Napoli, Firenze, Londra, Parigi m’erano mancate da morire: a tratti la loro lontananza quasi mi procurava un malessere fisico; di sicuro nervoso. I toscani nascono “impazienti”… I toscani amano la rapidità d’esecuzione; i toscani non sono formali, rispettano molto volentieri consuetudini, usi, abitudini; tutto quello, insomma, che attraverso le generazioni è stato ben collaudato. Ma formali, no, non sono.
Arrivai in America che avevo 31 anni suonati, di primo pelo quindi non ero. Avevo i miei gusti, i miei orientamenti. Mi ero formato fra Firenze, Roma, Londra, il Casentino, il Sannio molisano. Venivo da una famiglia la quale aveva girato il mondo, sia per lavoro che per diletto; ero nato a quindici minuti di tram da Santa Maria del Fiore… Da Santa Maria Novella, da Piazza della Signoria, dalla Loggia dei Lanzi, da Palazzo Riccardi, dal Ponte Vecchio, dal Porcellino, da Lungarno Acciaioli… Venivo da un mondo in cui quasi su tutto si eccepiva con ‘sommo gusto’, meno che su quanto di più intimo possa manifestarsi nell’animo di un essere umano. Da bravo fiorentino con un bel po’ di sangue sia casentinese che molisano, ero (e sono) tanto lapidario, sbrigativo, quanto attento, comprensivo.
Ma il giorno dopo il mio arrivo a New York, capii che fra me e l’America non avrebbe funzionato… Eravamo incompatibili! Non potevano esserci punti in comune. Ricordo d’aver pensato già in quei giorni ai molisani che da bambino vedevo partire alla volta dell’America, del Canada, dell’Australia: compresi ancora meglio il senso di spiazzamento che all’epoca della mia infanzia e della mia adolescenza, prendeva i lavoratori molisani che arrivavano negli Stati Uniti e venivano, sì, colti d’infilata dallo smarrimento culturale, ‘estetico’: dallo smarrimento dinanzi all’uniformità architettonica, alla “povertà” architettonica, loro che in senso atavico erano abituati alla pietra: alle case in pietra; al tufo, alla lava pietrificata.
L’uniformità… L’uniformità che, in un solo abbraccio, stringe a sé – in modo assai gelido ai miei occhi – New York, Fildadelfia, Pittsburg, Cleveland e così via. T’inoltri nel New Jersey e t’accorgi che l’aspetto di Hackensack, Hoboken, Emerson, Oradell, è lo stesso. Implacabilmente lo stesso… La protesta si levò fiera e imperiosa in me il giorno di febbraio o marzo del 1978, in cui in Park Avenue notai un edificio imitazione del Quattrocento fiorentino! Per me non si trattò di un omaggio a Firenze, ma d’un insulto al Rinascimento fiorentino: nulla di più triste, di più freddo e impersonale delle imitazioni. Ma l’America era fatta, è fatta, anche così. Nulla di male se ci se ne accorgesse e si cambiasse allora indirizzo… Ma mi pare che 99 americani su 100 non se ne rendano conto. Hanno cose ben più importanti cui pensare? Certo: devono pensare ad allargare gli orizzonti della Scienza, aprire nuove frontiere per Medicina e Chirurgia. Ma poi succede che per pagarti un’operazione chirurgica, e con tanto di prolungata degenza ospedaliera, tu debba vendere la casa nell’ameno, lindo sobborgo. Per i repubblicani, per gli eredi di Ronald Reagan e Jesse Helms, in questo non c’è proprio nulla di male… Ricordate lo slogan con cui Reagan si presentò alle elezioni presidenziali del 1980? “There’s no such thing as a free meal”! Ah no? E come fa a tirare avanti, a campare dignitosamente, uno che con le proprie forze, e pur mettendocela tutta, da solo non ce la fa? Dovrà pur esserci qualcuno che se ne prende cura: lo Stato. Sissignori, lo Stato, meglio ancora se hegeliano…!
Al giornale in cui lavoravo, “Il Progresso Italo-Americano”, venivano di volta in volta sindacalisti i quali ci esortavano ad accettare aumenti di salario che equivalevano a elemosina, vera elemosina, in base alla quale avremmo perfino dovuto ringraziare con amore e devozione il padrone che si mostrava così munifico… Il mio spirito socialista si scontrò subito con l’America capitalista, con l’America delle “grandi opportunità”. Per me erano appunto ‘troppo moderati’ i democratici stessi. Figuriamoci… Il mio punto di vista poggiava su queste considerazioni, delle quali discorrevo in coffee-shops o nel corso di festicciole in case private: l’America è un Paese ricco, ricchissimo, poiché il suo sottosuolo abbonda in materie prime, le sue pianure si prestano all’agricoltura come poche altre al mondo; i suoi corsi d’acqua sono di portata straordinaria, qualcosa che ti toglie il fiato; i suoi boschi appaiono sterminati, i suoi mari sono fra i più pescosi al mondo; questo Paese sarebbe quindi in grado d’assicurare un tenore di vita almeno decente a tutti i suoi figli disposti a lavorare sodo, anche a migliorare se stessi; allora com’è che questo non è possibile? Dov’e il vizio, il vizio d’origine? Dove?! Esso c’è. Chi, allora, ne conserva la natura “perpetua”? Ricordo signori e signore che non sapevano rispondermi. Mi guardavano interdetti, interdette; a volta irritati, irritate, come se fossi piovuto dalla Luna…
In cerca di un posto di lavoro grazie al quale poter vivere decorosamente, fra il gennaio e l’aprile del 1978 scrissi non so quante lettere a giornali, case editrici, altre aziende. Credevo che, almeno in questo, gli Americani fossero come gli Inglesi; che, cioè, rispondessero alle lettere di lavoro che ricevevano: non ottenni invece alcuna risposta, salvo quella di un tedesco, Eric Besser, che a Massapequa Park dirigeva un settimanale calcistico, appunto, “Soccer Week”. Sì, a rispondermi fu soltanto un tedesco.
Nei miei dieci anni a New York, legai “soltanto” con neri, israeliani, e con un signore classe 1920 o 1921, Kenneth Renfrew, anglosassone proveniente dalla Virginia. Gli altri… Gli altri fingevano simpatia nei miei confronti. Fingevano d’interessarsi alla mia persona, all’italiano, al fiorentino, al giornalista. Pur istruiti, si meravigliavano… Si meravigliavano del mio accento “English, Public School”! Poi, in meno di tre o quattro minuti, la conversazione prima languiva, in pochi attimi moriva. Io non interessavo loro, loro non interessavano me. Un abisso ci separava.
V’erano scene ricorrenti alle quali non feci mai l’abitudine: non c’era modo di farcela. Eccoci quindi ai cappotti e alla giacche a vento. M’accorsi alla svelta che a indossare cappotti, cappotti di lana pura, ben tagliati, erano banchieri, dirigenti d’azienda, avvocati, chirurghi, magistrati. Erano altri a portare giacche a vento: camionisti, muratori, elettricisti, portieri, negozianti e così via. Era quindi questo il mondo del Futuro? Era questa l’America egalitaria?! A me sembrava “Ancien Règime”… Rammentavo operai toscani e operai inglesi andare in giro nei loro cappotti pesanti, accoglienti, specie la domenica.
Gli italo-americani. Ne conobbi parecchi. Ne conobbi di geniali, come l’avvocato Gene Crescenzi, che soldi da clienti poco abbienti nemmeno ne voleva: era fatto così. Aveva uno studio, in Lexington Avenue, se ben ricordo fra la 50ma e la 79ma; ma più che uno studio, era uno studiolo, perciò angusto, con pochissima luce naturale. Era nato poco dopo la Grande Guerra a New York da genitori italiani, in Italia era stato una prima volta a venti o ventun anni. Eppure era italiano! Lo era nella fertilità mentale, nel senso estetico, nell’educazione innata, ancestrale; nella duttilità di studioso di Diritto, di studioso del Rinascimento. Indifferente alla ricchezza materiale, quindi avulso dal lusso, dallo sfarzo, abitava con la moglie, franco-americana, socievole, aggraziata, in un appartamento di tre stanze affacciato sull’East River. Scriveva in un Inglese, sissignori, alla Dickens, alla Forster. Diceva che, per far trionfare la loro “causa”, gli italo-americani dovevano smetterla di “fare le vittime”: dovevano lanciare, eccome, “una solenne controffensiva”, attenti, però, a non scadere nel velleitarismo. Un uomo fuori dal comune, Gene Crescenzi. Un uomo e uno spirito liberi. Uno addirittura inconsapevole del proprio, poliedrico talento. Faceva tenerezza.
Gene Crescenzi e altri come lui, “giganti”, giganti dinanzi ai carrieristi partitocratici, ai conformisti, ai falsi ribelli che a quell’epoca, anni Ottanta, insieme a donne ambiziose, rumorose, ingombranti, gremivano – e con sussiego, con protervia – gli uffici della Rai Corporation, 1350 Avenue of the Americas, o scaldavano le seggiole della redazione locale dell’ANSA…
Che cosa è cambiato da allora per gli italoamericani e per gli italiani d’America? Non saprei. E’ dal 1988 che non rimetto piede negli Stati Uniti che a me, tuttavia, dietro una apparente mobilità (ma mi potrei sbagliare), sembrano immutabili, mummificati, almeno nelle “istanze” avanzate dai repubblicani… Agli italoamericani suggerirei di non puntare più di tanto su spaghetti, salse di pomodoro, pizze; ma di mandare in campo Virgilio, Tito Livio, Dante, Beccaria (sì, Beccaria, il nemico acerrimo della pena di morte), Pirandello, i Medici, il Rinascimento, lo stesso Futurismo, il “newyorchese” Prezzolini.
Come mi disse nel 1979 Maristella Lorch, direttrice della Casa Italiana della Columbia University, “basta, basta con quest’Italia che sembra fatta di sole scarpe, di sola pastasciutta”!