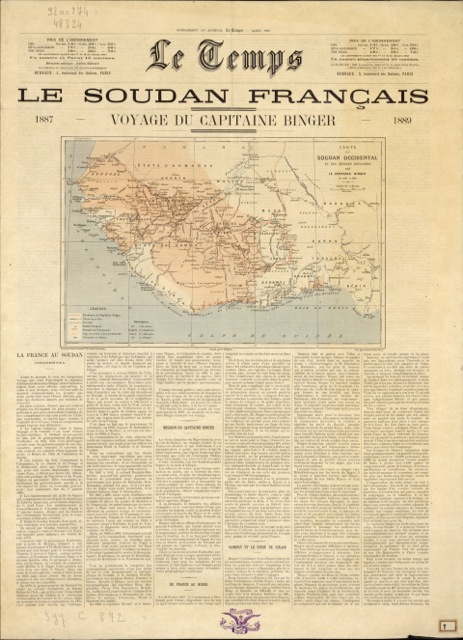Le elezioni presidenziali del 28 luglio in Mali sembrano un avvenimento lontano e di scarso rilievo. Al di fuori della Francia, e dei paesi africani confinanti, ben pochi sono interessati a quanto sta succedendo nell’ex Sudan francese che, come l’ex Sudan britannico, segna fisicamente la frontiera tra Africa bianca e Africa nera.
Eppure, le elezioni in Mali dovrebbero suonarci familiari, almeno perché, come in Grecia, in Portogallo o in Italia, a nessuno interessa chi le vincerà. Chiunque vinca, il suo compito si limiterà a mettere in atto i dettami imposti da altri. Come direbbe Mario Draghi, anche in Mali c’è il “pilota automatico”.
Uno dei 27 candidati, Tiébélé Dramé, si è ritirato dalla corsa denunciando un «processo elettorale messo in piedi alla bell’e meglio e condotto in modo autistico». Anche tra coloro che hanno sostenuto fino all’ultimo minuto la necessità di rispettare la data del 28 luglio, molti non si nascondono il reale stato delle cose: i certificati elettorali non sono pronti per tutti, e in alcune città del nord si vota in un clima di stato d’assedio e di occupazione militare nemica. Eppure, the show must go on.
La ragione la si ritrova in una frase pronunciata a marzo dal capo di Stato francese in un’intervista televisiva: «Noi vogliamo che ci siano delle elezioni in Mali alla fine di luglio. E su questo saremo intrattabili». Un diktat che presenta un problema di metodo e un problema di merito.
Il metodo. Qualche anno fa, alcuni commentatori ipersensibili definirono una “ingerenza inammissibile” una copertina dell’Economist in cui si dichiarava “inadatto” un certo candidato al ruolo di capo del governo in Italia. A marzo, non la redazione di un giornale si è espressa, ma un capo dello Stato. Non un giudizio di merito su tale o tal altro candidato è stato fornito, ma un calendario elettorale. Da un punto di vista formale è come se Obama esigesse delle elezioni in Canada entro una certa data, e si dichiarasse “intrattabile” sul rispetto delle scadenze.
Ma, si dirà, il Mali non è il Canada, e i rapporti tra Stati Uniti e Canada non sono quelli tra Francia e Mali. Appunto. E qui entriamo nel merito. La Francia è intervenuta militarmente all’inizio di quest’anno per – secondo la motivazione ufficiale – fermare i “jihadisti” al potere nel nord che puntavano verso la capitale Bamako. I francesi volevano, come gli americani in Irak, “fermare il terrorismo” e “riportare la democrazia”.
Ricordiamo di sfuggita che quando gli americani andarono in Irak, la Francia guidò il movimento mondiale di protesta, esprimendo riserve e ironie sull’esportazione della democrazia sulla punta delle baionette. Ricordiamo anche che l’amore per la democrazia della Francia è molto selettivo: intenso, quando ad imporla sono i francesi, come in Costa d’Avorio e in Libia due anni fa; scarso quando la impongono gli americani; nullo quando la democrazia premia elettoralmente i partiti non particolarmente amici della Francia, come in Algeria nel 1992, o più recentemente in Tunisia e in Egitto.
Le motivazioni geopolitiche sono molto meno glamorous di quelle impregnate di spirito missionario. Però sono più utili per capire quel che succede realmente. In Africa, la Francia sta giocando la sua ultima partita geopolitica. E la sta giocando con una determinazione che contagia persino François Hollande, perché l’area francofona (ex colonie francesi e belghe) è sotto assedio su parecchi fronti. Tra i vari attori di questo nuovo Scramble for Africa vi sono anche giovani potenze locali molto ambiziose – l’Algeria, la Nigeria, l’Uganda, il Kenya, il Sudafrica, per citarne alcune – che si aggiungono ai pretendenti esterni, in primo luogo la Cina, ma anche gli Stati Uniti, il Brasile, l’India, l’Arabia Saudita e il Qatar. Siccome l’era coloniale è finita, ogni paese africano è teoricamente libero di avere rapporti con chi gli pare; il problema è che in ogni paese, esistono tanti poteri quante sono le sue ricchezze, e ciascun potere, all’interno di ogni paese, ha una sua propria politica estera e, spesso, un suo proprio esercito.
Da qui l’esigenza “intrattabile” di eleggere al più presto un solo capo in Mali, di costringere il paese all’unificazione, manu militari, se necessario. Un’unificazione che, però, non può durare che fino al giorno in cui un miglior offerente bussa alla porta di servizio. E trova invariabilmente qualcuno disposto ad aprirgli.
In Costa d’Avorio, in Libia e in Mali, la Francia ha giocato non sulla superiorità dei suoi principi, ma sulla superiorità dei suoi mezzi militari. Certo, gli Stati Uniti e forse la Cina potrebbero soverchiarla, da questo punto di vista; ma per ragioni politiche ancora non possono. In ogni caso, la superiorità militare, da sola, non basta: come dimostrano l’esperienza sovietica in Europa dell’Est e quella americana in Irak e in Afghanistan, è una superiorità la cui data di scadenza è molto più intrattabile di quanto non lo sia François Hollande.