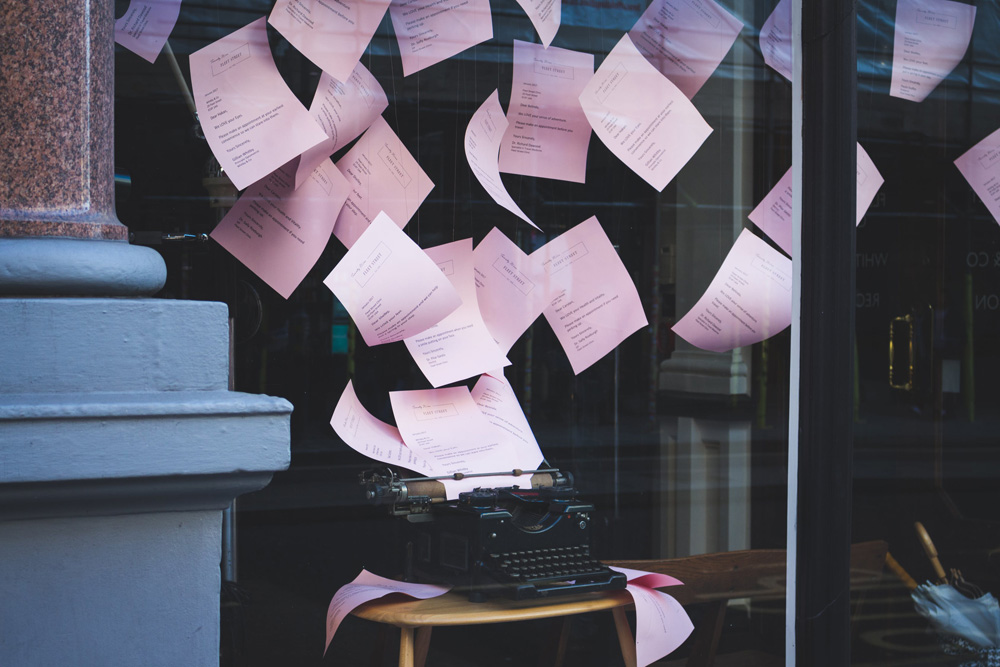News, breaking news, latest news, spot news, developing news, fake news H24 esondano compulsive da testate giornalistiche online, blog, siti web, communities, e rimbalzano febbricitanti su pagine, gruppi e profili di social network. Il lettore 3.0 si informa sui device digitali che, sempre più frequentemente, consegnano alla polis dell’etere parole poco pensate e ancor meno pesate, spesso urlate, il cui scopo non è informare bensì fare promozione o propaganda, se non generare fenomeni e tendenze. Il tutto associato a una TV scostumata, sempre accesa e connessa alle nostre vite, che ‘mostruosizza’ ogni vicenda con un impatto socio-culturale potenzialmente dannoso.
Accade così che il consumatore della notizia usa e getta finisce annegato fra titoli e didascalie, astrusità, citazioni banali, copia/incolla ad libitum, nel vano tentativo di colmare la ‘vuotezza’ intellettuale che entra dai prodotti hi-tech (ma anche low-tech) e che vanifica il lavoro di chi, l’informazione, la fa seriamente.
Un like per esprimere un’opinione
In questo caos comunicativo ed informativo l’analisi critica del lettore onlife diviene sterile, infruttuosa. In pochi si fermano per argomentare un messaggio sul web, sporadicamente ne discutono con l’autore. L’articolo non diventa più strumento di riflessione, ma ricettacolo di ‘mi piace‘ pigiati frettolosamente, oppure di offese gratuite o ‘trollizzate’ ad hoc, in un delirio digitale che azzera il confronto e quindi l’opportunità di crescita.
È chiaro che la società moderna sia affetta da una sorta di bulimia dell’informazione, un terreno sempre più sconnesso per chi è intenzionato a fare un buon Giornalismo, esercitando capacità critica e scongiurando quella che io chiamo ‘obsolescenza mnemonica’, ovvero il rischio di sovraffollare la memoria con concetti volatili senza alcuna possibilità di nutrimento culturale. Perché, se tenere vive le coscienze attraverso l’esercizio del pensiero è la mission di un serio professionista, è pur vero che diventa sempre più ostico svolgere correttamente il proprio lavoro, in un momento in cui l’oggettività della notizia ha lasciato spazio al sensazionalismo mediatico trasformando l’informazione in show e gli show in messaggi informativi. La gente è sedotta dalla molteplicità delle informazioni che riceve: dalla TV che enfatizza la notizia ai social che la mistificano, ai talk show che colonizzano la sfera privata, ai diktat di alcuni giornalisti che si trasformano in divi compiaciuti e compiacenti, fino al continuo ribaltamento delle notizie: tutto e il contrario di tutto.
C’era una volta la TV che mostrava e il giornale che spiegava. Oggi accade il contrario: è la TV che cerca di spiegare la notizia trasformandola in un evento mediatico. Contano i numeri, gli introiti pubblicitari, l’audience. E, soprattutto, la gente vuole storie, non vuole fatti.
Ma il primo dovere morale del giornalista è quello di divulgare criticamente una notizia di interesse pubblico, atta a garantire l’esercizio della sovranità consapevole sancita dall’Art. 1 della Costituzione italiana, evitando di assecondare la morbosità del privato. Va ricordato che in tale ambito il codice deontologico ha introdotto il concetto di essenzialità dell’informazione, nozione tuttavia sconosciuta a chi gioca a fare il Joseph Pulitzer di turno attraverso blog e salotti televisivi o a rincorrere follower e scoop.
Resta dunque un paradosso discutere di etica in un organismo che predilige ascolti. Difficile parlarne, inoltre, quando a livello internazionale una buona parte delle informazioni vengono veicolate attraverso i colossi del web come Google e Facebook.

Eppure in un tempo in cui si fatica a distinguere la verità dalla menzogna e la Conoscenza è sempre più materia di nicchia, il giornalista, oggi più che mai, è chiamato ad essere il testimone affidabile dell’istante storico, un ‘processore umano’ che elabora le informazioni acquisite e le restituisce correttamente al cittadino. In assenza di tale mediazione la notizia rimarrebbe in balìa di logiche algoritmiche che ne determinerebbero la posizione, ma non l’accuratezza dei contenuti sempre più poveri o intenzionalmente manipolati.
La responsabilità di divulgare notizie fedeli alla verità sostanziale dei fatti però non si può attribuire solo all’etica giornalistica. Infinite variabili concorrono alla genuinità di una notizia e, parafrasando Hegel, “non risiedono nel solo pensiero soggettivo ma nella realtà oggettiva”.
Sopravvivere in un ecosistema in bilico tra diritto di cronaca e diritto alla privacy, respingendo la frenesia di rincorrere ad ogni costo i numeri che la comunicazione digitale richiede e, soprattutto, misurarsi con conti e bollette da pagare, è compito arduo. Le testate italiane si reggono in buona parte sul lavoro dei precari che sono costretti a vendersi a cifre improponibili. E il giornalismo precario, si sa, è un giornalismo ricattabile che alimenta, peraltro, quello cosiddetto deprofessionalizzato.
Quanto può essere realmente imparziale la verità di un giornalista, quella ‘stella del Beato Lolo stampata sulla fronte’, se si considera che tutto ciò che scrive passa attraverso il suo background culturale, viene filtrato dalle sue emozioni, vagliato dalla sua esperienza, dalla sua dose quotidiana di cinismo e, non di rado, dalle pressioni di editori che si prostrano ai poteri politici, finanziari ed economici?
Diceva Oriana Fallaci però che “la Storia si scrive sulla verità e non sulle leggende”, pertanto, un giornalista che intenda svolgere con senso morale e critico la sua attività dovrebbe prima di tutto dissentire, disobbedire, essere rivoluzionario. Per dirla col filosofo americano Thoreau, “bisogna essere prima uomini e solo dopo cittadini membri dello Stato, con il diritto di rifiutare l’obbedienza quando contrasta con ciò che la coscienza rifiuta“.
Teorie. Nella pratica resta comunque difficile conciliare questa nobile missione con la propria incolumità. Sono più di mille, purtroppo, i reporter uccisi nell’ultimo decennio mentre lavoravano ad inchieste scomode. E ce ne sono centinaia e centinaia minacciati, querelati, molestati, intimiditi. L’Italia è in cima alla classifica per numero di aggressioni fisiche e verbali a danno di chi fa informazione. Peggiora la situazione un’altissima percentuale di crimini contro i giornalisti che resta impunita, e sappiamo bene quanto questa impunità pregiudichi lo stesso lavoro.
È doveroso quindi che la libertà di Stampa garantita dalla nostra Costituzione torni ad essere oggetto di profonda riflessione collettiva, a sottolineare quanto il lavoro libero dei giornalisti assicuri un presidio irrinunciabile di democrazia in uno Stato di diritto.
Sostenere e difendere con ogni mezzo chi fa corretta informazione nel Paese, deve essere un impegno civile e morale imprescindibile di chi governa, ma anche dello stesso cittadino.
Un cittadino non informato, o informato male, non soltanto è a rischio ma diventa un fantasma, e un popolo fantasma cancella una nazione con tutti i suoi governanti. Uno Stato che protegge l’operato dei giornalisti, pertanto, protegge se stesso.
Una sorta di deterrente sembra stia arrivando dal giornalismo collaborativo, ma non è cosa facile: gli esseri umani sono nati per competere tra loro. Eppure bisogna fare gruppo, senza aspettare che un giornalista muoia per raccoglierne il testimone con le lacrime agli occhi. È necessario che quella solidarietà tra colleghi, tanto calorosamente declamata sulla Carta di Firenze, non resti solo un grumo di belle parole in mezzo a una sequela di bit e bites, ma uno dei principi fondamentali di chi decide di esse quam videri giornalista, un richiamo alla collaborazione effettiva, concreta, hic et nunc, magari con nuove forme di cooperazione.
A giocare da soli non si vince, e spesso si resta ancora più soli.