
Il sito Ethnologue stima che le lingue parlate oggi siano più di 7000, ma in realtà non esiste una risposta definitiva. La cifra oscilla costantemente, tanto per le difficoltà legate alla catalogazione, quanto per la natura delle lingue stesse, entità dinamiche e soggette a continui cambiamenti. Nella città di New York vivono più di 8 milioni e 300 mila abitanti: il 40% di loro sono nati al di fuori degli Stati Uniti. Secondo la Endangered Language Alliance (Ela), organizzazione per la conservazione dei linguaggi, a New York si parlano 800 lingue, di cui molte rischiano di scomparire. I cinque distretti della città: Brooklyn, Manhattan, Staten Island, Queens e Bronx, sono composti da dozzine di quartieri che attirano persone da ogni angolo del mondo.
Il più eterogeneo è il Queens, dove ne convivono ben 138 diverse, ed è più probabile sentire parlare qualcuno Vlashki, variante dell’istrorumeno, che negli sperduti villaggi di montagna che gli immigrati croati di New York hanno lasciato tempo fa. In una chiesa cattolica del Bronx la messa viene celebrata una volta al mese in garifuna, lingua Arawakan dei discendenti degli schiavi africani naufragati nei pressi di St. Vincent nei Caraibi e in seguito esiliati in America centrale. Praticamente il garifuna è diffuso nel Bronx e a Brooklyn quanto in Honduras e Belize. E a Rego Park, Queens, abita Husni Husain, che, per quanto egli ne sappia, è l’unica persona di New York a parlare mamuju, la lingua austronesiana che ha imparato da bambino in Indonesia, nella provincia del Sulawesi occidentale.

Queste lingue non fanno semplicemente parte della Babele di New York, sono idiomi in via di estinzione che, nate in ogni angolo del globo, oggi si sentono più comunemente in varie zone della Grande Mela che altrove. Il problema è che le lingue mutano, si evolvono, si diffondono, e può accadere che questo processo si arresti e che le stesse vadano incontro a un lento declino, arrivando addirittura a estinguersi e a morire. I rischio è particolarmente alto nel caso delle lingue minoritarie, ovvero le lingue parlate da un numero ridotto di persone all’interno di un contesto in cui un’altra figura risulta maggioritaria. Questo è quello che si sta verificando con le lingue di tutto il mondo parlate a New York, oltre a dozzine di lingue degli indiani americani, nella città si parlano infatti lingue a rischio di estinzione come l’ aramaico, il caldico e il mandaico del ceppo semitico; il bukhari (lingua ebraica più parlata a Queens che in Uzbekistan o in Tajikistan); il chamorro (delle isole Mariana); il gaelico irlandese; il cassubiano (parlato in Polonia); lingue indigene messicane; il tedesco della Pennsylvania; il reto-romanico (lingua parlata in Svizzera); romani (lingua balcanica); e lo yiddish.

Proprio per mantenerle vive, Daniel Kaufman, professore associato di Linguistica presso il Graduate Center della City University di New York, ha avviato il progetto Endangered Language Alliance (Alleanza per le lingue in pericolo d’ estinzione) che ha il compito di identificare e registrare le lingue in declino, molte delle quali sono prive di una grammatica scritta, e di incoraggiare i madre lingua a insegnarle ai compatrioti. La caduta in disuso di alcune lingue non costituisce certo una novità, ma il dato che oggi risulta allarmante è la velocità con cui migliaia di idiomi si stanno estinguendo. Il destino di una lingua dipende, da fattori prettamente sociali, politici ed economici. Le lingue non sono entità indipendenti, ma prodotti sociali che vivono nella mente e nella voce dei loro parlanti. La loro fortuna o sfortuna, quindi, è legata dalle vicende del gruppo umano che le utilizza. Una lingua, può sparire anche se le persone che la parlavano rimangono in vita, ma non la trasmettono più ai propri discendenti: in questo caso, si parla di language shift, intendendo con questo termine il processo graduale per cui una comunità di parlanti arriva a sostituire la propria lingua con un’altra. Per capire meglio i processi che portano all’estinzione di una lingua e sopratutto del come si possono tutelare e rivitalizzare abbiamo fatto qualche domanda alla sociolinguistica e accademica Vera Gheno:

Da cosa dipende il destino di una lingua?
“Come insegna il linguista Federico Faloppa nel suo bel libro Brevi lezioni sul linguaggio, le lingue muoiono per mancanza di parlanti e di contesti in cui usarle. Il destino di una lingua, dunque, è ineluttabilmente legato al destino dei suoi parlanti. Per questo è difficile pensare all’italiano come una lingua morente: viene parlato stabilmente non solo da una sessantina di milioni di persone che vivono in Italia, ma anche da numerose persone nel resto del mondo. Rispetto al contesto, posso dire che è un indicatore di cattivo stato di salute di una lingua il fatto che non vi si creino più neologismi: poiché ogni lingua deve rispecchiare la realtà della comunità che la impiega, e tale realtà muta di continuo, una lingua sana è una lingua nella quale si inventano continuamente modi per riferirsi a tali mutamenti”.
È un lavoro meraviglioso quello del linguista, com’è capire come funzionano le lingue del mondo?
“Io penso che ogni lavoro, se fatto con passione, sia molto soddisfacente. Diciamo che studiare la “proprietà nucleare degli esseri umani” (come dice Noam Chomsky), ossia la facoltà del linguaggio, mi permette di capire molte cose su come funzionino le persone, soprattutto nella loro parte relazionale con gli altri esseri umani. La sociolinguistica, da questo punto di vista, è la materia linguistica che ha attratto maggiormente il mio interesse poiché, tramite lo studio dei costumi linguistici, alla fine studia le persone, la loro umanità, la loro capacità di essere, tramite il lόgos, la “specie vivente più aggregata”, secondo le parole di Tullio De Mauro”.
Uno dei possibili ruoli di un linguista consiste proprio nel documentare e registrare lingue a rischio di estinzione. Ogni lingua è degna di essere preservata e protetta, cosa è necessario per mantenerla in vita e continuare a trasmettere il proprio idioma?
“L’unica vera maniera di salvare una lingua è parlarla e trasmetterla ai propri discendenti. Non si può fare molto altro: un linguista può, appunto, documentare e registrare le lingue a rischio di estinzione, ma non può secondo me salvarle. Una lingua può essere aiutata da riconoscimenti ufficiali, per esempio diventando lingua ufficiale di una nazione – o di una sua parte – ma questo serve soprattutto per creare dei contesti per impiegare la lingua, che è, come ho detto poco fa, un fattore importante, ma non l’unico. In altre parole, è difficile preservare una lingua “artificialmente”.

Le interruzioni delle lezioni del 2020 hanno minacciato la perdita di apprendimento per quasi tutti gli studenti nella città di New York, ma il prezzo è stato particolarmente grave per gli quelli che provengono da case di immigrati in cui l’inglese è parlato raramente o mai. Quanto è importante l’insegnamento di una lingua in presenza per l’apprendimento?
“Siccome la competenza linguistica è una competenza fortemente relazionale, non mera conoscenza tecnica, credo che la compresenza incoraggi molto l’apprendimento. In fondo, anche quando dobbiamo acquisire la lingua a livello ontogenetico (nei primi anni di vita), abbiamo bisogno delle persone attorno a noi per “attivare” quelle strutture linguistiche che sono già presenti nel nostro cervello. In assenza di relazione, non si impara nemmeno a parlare. Credo che questo, anche se in maniera non del tutto identica, valga anche nell’apprendimento di lingue seconde. Non basta imparare le coniugazioni, le declinazioni, le reggenze eccetera, bisogna creare i contesti per usare tali competenze”.
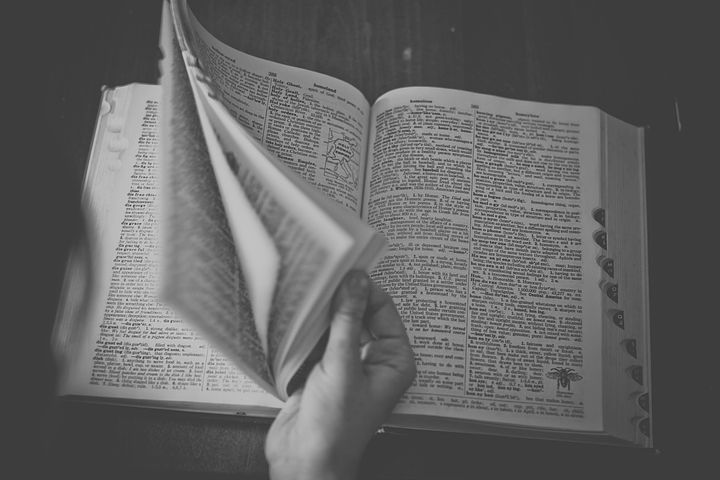
La realtà influenza la lingua, e la lingua influenza il modo di vedere la realtà. Quanto il linguaggio umano si è complicato a causa dei nuovi canali di comunicazione aperti da internet?
“Credo che i linguaggi umani si siano – in maniere diverse – bene o male adattati ai nuovi mezzi, cosa che hanno dovuto fare pena la loro obsolescenza. Casomai, direi che è l’orizzonte cognitivo degli esseri umani a essersi complicato molto. Marshall McLuhan, in “Galassia Gutenberg”, nota questo: «ogni miglioramento nelle comunicazioni aumenta le difficoltà di comprensione». È indubbio che la tecnologia ci abbia dato più modi per comunicare e più facilità nell’accedere alle informazioni… ma il nostro cervello si sta adattando a questo cambiamento progressivamente, forse anche con una certa lentezza”.
Invertire il processo di perdita delle numerose lingue in pericolo d’estinzione, così come si prefigge di fare il progetto avviato dal Professore Kaufman per New York, è realmente possibile?
“Non lo so. Di certo, censirle, preservarne testimonianze scritte e anche parlate, tutte cose che sono possibili grazie anche alle tecnologie che abbiamo oggi a disposizione, fa sì che almeno la loro memoria si possa conservare”.

Le lingue sono tutte davvero diverse o c’è una caratteristica che accomuna la grammatica di tutte?
“Joseph Greenberg è stato il primo, negli anni Sessanta, a parlare di universali linguistici. Ci sono delle caratteristiche che accomunano i linguaggi umani in quanto tali, per esempio l’avere vocali e consonanti, o l’avere i sostantivi o, ancora, prevedere degli avverbi di luogo o certi tipi di vocali e consonati che non mancano in nessuna lingua. Quindi le lingue della Terra sono diverse, certo, ma hanno dei tratti ricorrenti”.
Ogni lingua descrive e narra il mondo in un modo unico e peculiare. Ogni voce che si spegne, ogni mito, racconto o canzone non più tramandati, sono quindi tasselli perduti per sempre dal mosaico della diversità umana?
“Sulla prima parte sono d’accordo. Ancora Faloppa, nel suo libro, ricorda che perdendo una lingua si perde anche la possibilità di comprendere pienamente l’ecosistema in cui quella lingua si era sviluppata ed era usata. Sulla seconda non saprei. Si perde qualcosa, certo, ma magari è inevitabile, visto anche il “rimpicciolimento” del mondo dovuto alla globalizzazione. Forse è una fase di contrazione della diversità linguistica per così dire naturale, vista la situazione. Il che non vuol dire che la dobbiamo accettare pedissequamente: secondo me, il multilinguismo è la strada per la felicità di ogni individuo, per cui, se non altro, possiamo tentare di praticarlo nel nostro piccolo, ad esempio preservando il nostro dialetto o la nostra lingua madre anche se, magari, nel contesto in cui viviamo non servirebbero più”.











