Cari e stimati professori, qual’è il vostro ruolo rispetto alla nostra lingua? Il vostro scopo è semplicemente consigliare come scrivere, oppure pensate di avere il diritto di dire a noi italiani come dovremmo scrivere secondo le vostre dottissime norme grammaticali?
Questa era la domanda centrale che ponevo ai professori della Crusca in un articolo scritto qualche mese fa. La domanda arrivava a completamento di un viaggio durato oltre un anno all’interno della linguistica e della comprensione dei meccanismi che regolano le lingue in generale e la lingua italiana in particolare.
Riepilogando brevemente, per i linguisti esistono due modi di affrontare lo studio delle regole che sottendono ad una lingua: l’approccio descrittivista e quello prescrittivista.
L’approccio descrittivista è quello più “distaccato”, quello che osserva la lingua così com’è usata da un popolo e prova a capire quale modello grammaticale la descriva. Tale modello tornerà utile per consigliare a madrelingua e non come creare frasi in qualche modo standard, ma, al tempo stesso, occorrerà non lasciarsi incantare dal valore di quelle regolette: la lingua, alla fine, la fanno parlanti e scriventi; e se quelli non seguono più le regolette, a necessitare di aggiornamento saranno le regolette, e con loro i modelli arbitrari che i grammatici, da soli o in combutta, si sono inventati.

L’altro approccio è quello prescrittivista. Quello è l’approccio dei grammatici puristi che, identificate le norme grammaticali grazie ai loro modelli linguistici, si lasciano trasportare dall’emozione e dal delirio di onnipotenza, e identificano quelle regolette con le sacre scritture, come se gliele avesse portate personalmente Mosè appena sceso dal Monte Sinai.
Una volta infusi di tanta scienza, per parlanti e scriventi della lingua così dottamente normata non c’è più scampo: il giudizio morale dei sommi sacerdoti del sacro idioma piomberà implacabile per ogni accento (in più o in meno), per ogni apostrofo (in più o in meno), per ogni congiuntivo mancato (o presunto tale) e per altre minuzie, non appena il malcapitato italofono si azzarderà a scrivere alcunché (un’email, un bigliettino ad un amico, un post sui social). Nessuno sconto. Mai.
Torniamo alle ragioni da cui era scaturita la mia domanda di sei mesi fa.
Come forse già sapete, nel 2018 mi ero rivolto alla Crusca chiedendo loro di modificare la loro scheda sulla grafia del qual(’)è. Dopo aver spiegato il motivo per cui si deve considerare corretta la grafia qual’è con apostrofo al giorno d’oggi, chiedevo all’Accademia di aggiornare la scheda per farla suonare meno perentoria e non costringermi a difendermi dall’accusa di ignoranza ogni volta che usassi la forma moderna nei miei scritti.
L’Accademia mi aveva dapprima risposto via Twitter che loro non dettano le regole della lingua, bensì la descrivono. Oltre a quello, il prof. Paolo D’Achille, responsabile del servizio di Consulenza sull’italiano contemporaneo dell’Accademia, mi aveva onorato di una lunga e argomentata replica. In essa sono emersi punti importanti: intanto esimi linguisti, quali S.C. Sgroi, sulla questione la vedono come me; seconda cosa, la logica dell’apocope (quella che sostiene che si tratterebbe di troncamenteo e non di elisione) non convince; e terzo, la grafia “quale è” scritta per esteso è oggi perfettamente accettabile (ammissione molto importante questa. I grammatici che prescrivono “qual è” lo fanno escludendo la correttezza di “quale è” per evitare di entrare in contrasto con la regola generale dell’elisione).

Questo non è poco, anche se, con mio rammarico, il prof. D’Achille non era arrivato alla conseguenza ultima di queste constatazioni: modificare la scheda nel senso che indicavo io. L’ultimo ostacolo citato da D’Achille sarebbe l’uso maggioritario del qual è che, in un’asserita ottica descrittivista, ancora porta la Crusca a consigliare (solo consigliare, per carità!) la versione apocopata.
Non avevo avuto quello che volevo, ma avevo avuto comunque molto.
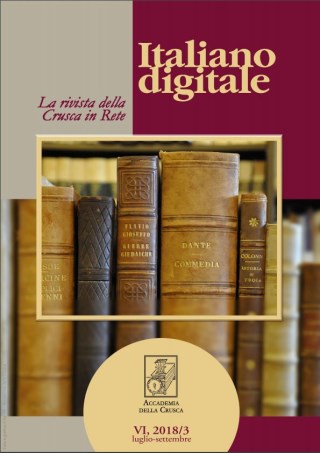
Nelle settimane successive, ecco un colpo di scena: un qual’è apostrofato era apparso, ad opera del prof. Sgroi, in un articolo su Italiano Digitale, una pubblicazione della Crusca. Preso dall’entusiasmo per tale divina apparizione, avevo scritto un articolo inneggiando allo sdoganamento del “qual’è” da parte dell’Accademia. Ma lì, apriti cielo, è intervenuto il presidente Claudio Marazzini con un atto di scomunica che affermava che la Crusca non aveva sdoganato alcunché. Non pago del cambiamento del titolo del mio articolo su VNY, anche l’articolo di Sgroi su Italiano Digitale è stato rimosso dalla rivista (che è stata ri-edita senza articolo. Per i collezionisti di Gronchi Rosa e di altre rarità, uno dei pochi esemplari della prima versione con l’articolo incriminato può essere trovato qui).
Tristezza dell’evento a parte, c’era un problema più grande: a questo punto i conti non tornavano più. Se la Crusca è descrittivista, come ha sempre affermato di essere, qual’era il motivo di tanta veemenza contro l’apostrofo del qual’è in un articolo?
La ricerca sull’argomento ha portato ad alcune scoperte interessanti. Se da una parte l’approccio descrittivista professato dalla Crusca spiega la filosofia alla base di molte schede (ad esempio quella famosa che sembrava legittimare l’uso di “uscire il cane”), altre esternazioni pubbliche sono invece frutto di un atteggiamento purista: la Crusca, specialmente quella attuale retta da Marazzini, si sente autorizzata a “normare” la lingua italiana e avrebbe la pretesa di dire agli italiani come devono scrivere. Un approccio diametralmente opposto a quanto dichiarato, insomma.
Da tutto questo nasceva lo spirito della mia domanda alla Crusca, che riporto nuovamente qui:
Cari e stimati professori, qual’è il vostro ruolo rispetto alla nostra lingua? Il vostro scopo è semplicemente consigliare come scrivere, oppure pensate di avere il diritto di dire a noi italiani come dovremmo scrivere secondo le vostre dottissime norme grammaticali?

Belgrado: non pervenuta
Quando guardavo le previsioni del tempo in TV da bambino, avevo perso fiducia che gli emissari RAI in Jugoslavia inviassero per tempo a Roma le informazioni sulla temperatura dalla remota Belgrado (remota a quel tempo). Ma perché diamine era così difficile sapere quanto faceva caldo o freddo a Belgrado? Si trattava di una sensazione di sottile insoddisfazione che la Crusca marazziniana mi ha fatto nuovamente provare in questi mesi di lunga attesa. Mi aspettavo una telefonata, un’email, un blog post, un tweet o qualcosa che avrebbe risposto alla mia domanda e mi avrebbe fatto finalmente capire qual’è il ruolo dell’Accademia.
Invece non è successo niente di tutto questo. Niente di niente. Risposta non pervenuta. Semmai, ci sono state altre situazioni in cui la Crusca ha assunto un atteggiamento purista nei confronti del pubblico. Per dirne una, l’altro giorno gli account social dell’istituto dicevano agli italiani di sostituire la pronuncia scandìnavo, la pronuncia standard con accento sulla i, con un inaudito scandinàvo. Sono certo che ci siano ottime ragioni etimologiche per quella scelta, ma se si guarda l’uso vero degli italiani (approccio descrittivo) quel consiglio è una sciocchezza (fidatevi: ho vissuto otto anni in Scandinavia e non ricordo di aver mai sentito un italofono dire “scandinàvo” in tutta la mia vita né dal vivo né alla TV).
Ma non è l’unica cosa. Lo scorso autunno il presidente Marazzini ha pubblicato un libro, Elogio dell’Italiano, uscito con La Repubblica sotto forma di lunga intervista. Orbene, il presidente ha dedicato ben sette (!) pagine del libro (pag. 40-46) per condannare il “qual’è” con apostrofo e per prendersela direttamente con il non allineato Sgroi (pag. 40-41). Credo di essere stato citato anch’io indirettamente in qualità di “sostenitore di questo grammatico eretico” (pag. 41), ma il Presidente non mi ha onorato con una chiamata per nome anche se l’intervento da lui citato (quello del prof. D’Achille di cui ho scritto sopra) era una risposta al mio interpello (intuisco che Marazzini sia un po’ “elitario” e abbia scelto di rapportarsi solo coi suoi pari. Nessuno è perfetto).
Insomma, il dubbio sul ruolo della Crusca non accenna a diminuire, anzi… il mistero sembra infittirsi a mano a mano che si va avanti.
La gente è confusa
Ovviamente, se sono stato confuso io che ho provato ad approfondire la cosa, potete immaginare il caos mentale in cui versa il grande pubblico. Agli italiani da una parte viene lasciato intendere che la Crusca sia ente “normante” della lingua, ma dall’altra parte la versione ufficiale è che non sia affatto così. Quando gli fa comodo, la Crusca afferma che loro descrivono la lingua e non la normano, ma, al tempo stesso, frequenti esternazioni del presidente e di altri esponenti dell’Accademia rivelano una tendenza a porsi come motore immobile della lingua italiana, corroborando l’idea che l’istituzione sia preposta ad accettare e a respingere espressioni e costrutti dell’italiano contemporaneo.

In quest’ottica, si spiega molto bene la confusione generata di volta in volta dai vari “uscire il cane” piuttosto che “petaloso” piuttosto che “la Crusca sdogana presidenta anzi no” e così via. Perfino il presidente Marazzini si è lamentato in prima persona di questa cosa nel blog ufficiale pochi giorni fa tuonando contro incompetenza e fake news che arrivano a lambire l’istituzione da lui diretta.
Tutto quello che vuole, signor Presidente, ma chi è causa del suo mal, pianga se stesso. In questo momento la Crusca è cerchiobottista: dice di non dettare le regole, ma poi prova a farlo; le schede partono da filosofie inconciliabili e generano consigli pratici confusi e poco coerenti (se non per un pubblico specialista che sappia come leggerli, ovvero non certo l’italiano medio e semicolto).
Questo crea quello che prosaicamente definirei “un gran casino”. Ovvio che poi la gente non capisca più che pesci prendere se un linguista affronta l’argomento “scendere il cane” scientificamente, e qualche giornale sintetizza poi con un richiamo allo sdoganamento. Se la Crusca facesse davvero una scelta e rimanesse coerente a quella, la situazione sarebbe assai più facile da gestire.
SPASSA: Una style guide per l’italiano
Una cosa è oramai chiara: lo stato di cose è il risultato di una tensione non risolta tra gli accademici puristi e quelli descrittivisti all’interno della Crusca stessa. Se non fosse così, una soluzione i ragazzi di via di Castello, 46 a Firenze l’avrebbero trovata e l’avrebbero comunicata Urbis et Orbis. Ma così non è stato. E allora come uscire dall’impasse?
La soluzione potrebbe passare da SPASSA, acronimo di “Standard per la Pubblica Amministrazione e Standard per la Scuola dell’Accademia (della Crusca)”. Tale documento rappresenterebbe, se non una vera e propria grammatica italiana (opera forse troppo onerosa da intraprendere), almeno una style guide.
La style guide SPASSA altro non sarebbe che un documento ufficiale della Crusca preposto a fornire le linee guida linguistiche che permettano ad autori diversi di esprimersi con stili coerenti tra loro, in modo da realizzare testi chiari e coesi per l’intera comunità in due contesti specifici: scuola e pubblica amministrazione (PA).
SPASSA potrebbe essere il risultato del lavoro di un gruppo interno alla Crusca o adiacente ad essa (tipo la discutibile operazione INCIPIT, ma per un buon motivo questa volta). Esso avrebbe carattere normativo per gli studenti della scuola pubblica italiana e per chi redige documenti in seno alla pubblica amministrazione, ma non sarebbe normativo per altri parlanti e scriventi, giornalisti e scrittori in primis, che avrebbero così maggiore libertà di far evolvere la lingua secondo le loro esigenze comunicative, eliminando la tensione con Crusca e grammarnazi.
Ma cosa conterrebbe in pratica la SPASSA? Si potrebbe cominciare con il congiuntivo diafasico, e con considerazioni di questo tipo (vado a braccio):
“La presenza del complementatore il fatto che seleziona il congiuntivo come opzione stilistica nella subordinata”
O anche:
“Evitare di usare gli con il significato di a lei e a loro.”
O anche:
“Evitare l’uso di piuttosto che con valore disgiuntivo e di copula.”
E perché no:
“Evitare l’uso dell’imperfetto indicativo sia nella protasi sia nell’apodosi delle frasi ipotetiche della possibilità e dell’irrealtà.”
Tale documento non andrebbe neanche scritto una volta per tutte, ma potrebbe tranquillamente essere “versionato”, come noi informatici facciamo normalmente col software e oramai anche coi documenti. Si potrebbe partire con uno SPASSA 2020, per poi passare allo SPASSA 2023 e a quello del 2026, secondo le esigenze di aggiornamento avvertite dal gruppo di lavoro che lo redige.
Per quanto mi riguarda, la bozza potrebbe pure stare su GitHub, e utilizzare quella piattaforma per commenti, bug report e pull request. La lingua viva farebbe il suo lavoro, e la Crusca sarebbe in grado di monitorare qual’innovazioni meritino di entrare a far parte dello standard alto, e quali debbano invece dimostrare ancora di meritare tale riconoscimento.
In pratica SPASSA avrebbe grandi vantaggi. Facciamo una simulazione con il già citato prof. Vittorio Coletti che spiega “uscire il cane”.
“Siamo dunque di fronte a innovazioni in incubazione, almeno a mio giudizio accettabili a livello pratico e familiare, ma non accettabili in scritti formali ed esplicitamente indicate come errate dalla norma SPASSA 2020.”
Che goduta per tutti! Si salverebbero i proverbiali capra e cavoli. Coletti potrebbe fare in autonomia il suo lavoro di scienziato della lingua, ma nessuno si sognerebbe di dire che la Crusca “sdogani” alcunché nel momento in cui SPASSA stesso vieti l’uso transitivo di uscire esplicitamente. Che un dipendente pubblico non si azzardi ad affiggere un cartello che chieda agli utenti di “uscire un documento di identificazione”! Allo stesso tempo, chi uscisse un “uscire il cane” su Twitter o Facebook non dovrebbe difendersi da accuse di ignoranza (mica siamo a scuola, qui!) Un vero spasso (oops, bisticcio di parole) per tutti insomma.
E cosa dire del mio caro qual’è? La scheda del 2002 potrebbe finalmente recitare:
“Per motivi storici (la regola ortografica adottata dalla scuola italiana) la forma maggioritaria in libri e giornali è qual è, benché non ci siano motivi significativi per indicare qual’è con apostrofo come grafia scorretta. SPASSA 2020 indica come corretta la forma senza apostrofo.”
(Nota veloce dell’autore: ovviamente auspico fortemente che la Crusca non voglia aggiungere il qual’è tra le espressioni che SPASSA mette al bando. Non lo troverei un atteggiamento consono da parte di chi dovrebbe avere un approccio scientifico alle questioni linguistiche. Non si può continuare a ostracizzare la forma apostrofata quando tutti i linguisti sanno benissimo che tale grafia è sincronicamente corretta e più aderente alla pronuncia che ne fanno gli italiani! Non costringetemi ad accamparmi davanti alla sede dell’Accademia come fanno quelli che protestano davanti alla Casa Bianca qui a Washington. Fine della nota.)

Ovviamente ci sarebbero ulteriori vantaggi persino più importanti a mio modesto parere. Intanto una style guide di questo tipo aiuterebbe gli studenti italiani a sviluppare la loro coscienza linguistica. Sarebbe ovvio a tutti che la lingua parlata è solo parente di quella formale descritta da SPASSA 2020 e gli studenti imparerebbero a gestirle entrambe, rendendosi conto dell’importanza delle parole e di come esse vadano calibrate nei diversi contesti e registri.
Ma c’è un aspetto che trovo ancora più importante. In un mondo in cui l’inglese la fa da padrone, è necessario dare alla nostra lingua la possibilità di evolvere rapidamente. Occorre che essa sappia dotarsi delle potenzialità espressive necessarie per competere con l’inglese ad armi pari (almeno in patria) nei diversi campi dello scibile umano. La presenza molesta della gestapo linguistica nostrana sempre in agguato è oggettivamente un intralcio: migliaia di frustrati passano i giorni su internet alla ricerca di un anglismo, di un’ipotetica con l’imperfetto indicativo, di un pò accentato e di un qual’è apostrofato da mettere alla berlina. Lungi dal rappresentare una linea di difesa della lingua, tutto ciò rappresenta un punto di debolezza che tiene l’italiano legato ad uno stato di lingua vecchia e cavillosa. La lingua di una nazione moderna non può funzionare così. Deve potersi evolvere più rapidamente, anche per poter più rapidamente far posto a parlanti non madrelingua.
Vogliamo che l’italiano sia la lingua di italiani vecchi e nuovi oppure solo quella di un’elite intenta a conservare uno status quo fine a se stesso?
La decisione di aprire la lingua a cicli di mutamento più rapidi è una responsabilità storica in cui la Crusca può porsi, a sua scelta, o come intralcio al progresso del paese o come promotrice dinanzi a sconvolgimenti globali di impatto epocale.
La Crusca davanti a una scelta: cosa fare da grande
Porsi come promotori di cambiamenti radicali richiede scelte coraggiose che rompano col passato. In questo articolo ho indicato una possibile strada che, come effetto collaterale, porrebbe fine alla confusione intorno al ruolo dell’Accademia a cui assistiamo spesso.
La Crusca saprà fare questa scelta? Oppure preferirà essere l’ente soporifero che predica l’aderenza ad una norma lontana dalla lingua vera e quindi costantemente al centro di diatribe sciocche sul chi sdogani cosa?
Vedremo. Per me, è ora che la Crusca decida finalmente cosa vuol fare da grande.












