Non guardiamo allo strumento, guardiamo all’uso che sapremo farne.
Tullio de Mauro
All’Università di Toronto, dove si studia italiano da prima che il Canada diventasse una nazione, si è svolto il 19 ottobre uno degli oltre 1300 eventi programmati per la Settimana della Lingua italiana nel mondo sul tema “L’italiano e la rete. Le reti per l’italiano”.

All’interno della tematica proposta dal Ministero degli Affari Esteri, la giornata seminariale “Italian Language and Media in Toronto” ha visto la collaborazione delle figure chiave dell’italianità a Toronto: Alessandro Ruggera, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura; Eugenio Sgrò, Console Generale d’Italia a Toronto; Salvatore Bancheri, direttore del Department of Italian Studies, University of Toronto; Emanuel Nikiema, direttore del Department of Language Studies, University of Toronto Mississauga; e Gabriella Colussi Arthur del Department of Languages, Literatures and Linguistics, York University. L’evento ha visto anche la partecipazione di esponenti italiani e internazionali di primo piano a confrontarsi sulle opportunità didattiche offerte dai media e conoscere meglio la eccezionale realtà linguistica e culturale nordamericana.
Una manifestazione del genere con una tale collaborazione tra strutture del governo italiano e enti accademici canadesi diventa uno strumento strategico per la diffusione della lingua italiana all’estero, sostenuta e appoggiata in modo particolarmente unico. Come ha affermato il professor Emanuel Nikiema, docente di francese e Chair del dipartimento di lingue: “Il discorso del Console mi rende un po’ invidioso dell’appoggio e sostegno enorme che il governo italiano e le autorità italiane prestano per tutelare e promuovere la lingua e cultura italiana. Siete fortunatissimi. Magari lo avessimo per la francophonie…”.
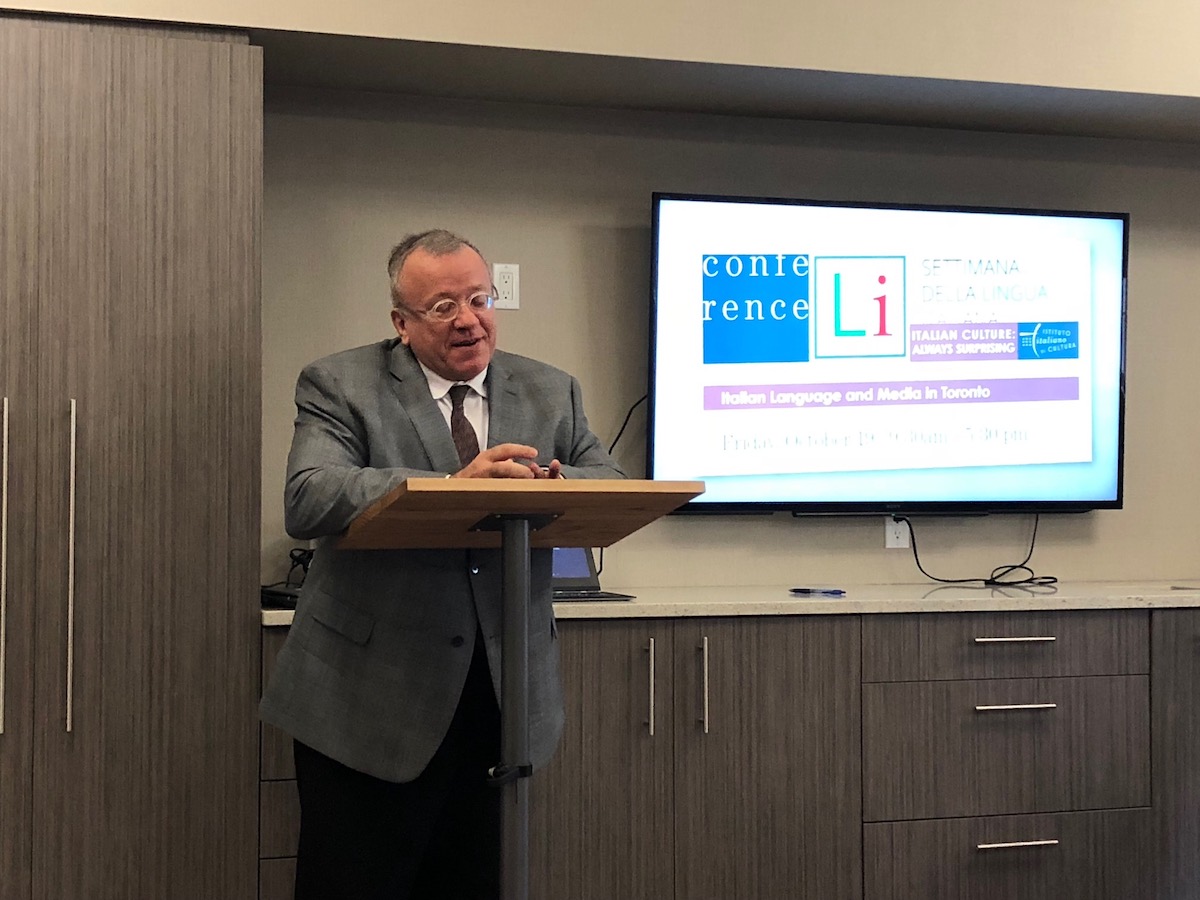
Dopo i saluti istituzionali, la relazione plenaria, intitolata “I media e la lingua: uno sguardo attraverso la storia linguistica italiana” e tenuta dalla professoressa Silvana Ferreri, ordinario di Linguistica presso l’Università della Tuscia di Viterbo, che ha così provocato il pubblico: “Cosa pensiamo che facciano i media per l’italiano? Un’operazione di crescita? Mantenimento? Salvaguardia?”. La professoressa Ferreri ha ripercorso delle tappe fondamentali nel ruolo dei media che hanno condizionato la lingua e i linguaggi d’Italia, un paese con il maggior numero di lingue al suo interno, caratterizzato da un antico plurilinguismo endogeno.
“Dietro alle nuove tecnologie, c’è sempre il linguaggio e la capacità di elaborare pensieri”.
Tullio De Mauro
Vari studi del grande linguista Tullio de Mauro sui media, vecchi e nuovi, i quali presentano un punto di vista innovativo, esaminano quello che è successo alla lingua italiana e in più anche quello che è successo agli utenti della lingua, agli Italiani. Di queste ricerche se ne occupa tuttora Ferreri. Inoltre, la rete ha segnalato “un cambiamento radicale nell’uso dei media—afferma la professoressa Ferreri—cambia il passo della comunicazione”. Si sofferma sull’uso dei cellulari, citando che l’Italia è il paese più telefonico del mondo tuttavia non si usano per fare telefonate. “Sono interattivi, bidirezionali, svincolati dai limiti di ben poco spazio, favoriscono una partecipazione al processo comunicativo”.
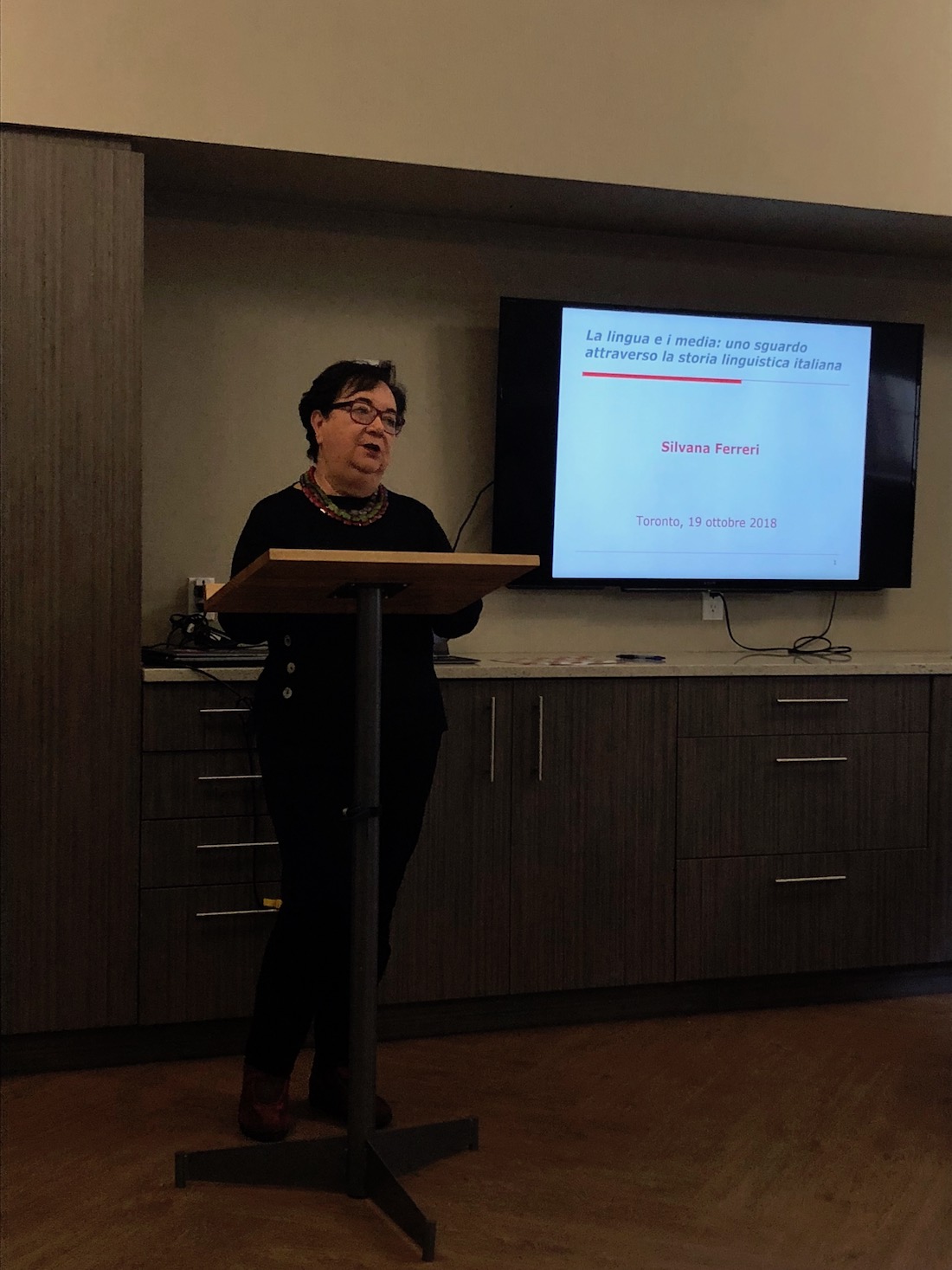
Il cellulare (e altri dispositivi) è riuscito ad aumentare il numero di persone che scrivono e anche leggono attraverso i media i quali “sono soprattutto multimodali — io uso più canali contemporaneamente: ascolto, scrivo, leggo, rispondo — non è più una specializzazione di un canale a rispetto a un altro—spiega la professoressa—cambiano le condizioni di produzione e ricezione, scrivo ma non so chi mi riceverà, ci saranno interazioni tra parlanti senza alcuna distinzione di status, di ruolo, di tutto”. Le implicazioni sul piano linguistico educativo sono notevoli, in modo particolare quando si pensa alla compenetrazione dei media, i nuovi intrecci delle abilità che non si possono più studiare singolarmente a prescindere da ciò che ancora continuiamo a farlo.
“Questa multimedialità richiede alti livelli culturali–afferma–senza il netto della cultura, la riduzione delle potenzialità, delle possibilità espressive, è massiccia”. A proposito dei media come strumento didattico, il suo consiglio è di “affiancare ma non sostituire i corsi in presenza con i media perché c’è una differenza tra apprendimento incidentale e un insegnamento intenzionale”.
Sul ruolo attuale dei media, visto che l’italiano “è una lingua minoritaria dal punto di vista della presenza all’interno del web a causa della scarsa produzione di contenuti all’interno del web” la Ferreri ha proposto “i media potrebbero affianco alle cose che fanno, occupare uno spazio nella formazione di prodotti culturali da mettere sul web per occupare maggiore spazio. E per i giovani che seguono quello c’è in rete, la possibilità di trovare più produzioni culturali nella nostra lingua”.
Un ottimo discorso sui media, sulla loro potenzialità straordinaria al livello linguistico, ma anche un’occasione per riflettere sulla correlazione tra lingua e cultura.

A seguire una tavola rotonda, altrettanto informativa e interessante, moderata da Corrado Paina, direttore della Camera di Commercio Italiana dell’Ontario in cui si è parlato dei media etnici con l’On. Joe Volpe, direttore del quotidiano Corriere Canadese, Onofrio De Lernia dell’OMNI News, Cristiano De Florentiis della RAI Tv, Stefano Vaccara de La Voce di New York e Umberto Manca della CHIN Radio. Prendendo spunto dalla relazione della professoressa Ferreri, Paina ha accennato a una operazione di mantenimento, addirittura salvaguardia per i media italiani, e da qui nasce la prima domanda: “Per chi scrivete oggi?” cioè chi è il pubblico che legge, segue i media italiani? Si sono confrontati sul futuro di tutti — televisione, radio, giornali, internet, e i social (Facebook, Instagram, Twitter) — per poter comunicare con le nuove generazioni di origine italiana, ed essere quel contatto continuo con la lingua e cultura. Ad un certo punto della tavola rotonda, una domanda dal pubblico che si concentrava sui numeri, sui nuovi media che vanno fortissimo e sono di tendenza. In risposta a questa domanda, Vaccara ha citato Netflix e il suo rapido incremento di popolarità, che addirittura occupa il 15% del traffico web. “Netflix ha iniziato con grande qualità. ma ora sta scadendo perché punta solo ad allargare la richiesta di milioni e milioni di persone”. Stiamo attenti: soffermarsi solo sulla finalità quantitativa facilmente potrà ridurre la qualità del contenuto.
Vaccara ha poi elaborato la funzione dei giornali per gli italiani in Nord America, dalle origini rifacendosi all’evoluzione dello storico quotidiano italo-americano di New York. “Il Progresso, giornale che a un certo punto vende 300.000 copie a New York negli anni Trenta del secolo scorso, nasce perché nei primi del ‘900 gli Italiani che arrivavano a New York non parlavano neanche una parola d’inglese. Allora se per esempio qualcuno era arrestato e processato, sulle pagine del Progresso trovavano la traduzione di quello che veniva detto in aula. Era soprattutto uno strumento di aiuto. Poi, dopo il periodo in cui furono utilizzati anche dalla propaganda del regime fascista, inizia l’epoca dell’informazione delle notizie soprattutto dall’Italia, perché un giornale italiano ci metteva giorni prima di arrivare negli USA. Con la televisione e internet questa funzione è finita perché giustamente gli Italiani che non parlano inglese non ci sono più oppure sono persone che sanno benissimo come informarsi su internet. E allora a che serve la stampa italiana all’estero? Oltre a informare sugli avvenimenti strettamente comunitari, deve rimanere legata alla cultura italiana, alla lingua degli italiani e concentrarsi soprattutto sulla qualità. Insomma uno strumento per diffondere cultura italiana e far pensare ancora in italiano”.

La seconda parte della giornata, dedicata alle opportunità didattiche offerte dai media, è iniziata con l’intervento di chi scrive queste righe, “Twitta per imparare italiano: gli ultimi 10 anni e uno sguardo al futuro”. In quest’anno 2018 ricorre il decimo anniversario del primo studio sull’uso di Twitter all’università (i risultati di cui sono stati pubblicati nel 2009 e presentati anche qui). Secondo un articolo approfondito sui primi 10 anni di Twitter a scuola, sono stati pubblicati più di 750 articoli accademici su Twitter come strumento didattico per lo studio delle lingue straniere. Peccato che tra tutti questi articoli fino al 2016, solo due sono per l’italiano (dato davvero allucinante!). Ragioniamoci insieme. Docenti e studiosi della lingua italiana dovrebbero andare a pari passi con le altre lingue straniere. Come possiamo discutere del ruolo dei media sul piano linguistico educativo se non siamo pronti a esaminare i social e i giovani che, piaccia o non piaccia, sono un binomio inscindibile? Bisogna poter riconoscere le potenzialità di questi strumenti, valutarle e riflettere sul loro ruolo nell’insegnamento.

Passiamo da Twitter a Betwyll, una applicazione di social reading che permette all’utente di leggere, commentare in 140 battute e condividere con una comunità di lettori con lo scopo di sviluppare una lettura profonda del testo e non solo. “È stato un grande onore e un enorme piacere essere invitato a questa proficua giornata di studio organizzata dalle università di Toronto e dall’istituto Italiano di cultura. Essere invitati ufficialmente, in una cornice così istituzionale, a discutere di come i media possono servire per insegnare l’italiano ha significato che Betwyll viene considerata uno strumento utile per l’insegnamento della lingua — dice il project manager Iuri Moscardi — Nei primi mesi del 2019 dovrebbe infatti partire un progetto di social reading che coinvolgerà gli studenti di italiano di UoT, UTM e York, oltre agli studenti dell’istituto. Sono molto soddisfatto dell’accoglienza ricevuta da parte dei professori presenti, incuriositi e attenti.”

A chiudere la giornata il professor Salvatore Bancheri ha provocato con la domanda “Ma veramente….stiamo tutti bene?”. Guardiamo i dati che riguardano la situazione della lingua italiana che emerge dagli Stati Generali organizzati dal Ministero degli Esteri: la quarta lingua più studiata nel mondo con 2.145.093 studenti in 115 paesi. Un trionfo per l’italiano. Ma veramente…stiamo tutti bene?
Un approfondimento dei dati rivela invece che in Nord America al livello universitario c’è stato un calo significativo; l’insegnamento K-12 una situazione peggiore. Non per un calo ma per quel che sembra un immobilismo da parte delle istituzioni scolastiche nei confronti dei programmi d’italiano. Bancheri segnala “tra le 665 istituzioni scolastiche che offrono italiano negli USA, appena 150 (il 27,3%) hanno partecipato alla rilevazione”. Questo atteggiamento insieme al calo degli iscritti nelle università cosa prevede per la lingua e cultura italiana?

Dunque la rete non è solo internet, media, ecc., ma anche una rete di persone “attori diversi italiani e stranieri, istituzionali e accademici, ed ancora accademici, scolastici e di comunità—conclude Bancheri—che hanno la voglia e l’entusiasmo di sedersi attorno ad un tavolo per guardare assieme alla lingua italiana e a quello che con la lingua italiana e per la lingua italiana si può ancora fare”.
La conferenza sul ruolo linguistico educativo dei media in Italia e in Canada (e in USA) è stata non solo un’occasione per confrontarci ma anche un invito ad agire, di raggiungere mete sfruttando i media, vecchi e nuovi, mettendo alle prove le potenzialità delle reti mediatiche e umane. La lingua associata alla bellezza, che si studia per passione, per amore (parole del ministro degli Esteri Moavero Milanesi), qui in Nord America si può mantenere solo se tutti noi siamo pronti a cambiare, migliorare, aggiornarci, lavorare.











