19 marzo 2024. Il treno correva verso sud. Marilynne Robinson si appoggiò al vetro e fissò il cielo. Era quasi sera, e la luna sorgeva proprio mentre il sole lasciava il suo ultimo bagliore all’orizzonte.
Un sorriso le attraversò il volto. Questo è quello che aveva descritto nelle prime pagine di Gilead (Einaudi, 2004), dove il reverendo John Ames — pastore congregazionalista settantaseienne — affida al figlio ancora bambino una lunga lettera d’addio. Tra i ricordi che affiorano, uno in particolare lo riporta all’infanzia: un viaggio con suo padre attraverso il Kansas, alla ricerca della tomba del nonno, predicatore radicale e visionario. Un’odissea fra campi arsi e fattorie abbandonate. Il giovane Ames — il narratore da bambino — e il padre si inginocchiarono. Ames ricordò di aver visto prima un tramonto a est, poi la luna piena salire dietro il sole calante. Due sfere in bilico, legate da una luce intensa, che tremolava tra loro e avvolgeva la tomba. Raccontò di quel bagliore come di un tocco divino.
Qualche pagina dopo, però, Ames spiega: quel fenomeno si vide in tutto il Kansas quel giorno. Il miracolo, dunque, non stava nel cielo, ma nella volontà di scorgere Dio in un momento sacro. E Marilynne, fra un sole che muore e una luna che nasce, lo sapeva bene.
Il sole tramontò completamente, e il treno parve accelerare verso la notte. La luce della carrozza si accese all’improvviso, cancellando i colori pastello del cielo e sostituendoli con contorni più netti, più freddi. Marilynne continuò a pensare a Gilead, a quella casa di legno bianco sospesa nel silenzio della prateria. Immaginò John Ames, la sua concentrazione mentre scriveva parole destinate al figlio che non avrebbe mai conosciuto perché fortemente malato. In Gilead, la fede non esplode in miracoli clamorosi, ma si nasconde nelle pieghe di un ricordo, nel peso di un perdono sussurrato, nel timore appena accennato che ciascuno di noi possa tenere tra le mani qualcosa di divino senza riconoscerlo. E Marilynne, mentre il treno riprendeva velocità, sentiva quel mormorio antico vibrare tra le rotaie: la consolazione più vera è quella che non proclami, ma custodisci in silenzio.
Gilead è stato un miracolo silenzioso, coronato da diversi premi – Pulitzer e National Book Critics Circle Award – e un grande successo di pubblico.
I futuri suoi romanzi sono tutti legati alla cittadina immaginaria di Gilead, Iowa. Home (Einaudi, 2008) racconta gli stessi giorni di Gilead, ma dal punto di vista della famiglia Boughton e del figlio ribelle Jack al ritorno dopo una lunga assenza. In Lila (Einaudi, 2014), la voce si posa su una donna cresciuta ai margini, segnata da abbandoni e silenzi. Vagando per l’America rurale, Lila trova rifugio nella chiesa di Gilead e nell’amore inatteso del reverendo Ames. La sua fede nasce dall’istinto, dalla fame di significato, ed è proprio in quel terreno spoglio che la grazia fiorisce, senza chiedere nulla in cambio. Jack (Einaudi, 2020) dà voce al figlio più tormentato del reverendo Boughton: un uomo segnato dal fallimento, dal senso di colpa e da un amore interrazziale difficile nell’America segregata degli anni ’50. La sua lotta è interiore, il suo dialogo con Dio è fatto di silenzi, e la redenzione sembra sempre un passo più in là, ma mai del tutto fuori portata.
Nei saggi When I Was a Child I Read Books e The Givenness of Things, Robinson ricorda e analizza il suo passato. L’infanzia, per lei, è un sacramento quotidiano: ogni gesto custodito nella memoria diventa parabola, ogni ricordo uno specchio del divino. Riflette sull’identità americana, sulla coscienza individuale, sulla responsabilità morale e sulla tenerezza nascosta nella fragilità umana. Scrive con la calma di chi sa che la verità non si urla, si ascolta.
E in Reading Genesis, il suo ultimo lavoro, prende in mano il testo più remoto, lo spoglia delle incrostazioni dogmatiche e lo riaccende come parola viva: non un racconto di ciò che fu, ma una mappa per ciò che siamo.
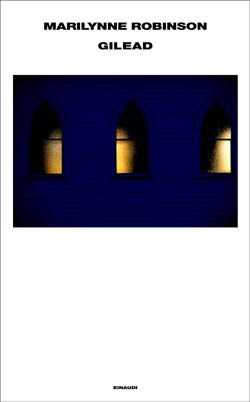
Così, da Gilead al Kansas, fino ai confini dell’antico Testamento, la sua opera resta un ponte: un filo di luce che unisce romanzi e saggi, terra e cielo, uomo e Dio. Sì, pensò. Quello che le interessa davvero è che quella luce resti nella testa e nel cuore dei lettori. Questo è molto più importante del Pulitzer, del National Book e del titolo del Ambassador Book Award del 2006. Molto più della popolarità avuta grazie alla stima del Presidente Obama. Stima che ebbe già dal novembre 2015: ancora prima di diventar presidente, il senatore Obama la intervistò per la New York Review of Books, discutendo di storia americana e fede. Il 26 giugno 2015, durante l’elogio funebre per Clementa C. Pinckney, il presidente Obama citò Marilynne Robinson. Parlando di “cuore aperto”, ricordò le parole della sua amica scrittrice: “è quella riserva di bontà che siamo in grado di offrire l’uno all’altro nella semplice, ordinaria vicinanza delle cose”.
Il treno rallentò con un sobbalzo lungo la rotaia. Fuori, nel buio, apparvero lampioni tremolanti e la doppia linea dei binari si fece specchio sotto le luci della stazione. Seduta, Marilynne lasciò che l’eco di quel viaggio si mescolasse al tintinnio dei sussurri dei pendolari. Pensò alle domande che avrebbero animato l’incontro di domani alla New York Public Library con Ayana Mathis: fede e Genesi, antico e moderno.
Prese il taccuino dalla borsa e lo mise sul grembo, il profilo in ombra contro il finestrino. Il cuore le batteva piano, misurato come un verso sacro. Ancora qualche fermata e tutto sarebbe cominciato di nuovo. Meglio ripassare gli appunti: una voce così non ammette distrazioni.












