La questione bellica ucraino-russa è da valutarsi non solo sul piano strettamente militare e giuridico, ma soprattutto dal punto di vista strategico delle materie prime a cui va aggiunta la particolare geografia degli affacci portuali sul Mar Nero.
In fondo la questione valutaria, cioè dei pagamenti del gas in rubli voluta da Mosca di recente (“Gas in rubli: la geopolitica valutaria e i calcoli della guerra”), non altro rappresentava e rappresenta una parte di quella che è una disputa più ampia; disputa che involge incidentalmente ma direttamente gli equilibri tra Occidente e Oriente (nel cui solco la Russia stessa è un po’ di qua e un po’ di là).
Nel recente libro La guerra delle materie prime e lo scuso ucraino (Rubbettino, pp. 54, 8,00€) Giuseppe Sabella spiega passaggi della questione che puntano, specificamente, a considerare non solo alcuni punti di origine del problema bellico ma anche gli intermezzi e, intuibilmente, la finalità concreta ed a lungo termine del Cremlino.
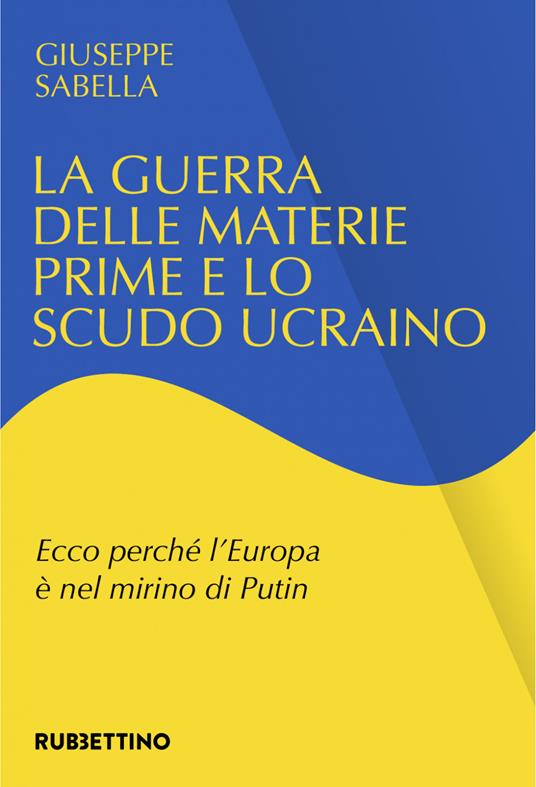
“L’Alleanza europea delle batterie e delle materie prime” rappresenta, ad esempio, un aspetto sensibile da tenere in considerazione nell’intero e complesso quadro della vicenda bellica; si pensi, per un attimo al fatto che lo scopo di tale contesto è sviluppare l’intera catena del valore dall’estrazione alla raffinazione e al riciclo dei minerali del Paese ucraino.
Su questo sfondo, spiega Sabella, a novembre 2021 la European Lithium Ltd (società australiana con sede a Vienna) si è accordata con la Petro Consulting Llc (società ucraina) ottenendo dal governo locale ucraino (dato che la Costituzione ucraina prevede l’autonomia per i governi territoriali come spiegato in una recente ricerca sulla rivista scientifica Alexis del GEODI – Centro di ricerca geopolitico e di diritto comparato dell’Università internazionale degli studi di Roma) i permessi per estrarre il litio da due depositi in particolare: uno a Shevchenkivscke nella regione di Donetsk (pieno Donbass), l’altro a Dobra nella regione del Kirovograd. Su quest’ultimo deposito, poi, superandosi la concorrenza con un’azienda cinese (la Chengxin).
Ecco che se si unisce questo fatto ad un altro imprescindibile da valutare nel contesto in sé per sé e cioè che il litio è fondamentale per lo sviluppo dell’industria delle batterie quale obbiettivo del c.d. Green Deal europeo, allora, potremmo ipotizzare come sia realmente il retropalco strategico russo (utilizzando l’operazione militare speciale avviata il 24 febbraio 2022 come carta, ultima o disperata, da giocare): i maggiori leaders mondiali di produzione delle batterie sono in Giappone, Corea del Sud, Cina e Australia.
Ora, se la Russia ha sostanzialmente ridotto o eliminato le possibilità di realizzazione degli accordi di novembre 2021 in relazione all’Alleanza sulle batterie significa, in altri termini, che entra in gioco per la ridiscussione delle estrazioni e forniture, quantomeno, del litio. E se la Cina è l’unico Paese tra i maggiori leader nella produzione di batteria a non essere a richiamo Occidentale è presumibile che l’obiettivo di Mosca sia condurre la partita verso Pechino per stabilizzare nuovi accordi che possano contemperare due cose almeno: – la Cina ha necessità di aumentare i volumi di energia e materie prime per mantenere alto il tasso di crescita del PIL (che non significa per forza di cose sviluppo del Paese); – la Russia ha necessità di avere diversità merceologica primaria da offrire sul piatto delle relazioni interdipendenti con i Paesi partener sapendo bene che gas e petrolio, via via, spariranno dai cicli produttivi e di vita delle masse (vedasi in ultimo decisione del Parlamento europeo sulle auto entro il 2035 e la deadline globale entro il 2050 per giungere ad emissioni zero).
Dove può cercarsi una chiave di lettura finale in tutto ciò? Forse nella fine della globalizzazione? “La globalizzazione è al canto del cigno – un bel problema per un’economia debole e votata all’export come quella russa – e all’interno del conseguente processo di decoupling, ovvero di sdoppiamento delle catene del valore, Putin ritiene che sia fondamentale per lui agganciarsi alla filiera asiatica e, quindi, a Pechino”. Questo il nucleo dell’articolato ed appassionato ragionamento di Sabella.
Chi è l’autore del libro da cui si parte per questa ulteriore analisi sulla questione?
Giuseppe Sabella (classe 1972) è direttore di Oikonova, think tank nato dall’esperienza del laboratorio milanese di Marco Biagi e specializzato in economia e lavoro. Autore di diverse pubblicazioni, collabora e ha collaborato con Tgcom24, Sole 24Ore, RaiNews e Il Sussidiario.












