Le parole sono il mezzo più potente che abbiano per esistere. Lo sa bene Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale e traduttrice, per vent’anni con l’Accademia della Crusca nella redazione della consulenza linguistica, oggi insegna all’Università di Firenze e indaga quelli che sono i meccanismi del linguaggio. Il suo ultimo libro “Le ragioni del dubbio”, uscito il 21 Settembre ed edito da Einaudi, è un lodevole tentativo che aiuta nel caos comunicativo dell’attuale complessa vita cognitiva, dove usare nel modo giusto le parole è diventata una necessità oltre che un enorme potere. Vera Gheno identifica tre parole che sono le pietre angolari di un metodo salvifico di quella faticosa abilità del saper comunicare bene e dialogarne con lei diventa un prezioso promemoria sull’amore per le parole e sulla responsabilità nei confronti di sé stessi e degli altri, in quanto esseri parlanti.

Perché un libro sul dubbio, la riflessione e il silenzio?
“Perché sono le tre parole che ho individuato in primis per me stessa per gestire la complessità cognitiva del presente. E siccome non c’è cultura senza relazione, tanto per parafrasare Antonio Gramsci, ho deciso che per me era importante condividere questo “metodo” che mi sono inventata”.
Perché è importante usare meglio le parole?
“Perché a mio avviso usare meglio le parole ci permette di vivere meglio; in ultima analisi, di essere più felici. Se è vero che le parole sono il nucleo della nostra umanità, come ci ricorda Chomsky, se è vero che senza il lógos, cioè la capacità del linguaggio, non c’è la pólis, ossia la società umana, come scrive Tullio De Mauro, a me pare consequenziale che migliorare l’uso delle nostre parole possa portare a un diffuso benessere”.
Ai nostri giorni non pensa che sia diventata più un’arte quella del saper tacere?
“Diciamo che l’arte sta nella sapiente alternanza di parole e silenzio, di pieno e vuoto. Bisogna cercare un equilibrio. Per esempio, evitando di parlare e scrivere a vanvera su argomenti che non si conoscono a fondo. Allo stesso tempo, resistiamo alla tentazione di stare zitti quando c’è bisogno della nostra competenza”.
Come si coltiva l’importanza del dubbio nell’era della comunicazione digitale, fatta di poche parole, spesso sbagliate, che porta ad impigrire e spegnere il cervello?
“Non penso che di per sé la comunicazione digitale porti a perdite cognitive. Questo può accadere quando si ha una “dieta mediatica” monocorde: solo social, solo telefilm, solo talk show, ma anche solo e sempre lo stesso giornale o solo libri classici. Il nostro cervello ha bisogno di varietà, e proprio grazie alla varietà mantiene la sua elasticità. Io penso che sia il modo migliore e più divertente per perseguire il dubbio”.
La riflessione richiede tempo ma il mondo di oggi è veloce e il più delle volte non ce lo concede. Qual è il primo passo da compiere per questo passaggio?
“Il tempo scorre in maniera molto soggettiva; spesso, quella di non avere tempo (per esempio, per rileggersi) è un’idea, non un dato oggettivo. Trenta secondi, se ben usati, sono tantissimi. Per questo, quando si sta per venire divorati dall’ansia di premere invio (o simili), propongo di pensare al minuto più lungo di cui abbiamo esperienza nelle nostre vite: l’attesa prima di scoprire il risultato di un test di gravidanza veloce, o il minuto prima dell’apertura dell’oblò della lavatrice a fine ciclo, o l’ultimo minuto prima che la pasta sia cotta… è un modo semplice per modulare il tempo, per rallentarlo, per non farsi travolgere dalla fretta”.
Un capitolo bellissimo del libro è dedicato alla fatica, comunicare richiede impegno, ci vuole un impegno collettivo affinché funzioni. Parlare bene con rispetto e cognizione è diventato un atto rivoluzionario?
“Non lo definirei rivoluzionario. Forse è un atto dovuto alla nostra umanità, alla nostra società e a noi stessi. La vera rivoluzione sta nel comprendere che la questione tocca ogni persona, non per forza “gli altri”. La lingua è cosa nostra”.

“Niente sarà più come prima. La pandemia ha cambiato per sempre la nostra lingua”. Ogni lingua sana cambia al mutare della realtà che deve rispecchiare. Quali sono gli aggiustamenti linguistici di cui ha avuto bisogno questo triste tempo?
“Sicuramente, ha dovuto includere termini che prima erano propri di settori circoscritti della lingua, come quello medico o quello della virologia. Al di là di quello, forse uno dei vantaggi portati dalla pandemia è quello di avere fatto vedere l’importanza di usare bene le parole nella cosiddetta onlife, come la chiama Luciano Floridi. Arrivati a questo punto si può davvero pensare di continuare a considerare la rete come qualcosa di “alieno” alla nostra vita quotidiana?”.
L’opinione dell’Accademia della Crusca è sacrosanta e non ha approvato il simbolo della Schwa, ecco c’è bisogno di pazienza anche per questo passaggio?
“Non è stata “l’Accademia della Crusca”, ma Paolo D’Achille, eccellente linguista, ad avere scritto la risposta di consulenza più genericamente dedicata al cosiddetto “linguaggio inclusivo”, non è certo dalla Crusca che mi aspetto un avallo di questi esperimenti linguistici. Il fatto è che c’è una minoranza di persone che sta attuando da un decennio una ricerca di autodefinizione linguistica che non comporti l’uso del maschile o del femminile; lo sta facendo in Italia come pure in molte altre lingue di molti altri paesi. Questo dato umano è incontrovertibile, e non è secondario rispetto alle “regole linguistiche”. Io stessa esprimo continuamente forti dubbi rispetto alle possibilità dello schwa di attecchire (come pure degli altri esperimenti linguistici in circolazione), ma non perché sarebbe impronunciabile, o è un simbolo alieno al nostro alfabeto, bensì perché sarebbe un cambiamento che impatta sulla morfologia dell’italiano, e prima che questo possa accadere ci vorrebbe un cataclisma sociale tale da far sentire il bisogno di una forma “terza” alla maggioranza della società. Ma la strada non è neanche accettare con un sorriso il maschile sovraesteso come inevitabile, come pure far finta che queste istanze non ci siano. Le istanze ci sono, troveranno la loro strada, senza essere imposte dall’alto (una delle sciocchezze che mi tocca continuare a leggere, detta anche da persone di indubbia levatura scientifica). A proposito, così come un’innovazione linguistica non può essere imposta dall’alto o a tavolino, così non la si può nemmeno vietare dall’alto o a tavolino”.
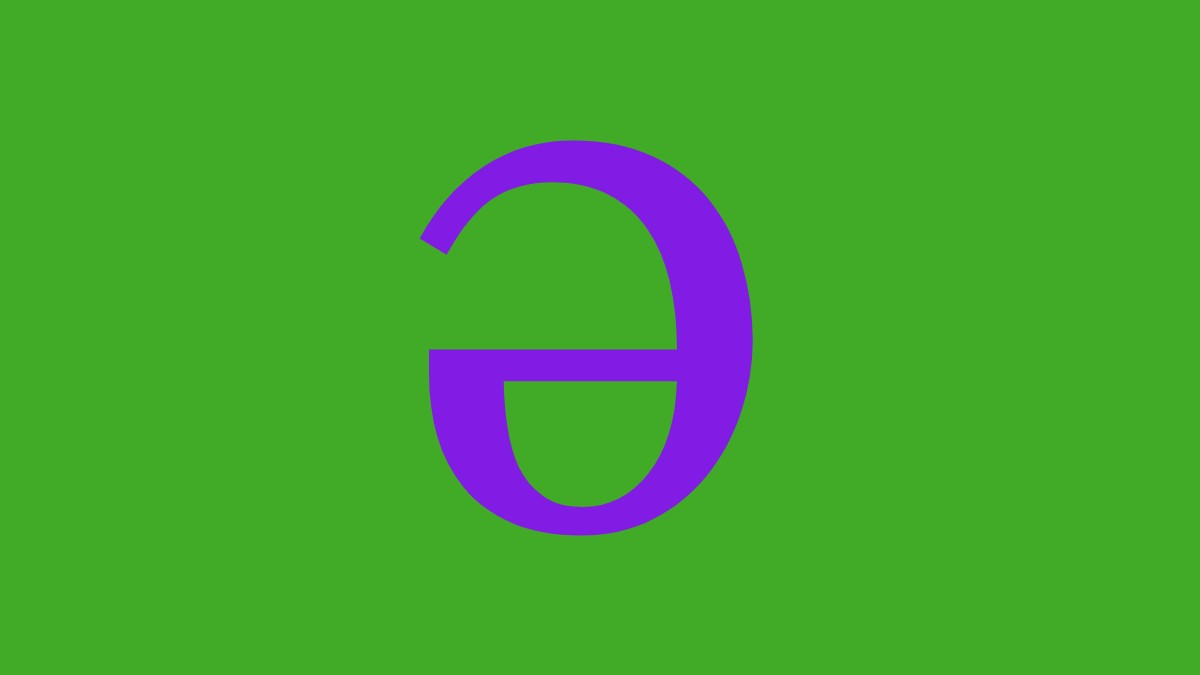
Qual è la difficoltà più grande per diventare e rimanere nel corso della vita un bravo essere parlante?
“Forse arrivare alla consapevolezza di sapere sempre troppo poco. E poi ricordarselo vita natural durante, anche laddove tenderemmo a dimenticarcelo”.
Una riabilitazione linguistica è possibile a qualsiasi età, quando e come si sviluppa il potere delle parole?
“Il grosso si sviluppa sicuramente nei primi anni di vita, forse nei primi quindi anni. Poi ci calcifichiamo tutti, diventiamo più renitenti al cambiamento… ma si può sempre fare qualcosa. Magari non si deve pensare di allenarsi per arrivare alle olimpiadi, ma mantenersi sufficientemente in forma, cognitivamente parlando, da correre attorno all’isolato”.
“Le parole mi hanno salvata da ragazzina, quando ero terribilmente insicura, afflitta da disturbi alimentari, intimidita dal prossimo”. La sua relazione tesa con il cibo deriva da un trauma di nominazione. Quanto può far male non saper usare bene le parole e in che modo possono invece essere salvifiche?
“Le parole fanno malissimo. Le parole in rete possono fare ancora più male perché non si arriva mai al limite della zuffa, del darsele di santa ragione. E le parole fanno pure benissimo, basta saperle usare. Ho visto persone raccontarmi i loro peggior segreti ed essere rinfrancate da una singola parola. Le parole sono balsamo, in mille momenti”.
Se dovesse scrivere una parola sui social media a tutti i giovani parlanti di oggi per incoraggiarli ad andare oltre il confortante “Lessico Famigliare” al quale sono indissolubilmente legati sin dalla nascita per imparare l’estraneo mestiere del saper comunicare bene. Ecco, quale sceglierebbe?
“Curiosità. Senza questa, si gode solo a metà, tanto per parafrasare una famosa pubblicità”.












