Dalla sua irruzione nelle nostre vite, il COVID è rimasto la prima notizia del giorno, tutti i giorni, in tutto il mondo. Eppure, pur partendo da informazioni scientifiche comuni, condivise e note in tutto il globo, ogni Paese del mondo ha reagito in modo diverso. Nessuno lo saprà meglio dei nostri lettori che, tra Italia ed America, per tutto il 2020 si sono trovati a dover conciliare due narrazioni marcatamente diverse dello stesso fenomeno.
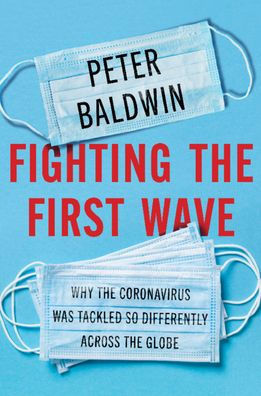 Come spiegare le vaste differenze nella risposta all’espandersi della pandemia? Nel suo nuovo libro, Fighting the First Wave, il professor Peter Baldwin, storico della UCLA, ne esplora le ragioni, non solo scientifiche e politiche, ma anche storiche, sociali e culturali.
Come spiegare le vaste differenze nella risposta all’espandersi della pandemia? Nel suo nuovo libro, Fighting the First Wave, il professor Peter Baldwin, storico della UCLA, ne esplora le ragioni, non solo scientifiche e politiche, ma anche storiche, sociali e culturali.
Professore, grazie di avere accettato di fare due chiacchiere sul suo nuovo libro. Come docente di storia, il suo punto di vista sugli eventi dell’ultimo anno è fonte di molti spunti di riflessione. Cominciamo dalle domande più difficili: a quali conclusioni è giunto? Come si spiegano le vaste differenze nella risposta all’epidemia?
“In primo luogo, ci sono gli ovvi fattori geografici da tenere in considerazione. Alcuni paesi, come Australia o Nuova Zelanda, hanno potuto isolarsi meglio di altri. Poi c’è una questione di sfortuna: quei paesi che sono stati colpiti più duramente e per primi, come l’Italia, hanno avuto meno tempo di altri per prepararsi all’emergenza. E poi fattori come il tempismo, la tempestività delle risposte, che hanno premiato praticamente tutti i paesi asiatici… Su questo fronte le democrazie occidentali hanno sicuramente lasciato a desiderare. Sono tutte arrivate abbastanza in ritardo a fare i conti con la realtà, quando ormai c’era ben poco che si potesse fare se non chiudere tutto e bloccare in ogni modo la trasmissione del contagio. Tuttavia, io penso vada tenuto conto di un ultimo fattore. I leader politici nella loro risposta sembrano essersi largamente basati sulla loro valutazione del loro stesso elettorato. Hanno fatto quello che ritenevano di potersi permettere”.

In che senso, mi spieghi meglio.
“I diversi leader hanno valutato che i loro cittadini fossero più o meno in grado di sopportare alcune forme di dolore che altre. Prendi l’ex presidente Trump, o Bolsonaro. Hanno evidentemente considerato che il loro elettorato fosse più in grado di sopportare la malattia che la crisi economica, e hanno agito di conseguenza. Oppure prendiamo l’esempio del Regno Unito: Boris Johnson lo ha detto chiaramente, che lui non pensava che i suoi cittadini avrebbero rinunciato alla libertà di andare al pub. Ha mantenuto questa linea finché ha potuto, e in realtà ti dirò secondo me si sbagliava! I cittadini britannici hanno accettato le restrizioni ed il lockdown, non ci sono state rivolte di piazza”.
Nel suo libro lei riflette sul fatto che, se da una parte le misure dei governi sono state influenzate dalla loro opinione dei cittadini, la risposta dei cittadini è dipesa dalla loro opinione del governo, dalla fiducia nelle autorità. Ecco questa fiducia, in Italia come in America, è ai minimi storici. Dal suo punto di vista, al netto dello sviluppo scientifico, ci sarebbe stato un momento storico migliore per l’arrivo di una emergenza come questa?

“Domanda interessante. Io direi il secondo dopoguerra. Mi viene in mente il caso della vaccinazione contro il vaiolo a New York City nel 1947: in meno di un mese vennero vaccinate 6 milioni di persone, perché erano stati registrati una dozzina di casi e due morti. I novax ci sono da sempre, da quando ci sono i vaccini almeno, ma negli anni ’50 c’era un livello di fiducia nelle istituzioni che oggi è venuto a mancare… Le informazioni viaggiano veloci, e con più viaggiano con più sembra che il valore della competenza vada scemando. A questo poi si sono aggiunte le nuove preoccupazioni per la privacy, e la giusta enfasi senza precedenti sui diritti civili, che ingarbuglia il discorso ancor di più”.
In che senso?
“In questo ultimo anno i governi si sono trovati in un gioco a somma zero. Se si insiste sul fatto che dovessero rispettare i diritti civili, poi bisogna anche capire i diritti civili di chi. Perché da una parte c’è il diritto alla libertà, ad andare in giro, a lavorare, ed è giusto. Ma c’è anche il diritto degli anziani a non morire nel corridoio di un ospedale sovraffollato. Quello degli infermieri di non mettere a rischio la loro vita ogni giorno. Alla fine diventa una competizione tra quale diritto conta di più, un dilemma morale da cui si fatica a uscire”.

Quindi mi sta dicendo che le democrazie partivano svantaggiate nella gestione di una pandemia.
“Non facciamo confusione, molte democrazie hanno avuto una risposta eccellente. Basti pensare alla Nuova Zelanda! Ce ne fossero di leader come Jacinda Ardern. Però le democrazie sono strutturalmente impreparate a gestire rapidamente queste situazioni di crisi… Ed è per questo che tutti i paesi hanno le loro leggi su come bypassare temporaneamente la democrazia in casi particolari, tra cui guarda caso le pandemie”.
Eppure, come riporta nel suo libro, non tutti i paesi hanno esercitato questa autorità.
“Certo, per esempio la Svezia. Il governo continuava a sostenere di non poter prendere misure più restrittive, di avere le mani legate. Credo sia l’unico caso della storia in cui un governo si vanta di non poter prendere iniziative”.

Colgo la palla al balzo professore e la dirotto sulla crisi di governo italiana. Il nostro premier dimissionario è stato accusato, non sui giornali ma in Parlamento, di essere una “ferita per la democrazia” a causa della sua gestione della situazione emergenziale. Lei che di storia e di ferite alla democrazia ne sa per davvero pensa che sia calzante?
“No, direi di no. Se le democrazie avessero mantenuto i loro normali iter nella gestione di una pandemia saremmo tutti morti, parlare di ferita alla democrazia mi pare esagerato”.
Parlando di Svezia, nel libro riporta una riflessione: forse il caso svedese è stato così peculiare anche perché è un paese disabituato alle crisi drammatiche, avendo anche evitato la Seconda Guerra Mondiale rimanendo neutrale. Allora le chiedo, pensa che lo stesso sia successo anche su larga scala? Abbiamo dimenticato che i governi possono trovarsi anche a fronteggiare dei reali drammi, e dunque non ne teniamo conto quando andiamo a votare?
“Ah, questo è un discorso molto interessante. Ora che ci penso, forse è così. Mi piace pensare che Biden avrebbe vinto anche senza la pandemia, ma non ne sono convinto… Ha vinto anche perché è una figura rassicurante, a cui gli americani metterebbero in mano un paese in macerie. Forse prima di questa esperienza traumatica questo fattore era passato in secondo piano”.

Lei riporta che durante questa crisi in tutto il mondo la voce degli esperti virologi, catapultati volenti o nolenti davanti ai microfoni dei media, fosse più credibile di quella delle istituzioni alle orecchie dei cittadini. Dopo anni di populismi, di “uno vale uno”, forse questa pandemia ci ha reinsegnato il valore della competenza?
“Difficile a dirsi. Prendiamo proprio il caso dell’Italia, che passa da un governo politico a guida 5 Stelle ad un esecutivo con a capo Mario Draghi. Non è tanto che i politici stiano tornando alla competenza, quanto più che stiano ammettendo che la competenza è cosa a loro estranea. Io credo che nella popolazione l’esperienza della pandemia abbia lasciato un desiderio di maggiore competenza ed esperienza, spero proprio che sia così… Ma, del resto, in tutto il mondo occidentale ci sono parti della società civile, non marginali, che si sentono completamente estraniate dalle istituzioni, che votano per movimenti di protesta più che a destra o a sinistra. Non credo il loro sentimento sia cambiato solo perché c’è stata la pandemia”.
Che mi dice della cooperazione internazionale per lo sviluppo dei vaccini?
“Questa è l’altra faccia della lotta al COVID. UK e USA avranno fatto qualche pasticcio nell’aspetto di gestione della pandemia, ma sullo sviluppo dei vaccini e delle cure invece sono stati eccezionali ed efficientissimi, confronto ad altri paesi”.
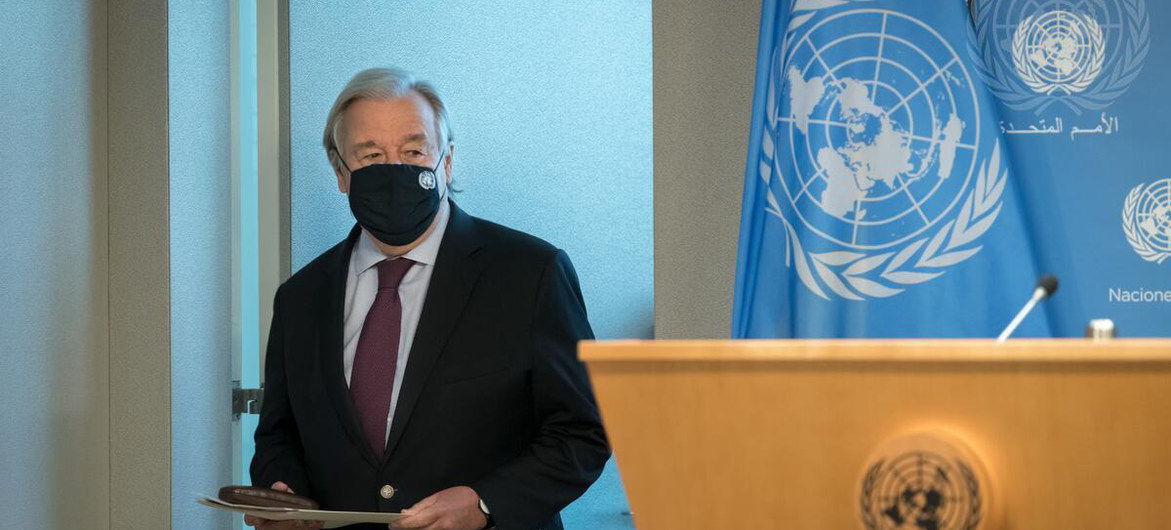
E sulla distribuzione internazionale?
“Argomento delicato. Siamo di fronte ad una ingiustizia di proporzioni globali nella distribuzione ai paesi con economie più deboli, è innegabile. Per giunta è una visione un po’ miope. Gli studi dimostrano che il guadagno in termini economici, per ogni dollaro speso dai paesi occidentali per sviluppare questi vaccini, sarebbe maggiore se la distribuzione fosse equa in tutto il pianeta. Però, cosa ci vuoi fare? Questo vaccino lo hanno pagato i paesi occidentali. Quale politico può dire ai suoi cittadini che devono aspettare perché le loro dosi di vaccino sono state mandate in Angola?”
Pensa avrà conseguenze dal punto di vista storico e geopolitico?
“Io credo ci sia un terreno molto fertile per Cina e Russia. Se la Cina domani decidesse di donare vaccini a tutta l’Africa cementerebbe la sua posizione in quell’area, allargherebbe la sua sfera di influenza del tutto indisturbata, l’occidente non proverebbe nemmeno a contrastarla”.

Cosa pensa rimarrà dell’epidemia da COVID professore?
“Nel mio libro ne accenno nelle conclusioni. Molti sottolineano che, per esempio, l’epidemia di spagnola ha avuto un effetto abbastanza limitato a livello storico, e che potrebbe essere così anche per il Covid, ma io non penso. In primis, la spagnola avvenne durante la Grande Guerra, e districare i due fenomeni e attribuire pesi specifici perfettamente distinti credo sia impossibile. Ma al di là di questo, io penso che questa epidemia lascerà tracce. Guerre e crisi economiche sono i periodi in cui lo Stato si inserisce con più forza nella vita dei cittadini, allarga il suo ruolo. Al passare dell’emergenza, piano piano la sua influenza torna a scendere, ma rimane sempre un po’ più alta di prima, e credo succederà anche in questo caso. Penso anche che cambieranno le priorità dei governi: sanità pubblica, coordinazione internazione… Ma non solo, anche il grande tema della crescita della popolazione globale, della crescente pressione demografica in alcuni paesi. Come verrà prodotto il cibo per una popolazione in crescita? Occorrerà assicurare che la produzione di cibo sia sicura, che gli animali siano protetti e che non si moltiplichino le situazioni di convivenza pericolosa tra uomini e animali che hanno dato origine a questa epidemia e alle ultime ad essa precedenti.

Professore dopo tutto questo parlare di epidemie volevo concludere la nostra chiacchierata chiedendole del suo impegno, con la sua fondazione benefica, l’Arcadia Fund.
“E’ un ente benefico che ho fondato con mia moglie. Ci occupiamo di difendere il pianeta dal punto di vista sia ambientale che culturale. Promuoviamo e finanziamo progetti per ristorare paesaggi ed ecosistemi, ma anche progetti che promuovono e preservano le culture a rischio, per esempio tenendo traccia delle lingue che si stanno lentamente estinguendo. Infine, un nostro grande obiettivo è la promozione dell’open access, vale a dire che ci impegniamo affinché l’accesso alle pubblicazioni scientifiche sia gratuito per tutti”.












