
Fine anni ottanta. Comic Club di New York. Tavolini stretti, camerieri veloci e brusio di sottofondo. Il palco è ancora vuoto, c’è soltanto l’asta, il microfono e lo sfondo di mattoni rossi sulla parete. Quando si abbassano le luci, il pubblico si zittisce di colpo e sparisce nell’oscurità mentre si accentua il chiarore del palcoscenico. Il primo comico prende il microfono e inizia il suo monologo, è iniziata la serata di stand-up comedy.
Elizabeth Strout è seduta tra gli spettatori con Martin Feinman, il suo primo marito. Si è trasferita a New York da circa un anno e da allora trascorre tutte le sere al Comic Club.
Dopo il college a Bates nel Maine, ha lavorato come cameriera in ogni ristorante e cocktail lounge della città, ha accettato qualsiasi lavoro che le poteva lasciare abbastanza tempo libero per la scrittura, ma purtroppo non le è servito a nulla: “mandavo costantemente i miei racconti ma nessuno ne era nemmeno lontanamente interessato”.
Ha frequentato la facoltà di giurisprudenza, a Syracuse University, perché aveva paura che altrimenti sarebbe finita per diventare una “cameriera di cinquantotto anni“, invece di una scrittrice di romanzi. Lì ha incontrato Martin che l’ha convinta a trasferirsi con lui a New York City (dove vive ancora). La Strout ha iniziato un apprendistato in uno studio legale per sei mesi: “è stato semplicemente terribile ma dopo quest’esperienza ho capito che se a cinquantotto anni sarei stata ancora una cameriera e non avessi pubblicato nulla, andava bene lo stesso perché almeno ci avevo provato“.
Quelle serate di Stand-up comedy al Comic Strip Club sono state la svolta per la sua carriera. “Ho capito quasi subito che le persone ridono di qualcosa perché è vero. Ho capito che la mia scrittura non funzionava bene perché non dicevo nulla di vero. Ho pensato, cosa mi sarebbe successo se fossi stata lì pronta a ricevere una risposta immediata da parte del pubblico? Cosa sarebbe uscito dalla mia bocca? È stato come mettermi in una pentola a pressione“.
Strout aveva intuito che il problema era, come dice il suo personaggio Lucy Barton che “non stava dicendo esattamente la verità, stava sempre lontana da qualcosa”. Strout ricorda di aver pensato: “Non sono sincera. Ma di cosa non sono sincera? Cosa posso fare per scoprirlo?” E così, a 32 anni, si iscrive a un corso di stand-up comedy. Durante l’esame finale sale sul palco e presenta per la prima volta “la sua voce”, quella di una “donna bianca molto tesa dal New England”. “Non sapevo nemmeno di esserlo fino a quando non ho iniziato a prendermi in giro. Stavo finalmente realizzando oh, questo è quello che sono!”
Quasi immediatamente inizia a scrivere il suo primo romanzo proprio su di una donna bianca del New England e nel 1998 – a quarantadue anni – Elizabeth Strout pubblica Amy e Isabelle (trad. di Martina Testa, Fazi, 2000,) la storia di una donna che vive con sua figlia in una vecchia città del Maine. In pochi anni diventa un best-seller nazionale ammirato per la costruzione dei personaggi, l’isolamento della provincia e l’emotività costantemente repressa delle protagoniste. Temi presenti anche nel successivo Abide with me, (Resta con me; trad. di Silvia Castoldi, Fazi, 2010).
 Ha 52 anni quando il suo terzo romanzo, Olive Kitteridge (trad. di Silvia Castoldi, Fazi, 2009) , vince il premio Pulitzer per la letteratura e vende in pochi anni più di un milione di copie. Nel 2014, la HBO ne ha comprato i diritti e ha prodotto una miniserie tv con Frances McDormand, Richard Jenkins e Bill Murray.
Ha 52 anni quando il suo terzo romanzo, Olive Kitteridge (trad. di Silvia Castoldi, Fazi, 2009) , vince il premio Pulitzer per la letteratura e vende in pochi anni più di un milione di copie. Nel 2014, la HBO ne ha comprato i diritti e ha prodotto una miniserie tv con Frances McDormand, Richard Jenkins e Bill Murray.
Il romanzo è costruito con una struttura in racconti – anche temporaneamente lontani tra loro – incentrati su Olive (ex insegnante di scuola), il marito Henry, il figlio Cristopher ed altri personaggi della piccola comunità, con la particolarità che in ogni racconto è comunque presente o citata la protagonista.
Olive Kitteridge non è un semplice personaggio letterario, è una delle grandi e difficili donne della letteratura americana. È schietta, inquieta, scontrosa. È irascibile, perde le staffe e – tante volte – non è capace di affrontare alcun compromesso. È una donna che fa riflettere sui limiti della tolleranza, della solitudine, delle divisioni di classe e dell’incapacità di essere null’altro che se stessi.
Dopo cinque anni l’autrice americana pubblica The Burgess Boys (I ragazzi Burgess trad. di Silvia Castoldi, Fazi, 2013) la storia dei fratelli Jim, Bob e Susan. È un romanzo sulla famiglia e i propri segreti, di rapporti con la comunità somala e di giustizia nel senso più ampio e umano del termine. Robert Redford ha appena comprato i diritti per la HBO. A differenza degli altri libri di Strout, My Name Is Lucy Barton (Mi chiamo Lucy Barton trad. di Susanna Basso, Einaudi, 2016) – il quinto romanzo – è in prima persona. Racconta della scrittrice Lucy ricoverata in ospedale a New York per alcune settimane che riceve inaspettatamente la visita della madre che non vedeva da molti anni. La protagonista continua a vivere nel libro di racconti successivo Anything Is Possible (Tutto è possibile trad. di Susanna Basso, Einaudi, 2017) che si svolge principalmente nel paese d’infanzia di Lucy Barton, dove tutti i personaggi hanno dei collegamenti con lei.
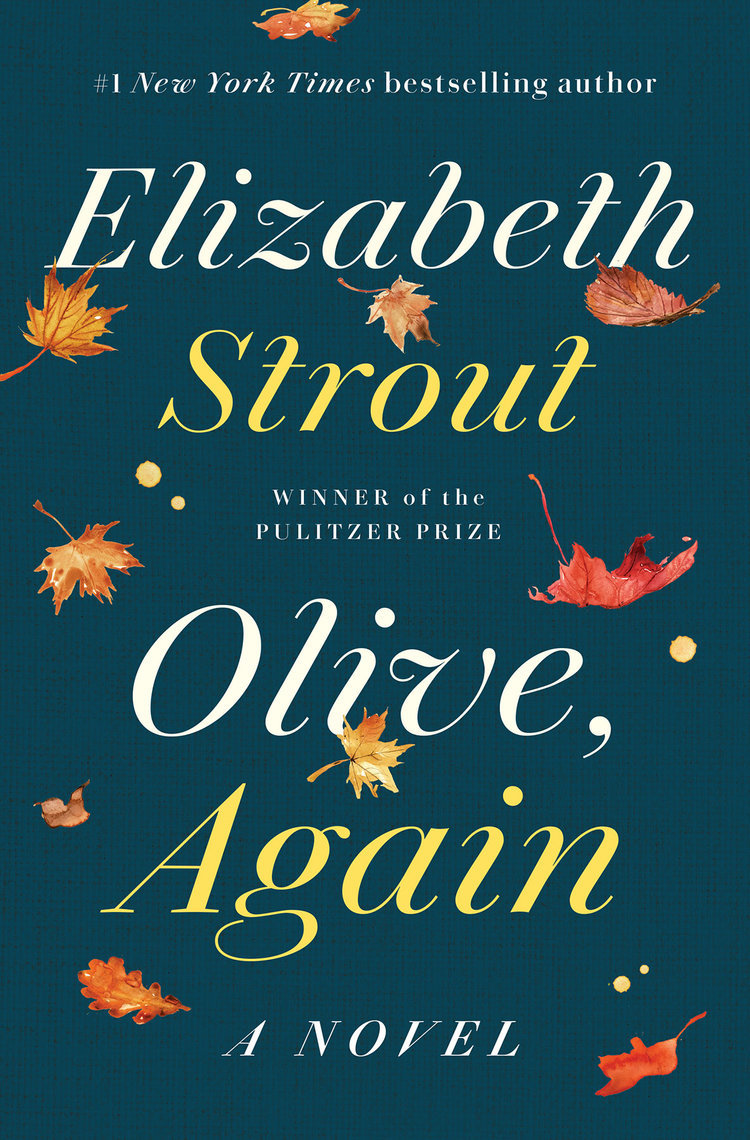 Nell’ultimo romanzo – Olive, Again (Olive ancora lei, traduzione di Susanna Basso, Einaudi, 2020) – ritorna Olive Kitteridge, che mantiene intatto il suo caratteraccio anche se questo libro racconta più le conseguenze della vecchiaia che crisi interiori.
Nell’ultimo romanzo – Olive, Again (Olive ancora lei, traduzione di Susanna Basso, Einaudi, 2020) – ritorna Olive Kitteridge, che mantiene intatto il suo caratteraccio anche se questo libro racconta più le conseguenze della vecchiaia che crisi interiori.
La Strout in questa ultima opera fa riapparire alcuni protagonisti presenti in altri precedenti romanzi: così rivediamo Jim, Bob e Susan Burgess del romanzo I fratelli Burgess e, Isabelle Goodrow di Amy e Isabelle. In un certo senso, Olive, Again diventa un sequel, non solo per Olive Kitteridge ma anche per questi altri personaggi.
Elizabeth Strout ha uno stile chiaro e introspettivo con frasi molto brevi, ricche descrizioni e un grande lavoro sulla caratterizzazione dei protagonisti che vengono descritti in ogni particolare fisico e psicologico (non è un caso che quasi tutti i suoi romanzi hanno il nome dei protagonisti). L’autrice riesce a raccontare sentimenti ed emozioni in maniera accurata toccando la loro più profonda intimità.
“Nella Stand-up comedy bisogna dire quello che stiamo pensando ma che non diremo – penso che uno scrittore di narrativa dovrebbe fare la stessa cosa“.
La vergogna, l’inquietudine e la schiettezza attraversano i romanzi della Strout come fa il miglior stand-up confessionale. La sua capacità narrativa, poi, è così dettagliata che nella lettura si riesce perfettamente a “vedere” i personaggi che descrive, a sentire le emozioni che esprimono e diventano azioni. Inoltre, tutti i romanzi dell’autrice sono caratterizzati da forti colpi di scena. In genere gli autori cercano di preparare il lettore a questi eventi lasciando indizi, creando un atmosfera di suspense, con lei no: entrano nella vicenda come entrerebbero nella vita, all’improvviso.
La storia di Elizabeth Strout è fatta di fede creativa e perseveranza. Rimane sorpresa quando gli amici la chiamano modesta, perché significa che non la conoscono davvero. Cresciuta nel Maine, “molto lontana dal nulla“, sapeva che voleva diventare una scrittrice dal momento in cui ha preso una matita in mano, dal New England e arrivata a New York “che è stata come una meravigliosa linea telefonica che ti mette in contatto con tutto, anche con te stessa”. Seguendo serate di Stand up Comedy ha capito qual’ era la sua voce e non ha mai smesso di usarla. “Se vuoi davvero essere uno scrittore, fallo e basta, bisogna scrivere, scrivere, trovare la propria voce anche nei posti più impensabili, leggere buone frasi, scrivere ancora, leggere ancora e non fermarsi mai.”












