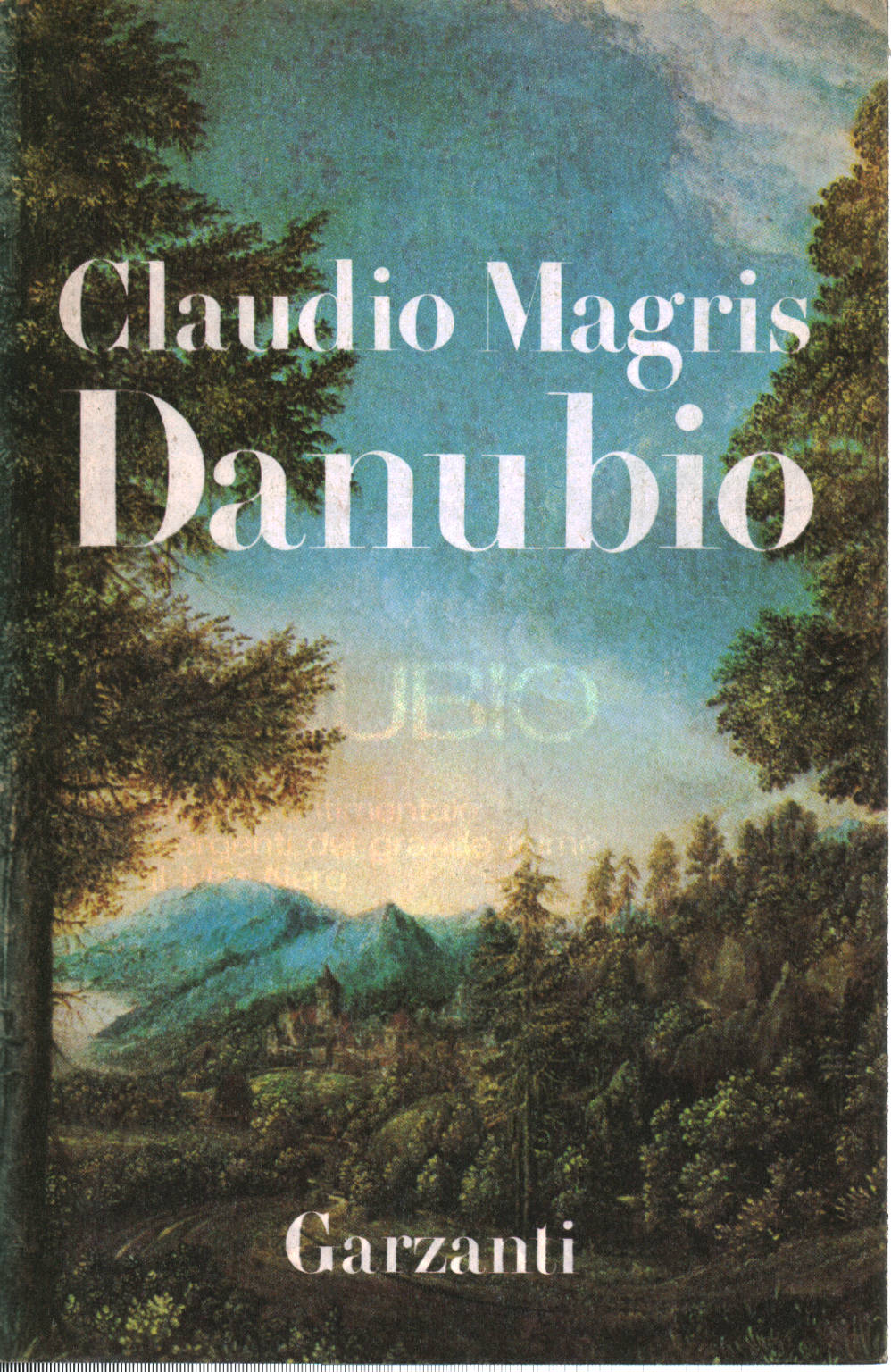 Nella copertina della prima edizione di Danubio (Garzanti, 1986), c’erano boschi, montagne, un castello sullo sfondo. Claudio Magris, triestino, uomo abituato ad avere in faccia il mare, ma alle spalle le Alpi, ci ha raccontato questa Europa. Un’Europa “di mezzo”, continentale, fluviale, fatta di pianure, catene montuose e città, non mediterranea né atlantica (anche se, almeno in parte, adriatica). L’”altra Europa”, che si allunga verso Oriente, i Carpazi e il Mar Nero.
Nella copertina della prima edizione di Danubio (Garzanti, 1986), c’erano boschi, montagne, un castello sullo sfondo. Claudio Magris, triestino, uomo abituato ad avere in faccia il mare, ma alle spalle le Alpi, ci ha raccontato questa Europa. Un’Europa “di mezzo”, continentale, fluviale, fatta di pianure, catene montuose e città, non mediterranea né atlantica (anche se, almeno in parte, adriatica). L’”altra Europa”, che si allunga verso Oriente, i Carpazi e il Mar Nero.
La si chiamava Mitteleuropa, e con questo nome, all’epoca, l’abbiamo riscoperta. L’abbiamo riscoperta poco prima della caduta del Muro di Berlino, che ha segnato la ricongiunzione di alcuni sui pezzi, rimasti dietro la Cortina di Ferro durante la Guerra Fredda, alla “casa madre”: la Cecoslovacchia, ad esempio, oggi Repubblica Ceca e Slovacchia (una separazione consensuale e non violenta, per fortuna), o l’Ungheria. L’abbiamo riscoperta inoltre subito prima della tragica caduta della ex-Jugoslavia, con una serie di guerre ferocissime protrattesi dal 1991 fino alla soglia del XXI° secolo, i cui esiti sono ancora lì, ancora visibili. Ed imprevedibili.
Prima di Danubio, opera che gli ha dato fama imperitura, Magris, che in questi giorni ha compiuto 80 anni, ci aveva già guidato alla scoperta di questa Europa dalle tante lingue e dalle tante etnie e dalle tante religioni, dai confini mobili, spesso tracciati col sangue, lontana dai grandi porti anseatici ma anche dal mondo latino (con cui peraltro ha avuto spesso a che fare). La prima pietra miliare era scaturita dalla sua tesi di laurea, un volume dalla copertina severa, Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna, che ci aveva fatto, di nuovo, scoprire o riscoprire, autori come – permettete che lo citi per primo – Roth (Joseph, il cantore della caduta dell’Impero asburgico, quello che partì socialista per la Russia dopo lo scoppio della Rivoluzione e ritornò monarchico), o come Schnitzler, come Hofmansthal, Rilke, Kraus Musil, Canetti, e tanti altri. Fra cui gli italiani, naturalmente, a partire dai suoi concittadini, Svevo Saba, che disse di avere apprezzato più compiutamente dopo aver lasciato Trieste per proseguire gli studi a Torino (a volte bisogna mettere distanza fra sé e le proprie radici, per capirle meglio, per non esserne strangolati).
Mondo tedesco e mondo slavo, dunque, Tolstoj e Kafka i suoi numi tutelari. Ma anche Italia, perché il Friuli, così come il Trentino, già sudditi della corona asburgica, erano/sono parte del Belpaese, pur con le loro anomalie, o forse proprio per questo, perché ci ricordano che di Italia non ce n’è una sola, ce ne sono tante, ognuna con le sue specificità.
Magris non ha mai pianto sul passato. Non a caso parlava di “mito”, ben consapevole dell’ambivalenza delle nostalgie, della facilità con cui possono essere manipolate, strumentalizzate. Mai indulgente nei confronti dei nazionalismi di ritorno, dei deliri identitari che incendiarono i Balcani e fecero tornare in Europa la pulizia etnica e i campi di concentramento, e questo per me rimane uno dei suoi insegnamenti più importanti, forse il più importante. Capace però anche di smitizzare l’insofferenza “di ritorno” nei confronti delle patrie grandi o piccole, ad esempio quando, a proposito dlela letteratura sudtirolese, parlò di “atteggiamenti letterari che in un contesto culturale diverso sarebbero puberali o patetici, in Alto Adige hanno ancora un valore contestativo”.
Magris, nei suoi libri così come nella sua attività pubblicistica, alimentata da una curiosità vivissima, da una continua attenzione ai fatti, anche alla cronaca, è stato e rimane un grande intellettuale liberale e progressista. Potendo definirlo per negazione, lo direi oggi un anti-Céline o un anti-Houellebecq, ovvero un nemico di tutte quelle visioni della storia, in particolare della storia europea, di stampo apocalittico, e quindi latamente reazionarie (pur così affascinanti e così feconde sul piano letterario).
Un aneddoto riguardo proprio al suo compleanno, che ricorre il 10 di aprile, lo può raccontare bene (lo riprendo dal Corriere della Sera, articolo di Cristina Taglietti). “Chiesi a mio padre di poterlo festeggiare il 9. Lui mi rispose: se proprio vuoi, ma posso sapere perché? E io: perché il 9 aprile 1863, ad Appomattox, in Virginia, Abramo Lincoln ha dichiarato liberi gli schiavi neri”.
Magris è stato anche per un breve periodo un parlamentare (esperienza che a differenza di altri intellettuali prestati alla politica non ha rinnegato), e un viaggiatore, e qui forse pesa l’amore giovanile per Salgari. Non un romanziere puro, pur avendo scritto romanzi e anche per il teatro, ma, al pari del croato Predrag Matvejevic, un altro intellettuale di area mitteleuropea, autore capace di piegare il rigore accademico e l’ampiezza dell’erudizione alle esigenze della narrazione, quindi di mescolare storia, riflessioni, aneddoti, vicende personali o comunque “reali”.
La sua ultima opera, una raccolta di racconti: Tempo curvo a Krems (Garzanti, 2018). Lunga vita a Claudio Magris.












